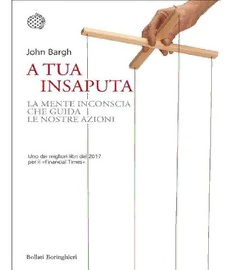Table Of ContentL’autore
John Bargh è uno psicologo sociale e viene considerato uno dei
principali esperti mondiali del pensiero inconscio. Ha al suo attivo oltre 190
pubblicazioni specialistiche. Nel 2006 ha vinto il Donald T. Campbell Award
for Distinguished Career in Social Psychology e nel 2014 il Distinguished
Scientific Contribution Award della American Psychological Association. È
attualmente docente di Psicologia a Yale, dove dirige anche il laboratorio
ACME (Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation). A tua
insaputa è il suo primo libro per il grande pubblico.
www.bollatiboringhieri.it
www.facebook.com/bollatiboringhieri
www.illibraio.it
© 2017 John Bargh
Titolo originale
Before You Know It: The Unconscious Reasons We Do What We Do
© 2018 Bollati Boringhieri editore
Torino, corso Vittorio Emanuele II, 86
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
ISBN 978-88-339-3149-4
Illustrazione di copertina: Marionette Control Bar © macida / Getty Images
Prima edizione digitale giugno 2018
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata
Indice
A tua insaputa
Introduzione. Un salto indietro nel tempo
Sapere di non sapere
Le tre dimensioni temporali
Il nuovo inconscio
Parte prima. Il passato nascosto
1. Il passato è sempre presente
Dov’è il mio pulsante?
L’alligatore dell’inconscio
Il genio della lampada
Di germi e presidenti
Condivisione e collaborazione
Il gene egoista
2. Nel consorzio delle umane genti
Scimmie, calore e attaccamento
Buoni o cattivi: il ruolo della cultura
3. «Priming» time
Comunisti e protestanti
Costi e benefici
Fuori dal tunnel
4. Dissolvenze incrociate
I morti viventi!
Motociclette ed errori di attribuzione
Cambiamenti «climatici»
Tripla corona, rabbia triplicata
Un cumulo di emozioni
Parte seconda. Il presente nascosto
5. Restare o andarsene?
Tira la leva, spingi la leva
Che cosa c’è in un nome?
Gatti imbronciati e politici competenti
Tribù contro tribù
6. Quando ci si può fidare dell’istinto?
Quando fidarsi dell’istinto: regole 1-4
Quando fidarsi dell’istinto: regole 5-7
Quando fidarsi dell’istinto: regola n. 8
7. Camaleonti a due zampe
L’effetto camaleonte
Comportamenti contagiosi
Finestre rotte e aggiornamenti di stato
Parte terza. Il futuro nascosto
8. Attenti ai desideri
Attraverso le lenti «deformanti» dell’obiettivo
Amici, mamme, camerieri e cronisti di nera
Strategie di autoinganno
Un pericoloso afrodisiaco
9. L’inconscio non dorme mai
Rivelazioni nella vasca da bagno
Fate come Mike
Notti agitate
10. Il controllo della mente
Propositi da mettere in atto
Conclusioni. Siete voi il
DJ
Ringraziamenti
Note
Introduzione. Un salto indietro nel tempo
1. Il passato è sempre presente
2. Nel consorzio delle umane genti
3. «Priming» time
4. Dissolvenze incrociate
5. Restare o andarsene?
6. Quando ci si può fidare dell’istinto?
7. Camaleonti a due zampe
8. Attenti ai desideri
9. L’inconscio non dorme mai
10. Il controllo della mente
Conclusioni. Sei tu il DJ
Bibliografia
Indice dei nomi
A tua insaputa
A Danielle, la mia supereroina
Introduzione
Un salto indietro nel tempo
La distinzione tra presente, passato e futuro è – per quanto ostinata – solo un’illusione.
Albert Einstein
Al college mi sono specializzato in psicologia e, come materia
complementare, in Led Zeppelin. O forse il contrario.
Si era alla metà degli anni settanta e studiavo alla University of Illinois, a
Urbana, Champaign. Quando non ero impegnato nel laboratorio di ricerca del
Dipartimento di Psicologia, bazzicavo nella radio studentesca, WPGU, dove
facevo il DJ notturno. Per mettere dischi non basta solo la tecnica, e questo era
vero soprattutto nell’era predigitale, al tempo dei vinili. È un’arte che
richiede sia intuito, sia perizia, e ci vollero diversi incidenti in diretta prima di
sentirmi finalmente a mio agio nella postazione insonorizzata con finestra
nello studio radiofonico. Per inserire bene una nuova canzone bisogna
combinarne il ritmo e l’accordo musicale con quella che sta sfumando. Come
due persone che si incontrano sulla soglia di un ristorante mentre l’una esce e
l’altra arriva, le due canzoni si sovrappongono per qualche secondo e questo
genera un gradevole senso di fluidità. Una delle cose che più amavo dei Led
Zeppelin erano i lunghi finali dei loro brani, che mi stimolavano a una
maggiore creatività nell’ideare le transizioni da un pezzo all’altro. Mentre
Ramble On sfumava con il «Mah baby, mah baby mah baby» di Robert Plant
sempre più distante, vi sovrapponevo l’intro di tuoni e pioggia di Riders on
the Storm dei Doors.
Ero un ragazzo del Midwest che stava appena cominciando a capire cosa
voleva fare della propria vita e fui attratto dalla psicologia perché prometteva
un futuro di spiegazioni: perché gli umani si comportano come si
comportano, sia nel bene che nel male; quali sono le componenti della nostra
mente che determinano i nostri pensieri e le nostre emozioni; e poi la cosa
che mi intrigava più di tutte: come utilizzare questo pozzo di conoscenze
sempre più profondo per dare una forma diversa a noi stessi e al nostro
mondo. Il motivo della mia ossessione per la musica era invece l’opposto: la
musica sfuggiva a qualsiasi spiegazione. Perché mi piacevano certi gruppi?
Perché alcuni brani mi facevano rizzare i peli sulle braccia o mi facevano
ballare – mio malgrado – mentre altri mi lasciavano totalmente indifferente?
Perché la musica aveva un effetto così potente sulle mie emozioni? Essa
parlava a qualche recesso segreto di me stesso che non comprendevo, ma che
evidentemente esisteva ed era importante. Nel 1978, dopo essermi trasferito
ad Ann Arbor, in Michigan, per il dottorato, fui convocato dal mio tutor
Robert Zajonc nel suo ufficio. Zajonc mi mostrò due cartoline raffiguranti
quadri di arte moderna e mi chiese quale preferissi. Fece la stessa cosa con
altre quattro o cinque coppie di quadri. Ogni volta sapevo subito qual era
quello che mi piaceva di più, ma quando si trattava di spiegare perché non
trovavo le parole.
Vedendomi in difficoltà, Bob sorrise e commentò: «Esatto».
Gli psicologi avevano intuito l’esistenza di meccanismi nascosti,
sottostanti, che guidano o addirittura generano i nostri pensieri e le nostre
azioni,1 ma stavamo appena iniziando a capire quali fossero e come
funzionassero. In altri termini, non si conosceva ancora una componente
importante di ciò che ci rende quello che siamo, anche se da essa deriva un
aspetto fondamentale della nostra esperienza.
Più o meno nello stesso periodo, la fine degli anni settanta, un uomo di
nome Michael Gazzaniga stava girando il New England a bordo di un camper
GMC di otto metri.2 Gazzaniga, uno dei padri delle moderne neuroscienze, non
stava solo facendo un viaggio di piacere. Lo scopo dei suoi viaggi era visitare
dei pazienti split brain, individui sottoposti a resezione del corpo calloso (la
fascia di fibre che collega gli emisferi cerebrali) allo scopo di ridurre i loro
attacchi epilettici. Gazzaniga sperava così di scoprire qualcosa di nuovo
riguardo i meccanismi di interazione tra le diverse regioni del cervello.
Parcheggiava il suo camper e faceva sedere il paziente di fronte a un
videoterminale in grado di fornire stimoli al suo emisfero cerebrale destro e
altre informazioni, diverse, al sinistro. Generalmente, il paziente non si
rendeva conto di ciò che veniva presentato al lato destro del suo cervello, ma
solo di quello che veniva presentato al lato sinistro.
C’erano studi in cui i ricercatori presentavano comandi visivi, per
esempio «cammina», all’emisfero cerebrale destro, e subito il paziente