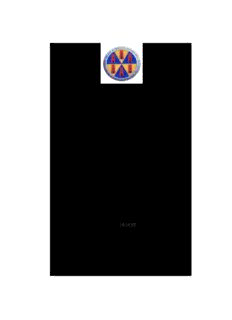Table Of ContentUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA
FORMAZIONE
DOTTORATO DI RICERCA IN RELAZIONI E PROCESSI
INTERCULTURALI
CICLO XXV
TITOLO ELABORATO:
FRA NORMALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE
Soggetto, corpi, anarchia
SPS/01 – FILOSOFIA POLITICA
CANDIDATO:
PAOLO BIONDI
(MAT. 141435)
Coordinatore del Dottorato
Chiar.mo Prof. Fabio Ferrucci
Tutor
Chiar.mo Prof. Flavia Monceri
INDICE
INTRODUZIONE 3
CAPITOLO 1. Normalizzazione e individualizzazione 15
1.1 La ‘dialettica’ normalizzazione/individualizzazione 15
1.2 Normalizzazione e individualizzazione in Émile Durkheim
e Georg Simmel 26
1.3 L’ordine sociale fra individuo e norma 39
1.4 Ordine, controllo e anarchia 57
CAPITOLO 2. Dal soggetto ai corpi 74
2.1 Equilibrio, limitazione e anarchia 74
2.2 Post-strutturalismo e critica del soggetto 99
2.3 Soggettività e corpo in Michel Foucault 125
CAPITOLO 3. Corpi, rappresentazioni e azione politica 144
3.1 Soggetto e corpo nel pensiero femminista 144
3.2 Dal corpo ai corpi: Judith Butler 170
3.3 Intermezzo: la rappresentazione dei corpi maschili 187
3.4 Il soggetto dell’azione politica nel post-anarchismo 209
BIBLIOGRAFIA 238
RINGRAZIAMENTI 250
2
INTRODUZIONE
Questo lavoro nasce dall’insoddisfazione nei confronti di una
particolare visione della contemporaneità che la vede segnata da un
problema piuttosto banale, almeno nel senso che esso si ritrova nella
maggior parte dei tentativi delle scienze sociali di descriverla e
comprenderla. I termini che probabilmente più di altri hanno la capacità di
evocare questo problema sono quelli di ‘post-moderno’ o di ‘post-
modernità’, che intendono indicare un momento storico, una società e una
cultura che presentano i caratteri di una rarefazione, se non di una
dissoluzione, delle tradizionali istituzioni moderne, la quale si è manifestata
nel modo più evidente con l’emergere del fenomeno della globalizzazione.
I toni attraverso cui la post-modernità e la globalizzazione vengono
descritte sono più o meno gli stessi e le analisi che le ricostruiscono
sembrano sottolineare una loro natura paradossale: se, da un lato, esse
sembrano divenire il simbolo di un aumento pressoché indefinito delle
possibilità di espressione del singolo, della moltiplicazione dei punti di
contatto e contaminazione tra individui e culture, della distruzione di
barriere che sino a non più di vent’anni fa apparivano insormontabili,
dall’altro, instabilità, incertezza, conflitto, disagio individuale e collettivo,
isolamento, appaiono come l’altra faccia della medaglia di una dimensione
umana che sta perdendo qualunque riferimento stabile.
In altre parole, sembra che sia impossibile descrivere o trattare la
contemporaneità senza in qualche misura avanzare un’interpretazione di
questo paradosso e, di conseguenza, ciò che appare come un passaggio
obbligato per qualunque prospettiva disciplinare che se ne occupi è la
definizione di una chiave di lettura che permetta più o meno di orientarsi al
suo interno. Per comprendere appieno la post-modernità, sembrano in
generale affermare le scienze sociali, occorre osservare i processi che la
caratterizzano come un unicum storico, quali la sempre crescente mobilità e
3
precarietà del lavoro, l’espandersi della società dei consumi, il cristallizzarsi
di grandi concentrazioni di capitale grazie alla costituzione di un mercato
planetario e la penetrazione della logica spregiudicata della finanza globale
all’interno delle istituzioni degli stati democratici, nate proprio per difendere
i cittadini dagli effetti perversi della concentrazione del potere.
Dietro la moltiplicazione delle possibilità di espressione individuale,
dietro la disgregazione delle istituzioni tradizionali come ad esempio la
famiglia e gli stati nazionali e dietro l’apparente incremento senza
precedenti della libertà individuale, le scienze sociali scorgono un processo
di omologazione forzata che si concretizza in una sorta d’ingiunzione al
rifiuto della tradizione fondato sul progressivo venir meno di qualsiasi
impulso solidaristico, la cui conseguenza più evidente e pericolosa è la
divaricazione del corpo sociale in gruppi ristretti di ricchi e potenti e masse
sempre più subordinate e escluse. Se questo processo di divaricazione, a
livello micro, si alimenta attraverso l’illusione di un successo facile che la
nuova società globale sembra porre miracolosamente alla portata del
singolo, esso sembra altrettanto connesso, a livello macro, con la crisi delle
democrazie occidentali, le quali non sembrano essere più in grado di
difendere il bene comune e piuttosto sono ormai uno degli agenti principali
che mettono in discussione la stessa idea di comunità.
L’esito più importante del tentativo di comprendere la post-
modernità a partire dall’osservazione dei suoi processi sociali specifici,
dunque, sembra essere quello di chiarire la misura in cui essa risulti in una
sorta di corsa suicida della società occidentale e di portare alla luce come da
questa contorta e autodistruttiva dinamica sociale scaturisca un problema
politico: quello dell’attuale inefficacia istituzionale nel preservare la
comunità dall’ingerenza di un progresso anti-comunitario, che non possiede
più alcun volto umano. Ciò, allo stesso tempo, permette d’individuare
proprio nella politica un possibile strumento d’intervento e di definire
questo intervento come ispirato e teso a una sorta di ricomposizione delle
innumerevoli divaricazioni aperte dalla globalizzazione nel corpo sociale
4
come quelle tra ricchi e poveri, tra globale e locale, tra stato e società civile
attraverso uno sforzo di sintesi, d’ibridazione, di contaminazione e che sia
tale da riscoprire la radice solidaristica delle istituzioni.
Coloro che si trovano in una posizione di potere, sembra suggerire
tale lettura, non devono ostacolare le soluzioni ai paradossi della post-
modernità che provengono ‘dal basso’, cioè lontano dai centri di potere,
perché è proprio lì che la solidarietà riemerge con più forza come norma
sociale fondamentale, negata invece dalle disumanizzanti logiche della
globalizzazione. Ne consegue, ancora per questa lettura, che appare
necessaria una sorta di ‘rifondazione morale’ della società che non può che
essere ottenuta attraverso la sola rifondazione delle istituzioni politiche alla
luce dell’ideale solidaristico.
Come si diceva all’inizio, questo lavoro nasce dall’insoddisfazione
verso visioni di questo tipo. Anzi, potremmo dire, esso intende proprio
sostenere che un’impostazione del paradosso post-moderno che culmini
nell’affermazione secondo cui una soluzione alla corsa suicida della società
occidentale possa provenire solo ‘dal basso’ tende a promuovere un tipo di
cambiamento che non coincide con la messa in discussione di asimmetrie e
disuguaglianze fondamentali delle moderne democrazie occidentali, quanto
piuttosto con una loro riproduzione acritica, perché la stessa distinzione tra
un ‘alto’ e un ‘basso’ sembra istituire, a sua volta, una nuova distinzione che
colloca in maniera esclusiva la fonte del cambiamento in un luogo che si
presume immune dalle logiche perverse del potere.
L’argomentazione di questa affermazione, che potrebbe essere
individuata come la linea guida di tutto il presente lavoro, sarà condotta da
un punto di vista teorico, in quanto sembra che sia proprio a livello teorico
che la riproduzione di asimmetrie e distinzioni avviene nella misura più
rilevante. Ciò, tuttavia, non significa cercare di riaffermare
anacronisticamente il primato indiscusso della teoria nei confronti della
pratica; piuttosto, s’intende sostenere che l’atto teorico non può sottrarsi a
condizionamenti che sono di natura storica, sociale, culturale che lo
5
qualificano già come un’attività pratica, in quanto sono proprio tali
condizionamenti a incidere inevitabilmente sulla riflessione teorica e sui
suoi risultati e, verrebbe da dire, in misura tanto più rilevante quanto più essi
sono negati.
Ad esempio, ciò sembra evidente se si considera che la linea di
pensiero che analizza la post-modernità a partire dall’individuazione di un
nesso causale e necessario che fa derivare il problema politico dai processi
sociali, produce una sorta di ‘effetto di verità’ tale da apparire difficilmente
contestabile. Una teoria che affermi che le dinamiche sociali determinano la
modificazione delle istituzioni politiche, di modo che si può pensare a una
relazione ottimale tra queste due dimensioni che assuma la forma di un
adeguamento della prima alla seconda, appare probabilmente come una
verità autoevidente. Tuttavia, tale verità si dimostra, al contrario, piuttosto
discutibile e non solo perché quello della formazione delle istituzioni
politiche è un tema che le scienze sociali non riusciranno probabilmente mai
a sviscerare del tutto, ma anche e soprattutto perché non è possibile
dimostrare l’esistenza di un gruppo umano da cui la negoziazione di
posizioni di potere e il problema della risoluzione del conflitto (ovvero, la
dimensione politica) siano assenti. In altre parole, non è possibile dimostrare
l’esistenza di un gruppo che sia esclusivamente sociale, non-politico o pre-
politico, e che divenga politico da un certo momento in poi della propria
storia.
Di conseguenza, dato che quella tra sfera politica e sfera sociale si
presenta come una semplice distinzione analitica, stabilire una relazione
causale che derivi la prima dalla seconda non è un dato di fatto, quanto
piuttosto il frutto di un’opzione teorica che si colloca entro un preciso
insieme di assunti e presupposti più generali. Sottolineare l’esistenza di un
contesto più generale nel quale s’inserisce una certa teoria non significa,
tuttavia, affermare che questo contesto coincida con, o sia definito dai
confini tradizionali che separano le discipline, ad esempio la sociologia e la
scienza politica. Al contrario, significa porre in rilievo l’esistenza di
6
questioni precedenti e trasversali a quelle dell’appartenenza di un certo
oggetto di studio o di una certa prospettiva a un campo disciplinare o
all’altro, che attraversano l’intero insieme delle scienze sociali. Tuttavia, a
tali questioni fondamentali, come ad esempio quelle della definizione della
natura umana, della natura delle istituzioni e del presupposto dell’esistenza
di un legame sociale, non è possibile dare una risposta scientificamente
definitiva: di conseguenza, il loro emergere e la loro rilevanza obbligano a
prendere una posizione.
Una gran parte degli esiti di una qualsiasi teoria deriva dall’insieme
di queste prese di posizione – che includono anche ‘riferimenti al valore’ –
senza che esista la possibilità di correggerle e rivederle, dato che la scienza
non può garantire una verità definitiva su di esse. Per tale motivo,
rintracciare i presupposti fondamentali all’interno di una teoria non è
un’attività finalizzata alla correzione o al miglioramento di quella teoria: un
presupposto sulla natura umana, ad esempio, non può che essere sostituito
da un altro presupposto. Tuttavia, è un’attività che permette di spiegare una
teoria in misura rilevante come la conseguenza dell’adozione di un certo
insieme di presupposti, piuttosto che come conseguenza della sola
osservazione della realtà che possa essere valutata in base alla sua maggiore
o minore approssimazione all’oggettività. In questo senso, s’intende qui
sostenere che descrivere la post-modernità a partire dalla definizione dei
tratti peculiari della sua realtà sociale, attraverso una relazione di
derivazione della sfera politica da quella sociale, nonché intendere la sfida
della contemporaneità come quella di una rifondazione delle istituzioni
democratiche alla luce di una fondamentale norma solidaristica, appaiono
come l’esito di un percorso di scelte tra opzioni teoriche che può essere
ricostruito e il cui primo presupposto sembra essere proprio quello di
considerare la sfera sociale come il precedente logico di quella politica.
Se, infatti, proviamo a descrivere il paradosso della post-modernità a
partire dal problema politico, il risultato pare essere un’impostazione del
tutto diversa. Quel che ne emerge non è una crisi di efficacia delle
7
istituzioni democratiche nel senso che esse non riuscirebbero più a garantire
la salvaguardia del bene comune. Piuttosto, la compresenza
dell’ampliamento delle possibilità espressive del singolo con quella di
ingiunzioni all’omologazione sempre più pressanti può essere descritta
come l’incapacità delle istituzioni contemporanee di garantire
effettivamente l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nonostante la
proclamazione formale di tale uguaglianza. In tal senso, si può parlare di
una crisi di legittimità delle istituzioni democratiche, in quanto
l’ingiunzione all’omologazione, ovvero l’adeguamento forzato del singolo a
una serie di parametri, declinati in senso esistenziale, sociale e culturale,
diviene condizione necessaria dell’accesso a un gruppo di uguali a cui è
pienamente riconosciuto il diritto alla libertà di espressione individuale.
Tuttavia, lungi dal qualificarsi come la caratteristica tipica della post-
modernità, il problema della legittimità ha accompagnato la democrazia
moderna sin dalla prima formulazione illuminista dei suoi assunti di base.
Esso, infatti, fu rilevato da quegli orientamenti critici che mettevano in
risalto la problematicità di ergere a principio fondamentale della vita
associata l’ideale di uguaglianza, proprio perché ciò implicava
l’affermazione di uno standard normativo che di fatto limitava la
partecipazione alla vita pubblica solo ad alcuni gruppi sociali, il che in
definitiva significa solo ad alcuni individui.
Affermare l’uguaglianza di tutti, in altre parole, significa anche
stabilire dei criteri in base ai quali tale uguaglianza può essere rilevata e,
quindi, significa stabilire delle differenze. La differenza di censo, ad
esempio, ha da subito assunto un significato politico in quanto è stata subito
individuata come un fattore critico in grado di condensare una serie di effetti
collaterali di tipo sociale e culturale che definivano una condizione di
esistenza in qualche modo resistente all’equalizzazione. Tuttavia, la
disuguaglianza economica sembrava, rispetto ad altre, più passibile di essere
riassorbita proprio dal tentativo illuminista di porre la tensione all’ideale
egualitario come nuovo fondamento della vita associata. È probabilmente
8
corretto individuare almeno due ulteriori orientamenti critici nei confronti
dell’ideale di uguaglianza che producono argomentazioni sostanzialmente
diverse da quelle costruite sul censo, proprio perché risultano in qualche
modo resistenti a essere superate individuando nell’uguaglianza il fine
ultimo di una comunità politica illuminata. Il primo, ossia il pensiero
femminista può essere considerato, in questa chiave, come un orientamento
critico che mette in risalto la persistenza sostanziale di discriminazioni
legate alla conformazione fisica, nonostante in linea di principio si sancisca
l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge in virtù della comune appartenenza
alla specie umana. Il secondo, più immediatamente politico, è il pensiero
anarchico, che è stato probabilmente la linea di riflessione politica che più di
altre ha impostato la propria critica alla democrazia muovendo dal tentativo
di leggere la tensione verso l’uguaglianza come la manifestazione di un
potere che non libera l’individuo dalle costrizioni pre-moderne, ma lo rende
schiavo in maniera ancora più profonda.
Insomma, il problema che la post-modernità ripropone dal punto di
vista politico non è tanto quello dell’inefficacia delle istituzioni
democratiche, dato che tale inefficacia risulta evidente sin dal loro
emergere. Piuttosto, si tratta d’intendere come problema il fatto che le
istituzioni democratiche moderne si siano conservate sino ai giorni nostri,
riuscendo a mantenere sostanzialmente inalterata la tensione verso
un’uguaglianza che ancora non riescono effettivamente a garantire. Le
possibili risposte a questa questione sembrano essere sostanzialmente due.
La prima consiste nell’affermare che le istituzioni democratiche riescono,
seppure in maniera parziale e perfettibile, a rappresentare effettive e naturali
istanze dell’essere umano, e siano, di conseguenza, l’espressione di un
istinto alla solidarietà e alla cooperazione in qualche modo presente
nell’essere umano. La seconda, su cui sembrano convergere le critiche
provenienti dal femminismo e dall’anarchismo, consiste nell’affermare che
la loro tenuta sia il risultato dell’esercizio di un potere che necessariamente
divide e discrimina proprio per costruire l’uguaglianza. Si può affermare che
9
una risposta definitiva a questa questione teorica non sia ancora stata
prodotta. Di conseguenza, questo lavoro intende mettere in luce che
sostenere una tesi o l’altra implica l’accettazione di alcuni presupposti e il
rifiuto di altri.
Nel primo capitolo, si cerca di evidenziare come i concetti di
normalizzazione e individualizzazione, e il riconoscimento di una tensione
tra di loro, rimandino a questo problema politico. Descrivere la realtà
sociale nei termini di processi sociali divergenti che producono da un lato
l’omologazione e, dall’altro, l’esaltazione dell’individualità appare una
possibilità teorica che si apre a partire dall’illuminismo e risulta, quindi,
connessa con l’affermazione dell’indipendenza della sfera umana da quella
divina che, a sua volta, obbliga a spiegare la variabilità dell’umano, sia nei
termini di differenze tra i singoli che in quelli di differenze di tipo storico e
geografico tra diversi gruppi umani, come frutto di dinamiche interne alla
stessa dimensione umana. L’Illuminismo, in altre parole, sancisce il
riconoscimento della plasticità della natura umana, della sua capacità di
cambiamento al variare delle condizioni storiche, sociali e culturali, in
contrapposizione a una concezione statica della natura umana, secondo cui
essa sarebbe identica a se stessa nel tempo e nello spazio.
L’idea della plasticità della natura umana, si sostiene, appare come il
presupposto fondamentale che determina la stessa idea secondo cui è
possibile elaborare una teoria politica a partire dalla definizione delle
condizioni di un cambiamento orientato all’uguaglianza. Tale presupposto
appare anche come quello che legittima l’indagine scientifica della società
che, appunto, si palesa sin dai suoi inizi come indagine sulle condizioni
storiche e sociali del cambiamento politico. È probabilmente la sociologia
che si è fatta carico di questo compito più di altre discipline. Ed è proprio
all’interno del pensiero sociologico, sin dalle sue prime formulazioni, che è
possibile rintracciare due distinti problemi dell’indagine sociale, quello
dell’ordine e quello del controllo.
Il primo appare evidente in quelle analisi che muovono dalla
10
Description:Anarchism. A history of libertarian ideas and movements, Meridian Book, Cleveland;. D. Guerin, (1969) L'anarchismo dalla dottrina all'azione, Samonà e Savelli, Roma; J. Joll (1970), Gli anarchici, Il Saggiatore, Milano; A. Carter (1971), The political theory of anarchism, Routledge, Londra e New Y