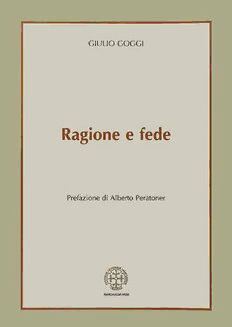Table Of ContentUOMO-POLIS-ECONOMIA
6
COLLANA DIRETTA
DAL PROF. ARTURO CATTANEO
GIULIO GOGGI
Ragione e fede
Studio sul rapporto
tra la ragione epistemica
e l’esperienza credente
Prefazione di Alberto Peratoner
Il Progetto Triennale di Formazione e Ricerca Uomo-Polis-Economia
è promosso dallo Studium Generale Marcianum
e dalla Fondazione di Venezia.
© Marcianum Press s.r.l., Venezia 2009.
ISBN 978-88-89736-63-0
AL LETTORE
Finora la collana Uomo – Polis – Economiaha raccolto lo statement
del Progetto (Uomo-Polis-Economia) e le lezioni e corsi dei Visiting
Professors negli anni accademici 2006-2007 (Al cuore dell’umano. La
domanda antropologica 1 e Sentieri dell’umano. La domanda antropo-
logica 2) e 2007-2008 (Sul buon governoe Ripensare il bene comune).
Con il presente volume inizia la pubblicazione dei primi risultati
dei percorsi di ricerca a cura dei singoli ricercatori e giovani docenti
coinvolti nel Progetto Triennale di Formazione e Ricerca Uomo – Polis
– Economia dello Studium Generale Marcianumin collaborazione con
la Fondazione di Venezia.
PREFAZIONE
Alberto Peratoner
Fides quaerens intellectum. Così il pensiero cristiano ha per secoli
concepito il rapporto tra ragione e fede: la fede incentrata in Cristo Gesù
che, nel presentarsi con il suo contenuto inaudito – il novum, l’ecce-
dente, l’essere costitutivamente ¢’·ÁÁ¤ÏÈÔÓ oltre la stessa gittata
dell’immaginazione umana – nondimeno non si astiene dal rivolgersi
alla ragione, non si trattiene da un quaerereche è un chiedere e cerca-
re, interrogare e interpellare, un sollecitarel’intelletto ad una qualche
risposta, ad un’integrazione prospettica che consolidi quanto acquisito
rilevandone la tenuta di senso anche nella luce di una riflessione critica
condotta nel rispetto delle esigenze del logose delle sue pertinenze.
La nota espressione risale a sant’Anselmo d’Aosta, ma reinterpreta
una ben più antica tradizione, giacché, alla sua comparsa nel Proslogion
– essa ne sarebbe stata addirittura il titolo originario1 –, sembra riecheg-
giare le parole del De Trinitatedi sant’Agostino, laddove questi afferma
che «fides quaerit, intellectus invenit»2. A ciò l’Ipponense aggiungeva
che a sua volta l’intelletto quaerit, in rapporto a quanto percorso: et rur-
sus intellectus eum quem invenit adhuc quaerit. L’espressione anselmia-
na passerà allora alla storia seguita dalla reciproca: Intellectus quaerens
fidem, a significare che a sua volta la ragione sollecita la fede a porger-
si all’indagine razionale e delle scienze, a fornire contenuti per sostan-
ziare la ricerca, offrire elementi, indicare direzioni percorribili. Tale rap-
porto di reciprocità, o di circolarità, trova una delle più ferme asserzio-
ni in Antonio Rosmini, con il riconoscimento alla ragione di un ruolo
imprescindibile, come di ciò che precede, accompagna, e segue la fede:
«l’intelligenza nell’uomo cattolico precede, accompagna, e sussegue la
fede, dimanieraché la fede cattolica non va giammai scompagnata dalla
luce dell’intelligenza, quando, se più addentro è dato di penetrare, la
fede stessa è una parte, la parte migliore di questa luce»3.
1Cfr. ANSELMO, Proslogion, Prooemium.
2AGOSTINO, De Trinitate, XV, 2, 2.
3A. ROSMINI, Introduzione alla Filosofia - Degli studi dell’autore, II, I, 30, Città Nuova, Ro-
ma 1979, p. 61.
8 RAGIONE E FEDE
Il presente studio di Giulio Goggi assume il primo lato di questa cir-
colarità, ponendosi dalla prospettiva della ragione che, sollecitata dalla
fede, è chiamata a percorrere, iuxta propria principia, i sentieri della
verità, rapportandosi a quanto proposto dalla Rivelazione, sin là dove
può inoltrarsi.
La prospettiva assunta si dà però un’ulteriore restrizione: l’indagine
è infatti condotta quanto alla pura ragione epistemica, cioè a quel sape-
re capace di costituirsi come scienza (epistéme), a quel sapere dell’in-
controvertibile che pone l’oggetto nella massima trasparenza dell’evi-
denza del logos.
L’esperimento è rilevante, poiché, con la suddetta restrizione, l’au-
tore concentra l’analisi sulla relazione di ragionee fedequanto all’evi-
denza assolutadell’apparireche solo nella ragione epistemica si pre-
senta all’intelletto.
Va pur detto che non è qui in questione la semplice esistenza di Dio
come Assoluto o Fondamento ultimo dell’essere, acquisibile quale veri-
tà di ragione nella sua forma epistemica, ma il dato centrale e fondante
della fede cristiana, ovvero che Gesù Cristo, persona concreta il cui
evento storicoè stato trasmesso da testimoni oculari e fissato nei Vange-
li, sia Dio.
In questa prospettiva viene alla luce una certa discontinuità, e non
tra fede e ragionetout court, ma tra la datità di quanto rappresenta i con-
tenuti di fede – fides quae creditur– e la pura ragione epistemica, il cui
carattere incontrovertibile, insieme alla luminosità dell’apparire dei pro-
pri guadagni speculativi, renderebbe la fede un atto di semplice ammis-
sione di un’evidenza incontestabile.
Va qui pure precisato che la discontinuitàrilevata non sussiste a
titolo di opposizione dei guadagni speculativi della ragione epistemica
alla menzionata datità del depositum fidei, ma di un collocarsi di questi
oltre quanto è ad essa disponibile. La discontinuità vale qui dunque
come ulteriorità, non come incompossibilitàrispetto a quanto appare al-
la ragione secondo la nota dell’incontrovertibilità. È precisamente quan-
to troviamo espresso da Blaise Pascal, il quale scrive in proposito che «la
fede dice ciò che i sensi non dicono, ma non il contrario di ciò che
vedono; essa è al di sopra, non contro»4, laddove i “sensi” traducono un
criterio di evidenzafenomenologica immediata rapportabile per analo-
gia all’evidenza della ragione epistemica, tant’è che altrove egli afferma
ancora che «l’ultimo passo della ragione è di riconoscere che vi è un’in-
4B. PASCAL, Pensées, 13/185 (ed. Lafuma).