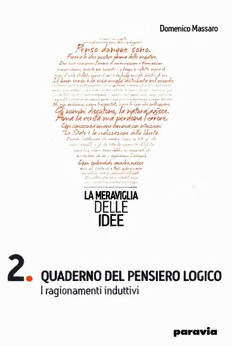Table Of ContentDomenico Massaro
L uoirv o ir uh sedette
Ut ; >»~;a/i OStiIn-thfo UftitC,eGhtitfjtiìti.tié*.
_ f^tlnSO 4lAh£flA.t £o h o .
Favvd In tJee bosifi/e piihrti ¿elle ht^tifUt.
tese nt'pvpicfrc !¿hiV^o di ^iArìA-Mb^^jGhe e dehetdUùhe
<vUv’pt-e. fr&ov'e, etuthU piti sortì»f a - ti il*h%o sì rilette saetti dì
essn: ìfcìe/a shunto sojuhti ditoni e Iti Uf/it W sitile dehfo odi ime.
Jjlu o h Oehtió è U COSÒ ÌMe^ho ¿istrtìùtifct he! UvùhJ.Ò.
Lu -■ Uso--.* è se* itti .}< «¡,*sh¿MtcsAtoA ìù-rc ci-*, ¿tetti tit io hhtbz. n ,J: ¿aiti li ¡‘■•se ÌUii/ei se l
■ti beh .* può Pi ’ U f>t>h*ti beh :. ‘¡b-psh.i ¿t thìrhJf.* in /basiti *- cohoW, -, (ti ti fan hi anni,
uufìe. È.4 s '¿itifi. :h ¿hfikt ttutifeUbtificti, •■ Ctiitiitth vi* f/.tihficl, aticnt, ichzti . putii ¡vtzz.
y. t/essiLA ti :h.lthtir‘hr nyi nhtihvx'bft ptii siti-, sehzti ¿¡•es?< r ;•* ter >ni ; p,-, uh oceu/o /tilenhfe.
Voi frGfr tihdititnnOJ Sititene fr tiS&Ghftifi, cola * /e CGSft cl? fìtilki)£ÌtihG.
¿dii IaOVwVh discutane, U ìntifohtiU£iSCt.
rvnnti Iti rthifk rt\ti frtb'doM i erhoht.
Oifìt CGhczezhzM iswtiM cotrvjhciti. coh ilntuiziobi.
"Le tttife è Iti /etihzztiziobe ¿eliti ìiLt/fk.
EsStbdo !\khihfifihZJ enn lA'btiizti ¡’notivi, SU fot' Jt ti ¡fu
•>san Sihsildi. ? ¡¡J: Jnt fotti Iti supine/>fti cntid iti
Sopiti loto, ti seti ^ schzti tiukho Uh ti/-i\Oin-tihfo c!v>
Uvf>/liti Lenir cne hai a tipf>licfatiuvo ti ihdti^ti/ù.
LS^hi Sj>ìth4i4o autitito htisce
tifutiSt uni ilttiffo citi S; fini./ ¿Utiliti Ì*-Ul tifiti
tht'icMp eie ùy-tif Ju-schtic / etile J.dLditi!.
Un» ; r. i-hfai.JÌ'lti/jfa/eè sdttibfrlissevzti
Iti S. coir.'¡/¡’iti weii.tipit li suo sutiuppc.
LA MERAVIGLIA
DELLE
IDEE
QUADERNO DEL PENSIERO LOGICO
I ragionamenti induttivi
paravia
uesto volume, dedicato all’analisi dei ragionamenti induttivi,
si pone come l’ideale continuazione del Quaderno delpensiero
logico 1, incentrato sulla deduzione.
Induzione e deduzione costituiscono le due articolazioni essenziali
della logica; non meno importante della deduzione sul piano teoretico,
l’induzione si rivela estremamente utile anche in ambito pratico,
poiché è una forma di ragionamento che orienta molte scelte della
nostra vita. Infatti, anche se il più delle volte in modo inconsapevole,
pianifichiamo i nostri comportamenti futuri sulla base delle
esperienze passate, oppure operiamo generalizzazioni partendo
da osservazioni e fatti pregressi; in breve, ci fidiamo dell’inferenza
induttiva, benché essa non porti a conclusioni necessarie ed
inconfutabili ma soltanto probabili.
Il fatto che la conoscenza induttiva sia probabilistica non
rappresenta un limite, ma in qualche modo costituisce uno stimolo
alla ricerca, la quale risulta essere perfettibile e confutabile,
necessitando della continua verifica e conferma dei suoi risultati. Si
tratta di una caratteristica tipica della scienza, che infatti si fonda
perlopiù su procedimenti induttivi, in cui hanno grande importanza
l’osservazione e l’esperimento.
In questo volume procediamo gradualmente alla scoperta delle regole
essenziali dell’inferenza induttiva. Cerchiamo quindi di chiarire la
differenza tra i ragionamenti deduttivi e quelli induttivi, definiamo
il ruolo che l’analogia, la causalità e la probabilità rivestono
nell’ambito del ragionamento induttivo e portiamo alla luce lo stretto
legame fra induzione e scienza moderna. Nella trattazione
ci avvaliamo di numerosi esempi ed esercizi con un livello di
difficoltà progressiva.
Il volume è corredato di quattro batterie di test di logica volti
ad affinare le competenze relative alla logica linguistica, alla logica
numerica, al ragionamento critico e alla comprensione di testi.
Domenico Massaro
INDICE GENERALE
Capitolo 1 3 L’empirismo contro il principio
di causalità 39
Le caratteristiche
4 Le critiche a Hume 41
dell’induzione 4
5 La produttività della causa 42
1 Due diversi modi di ragionare 4
6 Una causalità libera 44
2 A che cosa serve l’induzione? 6
7 La causalità nella spiegazione
3 L’esperienza come punto
storica 45
di partenza 7
4 Bacone: il teorico dell’induzione 8 METTITI alla PROVA 49
5 La rifondazione moderna
dell’induzione 10
Capitolo 5
6 Verso il metodo scientifico 12
Induzione e probabilità 50
METTITI alla PROVA 13
1 Eventi casuali... ma prevedibili 50
2 Le regole della probabilità 51
Capitolo 2
3 La scommessa di Pascal 53
L’attività induttiva e P“arte” METTITI alla PROVA 55
del pensiero 14
1 La Logica di Port-Royal 14
Capitolo 6
2 II rifiuto della logica vuota e
formalistica della tradizione 16
Induzione e scienza 56
3 John Stuart Mill e il Sistema 1 La scienza come forma più alta
di logica deduttiva e induttiva 18
di conoscenza 56
4 I canoni dell’inferenza induttiva 22
2 II naturalismo rinascimentale 57
METTITI alla PROVA 25 3 La scienza dei moderni 58
4 La critica alla concezione “ingenua”
del metodo scientifico 61
Capitolo 3
5 Le tappe dell’indagine scientifica 62
Induzione e analogia 26 METTITI alla PROVA 65
1 II ragionamento analogico 26
2 Gli usi dell’analogia 27
3 Lo schema generale dell’analogia 29
4 I criteri di validità dell’inferenza TEST di LOGICA 67
analogica 30
Logica linguistica 68
5 L’importanza dell’analogia
per lo sviluppo della scienza 32 Logica numerica 70
METTITI alla PROVA 34 Ragionamento critico 72
Comprensione di testi 75
Capitolo 4
Induzione e causalità 36
Indice dei nomi 79
1 II problema della causazione 36
2 Dalle cause alla causa 38 Indice dei lessici filosofici 80
1
CAPITOLO
dell'induzione
Due diversi modi di ragionare
I ragionamenti logici si distinguono in due grandi categorie: quelli di
tipo deduttivo e quelli di tipo induttivo. In questo capitolo spieghere
mo innanzitutto che cos’è l’induzione e in che senso si differenzia dal
la deduzione, e mostreremo l’importanza del ragionamento induttivo
nell’ ambito sia della scienza sia della vita quotidiana.
Conclusioni necessarie e conclusioni probabili
La prima e più vistosa differenza tra i due tipi di ragionamenti con
siste nel fatto che, mentre le conclusioni dell’argomentazione dedut
tiva sono necessarie, quelle dell’argomentazione induttiva sono più
un esempio pratico A o meno probabili.|IÌ fatto che l’attività fisica svolta regolarmenteìi-
: miti il pericolo di malattie cardiache è una verità della scienza ed è
i anche opinione comune: la casistica finora osservata lo dimostra.
: Tuttavia, tale verità non si presenta con i caratteri della necessità: non
iogni persona che pratica sport è esente dal rischio di infarto. Ciò si
gnifica che, se vogliamo sconsigliare a qualcuno una vita sedentaria,
non possiamo sostenere che l’inerzia provocherà senz’altro (neces-
: sariamente) problemi cardiaci nel corso della vita, ma che vi è una
I ragionevole probabilità che c d possa avvenire.
A differenza dell’ induzione, la deduzione conduce a conclusioni
necessarie. Se sostengo che tutti gli uccelli sono animali, e che la ron
dine è un uccello, devo per forza concludere che la rondine è un ani
male. Da premesse corrette, collegate validamente (ossia in modo ta
le da non infrangere le regole della logica deduttiva), possiamo
ottenere una conclusione certa e vera.
1 Due diversi modi di ragionare 5
Anche la logica induttiva si basa sull’inferenza (inferenza indut
tiva), ma la connessione tra le premesse e la conclusione non dipen
de dalla legge della necessità, bensì da quella della probabilità:
quanto maggiore è il grado di certezza delle premesse, tanto maggio
re sarà il grado di probabilità della conclusione. Il ragionamento in
duttivo, per sua natura, ammette sempre la possibilità che, rispetto a
tutti i casi considerati, si dia anche un solo caso contrario che inficia
il valore assoluto e necessario della conclusione. Dunque, sebbene
ad esempio la nostra osservazione costante e ripetuta ci mostri resi
stenza di corvi soltanto neri, tuttavia non possiamo sostenere con as
soluta certezza che “tutti i corvi sono neri”, perché la presenza anche
di un unico esemplare bianco potrebbe sempre falsificare la nostra
affermazione.
Conclusioni particolari e conclusioni generali
Alcuni logici distinguono la deduzione e l’induzione anche sulla
base del procedimento a esse sotteso e affermano che, mentre la de
duzione muove da premesse universali e perviene a conclusioni
particolari, l’induzione opera al contrario: muove da premesse par
ticolari per arrivare a conclusioni generali. In realtà ciò non è sem
pre vero, perché l’induzione può anche condurre da premesse par
ticolari a una conclusione particolare, come nel seguente esempio:
ia notte appena trascorsa non sono riuscito a prendere sonno, fatto f UN ESEMPIO PRATICO
insolito per me, perciò analizzo che cosa può averlo causato. Consta
to che la mia giornata non è stata in nulla differente rispetto a quelle
precedenti se non per una tazzina di caffè che ho bevuto dopo la mia
consueta cena a base di zuppa di verdure. Inferisco che sia stato il caf
fè a causare l’insonnia. Se valutiamo questo caso, osserviamo come
nella conclusione non si pervenga a una legge universale (del tipo “il
caffè provoca l’insonnia”).
Lessico filosofico
inferenza induttiva duttiva, quella induttiva non consente di
L’inferenza induttiva è un procedimento lo ottenere conclusioni necessarie; tuttavia,
gico grazie al quale, date determinate pre quanto maggiore è il grado di certezza
messe, è possibile trarre una conclusione delle premesse, tanto maggiore sarà ¡1
probabile. A differenza dell’inferenza de grado di probabilità della conclusione.
6 Capitolo 1 Le caratteristiche dell’induzione
A ogni modo, l’induzione è caratterizzata da un accrescimento
di informazione rispetto alle premesse (nel nostro esempio, la
consapevolezza che il caffè bevuto a tarda sera può, in alcuni casi e
con un certo grado di probabilità, provocare l’insonnia): l’obiettivo
dell’inferenza induttiva consiste proprio nell’ottenere una genera
lizzazione che, pur congruente con i dati di partenza, consenta un
ampliamento della conoscenza iniziale. Dalla conclusione del ra
gionamento induttivo ci attendiamo, in altre parole, una spiegazio
ne dei fenomeni osservati.
2 A che cosa serve l’induzione?
Orientarsi nella vita quotidiana
Per quanto non provvista dello stesso grado di necessità dell’inferenza
deduttiva, l’induzione è una pratica logica legittima, oltre che utile.
UN ESEMPIO'RAUCO Àd esempio, sapendo che statisticamente la padronanza dell’ingle
se favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, è ragionevole iscri
versi a un corso per approfondire la conoscenza dell’inglese, ed è
logico, basandosi sull’ esperienza passata, munirsi di ombrello se ve
diamo il cielo coperto di nuvole perché, come abbiamo imparato ma
gari a nostre spese, c’è la concreta possibilità che si metta a piovere.
Dunque, possiamo orientare la nostra vita mettendo a frutto il
nostro intuito induttivo. Se non lo facessimo ci sarebbe impossibile
compiere anche le azioni più banali, come prendere l’autobus, orga
nizzare la giornata, stabilire degli orari, comprendere la condotta de
gli altri e adeguarvi la nostra ecc.
Elaborare teorie scientifiche
L’induzione si basa su un certo numero di casi in cui un fenomeno si
è verificato e avanza la legittima pretesa che tale fenomeno si verifichi
anche nel futuro: nel fare ciò essa presuppone il principio dell’unifor
mità della natura, cioè la convinzione che, in linea di massima, natura
saltus nonfacit, “la natura non fa salti", e che quindi il comportamento
dei fenomeni naturali è regolare. In effetti, ragioniamo in termini indut
tivi se diciamo che il Tirreno è salato, l’Adriatico è salato, il Baltico è sa
lato, e, dunque, tutti i mari sono salati. Insomma, la logica induttiva non
solo è utile nella vita quotidiana, ma è anche il metodo più produttivo
nella ricerca scientifica, per quanto essa si presenti sempre congiunta
con procedimenti deduttivi (> cap. 6, pp. 63-64).
3 L’esperienza come punto di partenza
3 L’esperienza come punto
di partenza
Dalla spiegazione dei fatti osservati...
L’induzione si basa sull’osservazione dei fatti, di cui propone una
spiegazione.-Se mi vengono i crampi dopo aver corso per un’ ora inin
terrottamente, posso legittimamente inferire che la corsa mi abbia
provocato i crampi. Se un automobilista viene fermato dai carabinie
ri, che gli ritirano la patente, possiamo immaginare che abbia com
messo qualche grave infrazione. Se il professore di filosofia, che è
sempre puntuale e arriva a scuola con il treno, oggi è in ritardo, pos
siamo supporre che il treno non sia arrivato in orario.; Il procedimen
to induttivo, in tutti questi casi e in tantissimi altri analoghi, offre
ipotesi di spiegazione delle situazioni problematiche descritte - i
crampi, il ritiro della patente, il ritardo del professore... facendoci
apprendere qualcosa circa le loro cause o ragioni - la contrattura dei
muscoli, la violazione del codice stradale, il ritardo del treno...
pertanto, possiamo considerare tali ipotesi affidabili, anche se non in
modo assoluto e incontrovertibile.
... alla generalizzazione di scelte
e comportamenti
L’induzione consente di compiere generalizzazioni ancora più am
pie: se, ad esempio, decido di trascorrere una vacanza aNewYork, ve
rificherò senz’altro che la mancia al cameriere è un atto dovuto, da cui
non posso esimermi; se poi vado in un paese straniero e affitto un au
tomobile, dovrò osservare con attenzione il senso di marcia delle vet
ture, adeguandomi nella guida (a destra o a sinistra) per non incorre
re in incidenti e sanzioni. Si tratta di casi “registrati” dall’esperienza
personale diretta e da cui si possono trarre opportune conclusioni
sulle consuetudini e sulle regole vigenti in altri paesi: in particolare,
il fatto che negli Stati Uniti è obbligatorio dare la mancia al camerie
re perché il servizio del personale non è incluso nel costo della con
sumazione, e che in certe nazioni (ad esempio l’Inghilterra) occorre
guidare tenendosi a sinistra perché questo comportamento è previsto
dal codice stradale locale.
C’ è dunque una stretta connessione tra ragionamento induttivo
ed esperienza: quest’ultima condiziona il nostro presente e, in qual
che modo, fornisce lo schema per poter agire in modo opportuno
nel futuro.
8 Capitolo 1 Le caratteristiche dell’induzione
Bacone: il teorico dell’induzione
Ma che cosa si intende veramente per “esperienza”? Il termine allu
de a una serie di osservazioni e atti concreti mediante i quali si acqui
sta la conoscenza di cose particolari; il discorso scientifico, dunque,
si deve basare su proposizioni che possono essere verificate tramite
il ricorso diretto ai fatti.
La critica al sillogismo aristotelico
L’appello all’esperienza è stato privilegiato nell’età moderna da Fran
cesco Bacone (1561-1626), considerato il migliore interprete della ri
voluzione scientifica e il teorico dell’induzione. Di Bacone è celebre la
polemica contro il sillogismo aristotelico (o ragionamento dedutti
vo), accusato di sterilità e vuoto formalismo logico, visto anche come
causa principale dell’arretratezza in cui versava la conoscenza scienti
fica prima della rivoluzione astronomica di Niccolò Copernico ( 1473-
1543), Giovanni Keplero (1571-1630) e Galileo Galilei (1564-1642). Il
sapere dei Greci, basato sul ragionamento deduttivo o sillogistico, se
condo Bacone rappresenta l’infanzia della scienza, con tutte le caratte
ristiche tipiche del modo di pensare dei fanciulli: «pronto a ciarlare, è
immaturo e incapace di generare» (F. Bacone, Instauratio magna, in
Scritti filosofici, a cura di P. Rossi, utet, Torino 1975, p. 522). Lalogica
deduttiva serve soltanto a spiegare le nozioni già acquisite, ma non
consente passi avanti sulla via della scoperta della natura:
Noi respingiamo la dimostrazione per mezzo di sillogismo perché
essa non produce che confusione e fa sì che la natura ci sfugga dalle
mani. Quantunque inf atti nessuno possa dubitare che due cose che
si accordano con un termine medio si accordino anche fra di loro
(che è una specie di certezza matematica), tuttavia qui è nascosto un
inganno: perché il sillogismo consta di proposizioni, le proposizioni
di parole e le parole sono le etichette e i segni delle nozioni.
(F. Bacone, Instauratio magna, in Scritti filosofici, cit., p. 533)
Lessico filosòfico ______
esperienza diante i quali si acquista la conoscenza di
Si tratta di un termine che deriva dal latino cose particolari. I n ambito scientifico il ter-
experientia, a sua volta derivante da mine è in relazione con proposizioni che
expérior, “provo”, “tento”, e allude a una implicano la possibilità di essere verificate
serie di osservazioni e atti concreti me- con il ricorso diretto a fatti.
4 Bacone: il teorico dell’induzione 9
L’appello all’esperienza
Poiché le parole sono astratte, ossia sganciate dall’esperienza, non pos
sono dare alcun contributo alla comprensione della realtà concreta. Da
ciò deriva l’invito ad abbandonare le sottigliezze sillogistiche e ad ac
cettare il metodo sperimentale, caratterizzato appunto dall’induzione,
la quale sa analizzare efficacemente l’esperienza ed è più adatta a sco
prire le leggi della natura: «Pensiamo infatti che l’induzione sia quella
f orma di dimostrazione che sostiene il senso, stringe da presso la natu
ra ed è vicina alle opere, quasi mescolandosi con esse» {ivi, p. 543).
La nuova scienza deve produrre conoscenza, non mere discussio
ni. Aristotele è stato un grande filosofò, ma i suoi concetti non permet
tono di progredire nel sapere. Egli è paragonabile al ragno, che intesse
la tela con materiali che genera da sé e poi la identifica con il mondo;
fuor di metaf ora, il filosofo deduttivo elabora una rete di relazioni lo
giche astratte che pretende di far coincidere con la realtà concreta,
mentre si tratta solo di una costruzione artificiale, di uno schema ra
zionale che non può rappresentare la varietà e la ricchezza del reale.
L’esigenza di un metodo che “faccia parlare”
la natura
La natura non si rivela f àcilmente né spontaneamente, ma va interpre
tata, stimolata e messa alla prova. Se il filosof ò deduttivo, simboleggia
to dal ragno, non è in grado di farci scoprire fatti nuovi sul mondo,
neppure ci può soddisf are la ricerca dell’uomo “empirico”, il quale, co
me la f òrmica, accumula dati senza filtrarli criticamente né elaborarli.
In altre parole, come non ci serve la logica astratta, così è insufficiente
il puro e semplice metodo empirico, che registra osservazioni in mo
do casuale e indiscriminato. Di qui la conclusione che l’osservazione
della natura è importante, ma deve essere condotta con metodo: oc
corre mettere alla prova la natura, interrogarla e obbligarla a darci ri
sposte utili. Insomma, il sistema per capire e costringere la natura a ri
velarsi è il metodo induttivo: «Alle scienze è necessaria un’induzione
di f orma tale da risolvere e analizzare l’esperienza e concludere neces
sariamente mediante legittime esclusioni ed eliminazioni» {ivi, p. 535).
Non il ragno né la f òrmica, dunque, ma l’ape rappresenta la nuova
metafora della ricerca: essa, infatti, succhia il nettare dai fiori su cui
si posa (ossia osserva e raccoglie), ma poi produce il miele, cioè qual
cosa di nuovo e originale. All’induzione com’era stata concepita da
Aristotele, consistente nell’«enumerazione completa» dei fenomeni,
Bacone contrappone una «nuova induzione», fondata sull’esperi
mento e capace di operare legittime eliminazioni.
IO Capitolo 1 Le caratteristiche dell’induzione
5 La rifondazione moderna dell’induzione
Dall’esperienza all’esperimento
Come abbiamo visto, per Bacone l’intera costruzione logica di Ari
stotele e, ancor più, degli aristotelici e degli scolastici, va demolita. A
suo avviso, da una parte - cioè per quanto riguarda il ragionamento
deduttivo - gli antichi peccavano di astrattismo, dall’ altra - cioè per
quanto concerne il loro metodo induttivo - concedevano troppo alla
realtà, erano troppo dipendenti dai fatti, verso cui non riuscivano a
esercitare l’indispensabile vaglio critico.
La vaga nozione di “esperienza” deve cedere il posto al vero metodo
scientifico, che si f onda sull’esperimento, cioè sulla f ormulazione di
ipotesi circostanziate e suffragate da una «collezione ordinata di fat
ti», e sulla loro verifica empirica. Un nuovo edificio logico deve esse
re eretto: un sistema che non si pongapiù l’obiettivo di insegnare agli
uomini come argomentare, ma come progredire nella conoscenza e
nella sua applicazione.
Per Bacone tale edificio deve essere costruito innanzitutto sconfig
gendo «l’informazione ingannevole e fallace offerta dal senso»:
l’osservazione poco accurata, ineguale e procedente a caso; la tradi
zione vana e derivante da voci popolari; la pratica servilmente inten
ta alle opere; e finalmente la storia naturale superficiale e povera
[che] ha fornito all’intelletto [...] un materiale corrottissimo.
(F. Bacone, Instaurano magna, in Scritti filosofici, cit., p. 538)
L’intreccio di osservazione e riflessione
Qual è dunque il fondamento del metodo induttivo proposto da Ba
cone? Secondo il filosof ò occorre innanzitutto partire da un materia
le idoneo, cioè conferire ordine e criterio alla raccolta delle osser
vazioni; è infatti inutile «pulire lo specchio» (quindi, dal punto di
vista di Bacone, affrancarsi dalla credenza nella magia, dai falsi pre
giudizi dell’opinione comune e dalle filosofie del passato), se poi le
immagini su cui si riflette sono caotiche e confuse. Per quanto riguar
da l’oggetto dell’indagine, bisogna preparare una «storia non solo
Lessico filosofico_________
esperimento scientifico esso richiede la riproduzione di
L’esperimento è la realizzazione di una un fenomeno naturale In laboratorio o In
prova empirica con cui si intende convali condizioni ambientali ben determinate e
dare o confutare un’Ipotesi. In ambito controllabili.