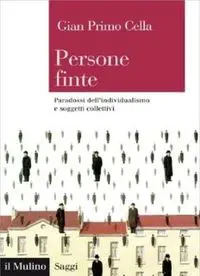Table Of ContentLDB
Individualismi di ogni tipo imperversano oggi sulla scena sia pubblica sia
privata, mentre vecchi soggetti collettivi, come partiti e sindacati, che hanno
accompagnato l’era della società industriale sembrano entrati in una fase di
declino. Contemporaneamente il mercato globale si afferma come suprema
forma di regolazione e di controllo dei conflitti e delle aspirazioni. In questo
contesto, gli attori e i soggetti collettivi, le "persone finte", non scompaiono, si
trasformano e generano paradossi: sono proprio i nuovi soggetti collettivi, infatti,
come le grandi imprese multinazionali dell’informatica e della comunicazione, a
promuovere ed esaltare pratiche e culture individualiste. Il libro ci consente di
scoprire la vera natura di queste "persone finte", rivelandone tutta la portata
politica.
Gian Primo Cella è stato professore di Sociologia economica e di Teoria sociale
nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano. Tra le sue
pubblicazioni per il Mulino: "Tracciare confini. Realtà e metafore della
distinzione" (2006) e "Relazioni industriali e contrattazione collettiva" (con T.
Treu, 2009).
Gian Primo Cella
Persone finte
Paradossi dell'individualismo e soggetti collettivi
Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda http://www.mulino.it/ebook
Edizione a stampa 2015
ISBN 978-88-15-25436-8
Edizione e-book 2015, realizzata dal Mulino - Bologna
ISBN 978-88-15-32327-9
Indice
Premessa
Capitolo primo
Il «paradosso» dell’individualismo
Capitolo secondo
Lo strano individualismo di un grande teorico sociale
Capitolo terzo
La rappresentanza attraverso soggetti collettivi
Capitolo quarto
Da dove originano gli attori collettivi
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Indice dei nomi
a Beatrice, Isabella, Tommaso
Ringraziamenti
Nel portare a termine questo lavoro, secondo un’abitudine che non oso chiamare «stile», mi sono
mosso in solitudine. In questi casi i ringraziamenti, almeno in apparenza, potrebbero essere
ridotti, anche se il solitario che studia e scrive dovrebbe essere molto grato a tutti coloro che, con
riconoscimenti espliciti o impliciti, gli permettono di non punirsi troppo di questa condizione.
Due amici e colleghi voglio però ricordare: Franco Rositi e Roberto Pedersini. Al primo, dal quale
ho sempre appreso sapienza sociologica in quasi cinquant’anni di rapporti, devo la sollecitazione
iniziale a occuparmi di soggetti collettivi, nonché qualche prezioso conforto critico su alcune parti
specifiche. Al secondo sono riconoscente per l’attenzione e la pazienza con cui ha letto la prima
stesura del saggio. Una lettura che mi è stata molto utile specie perché proveniente da un ben più
giovane collega.
Premessa
In occasione della stesura di questo saggio il tema si è imposto innanzitutto
attraverso la percezione di una sorta di paradosso, quello che riguarda la
diffusione a tratti inarrestabile, non solo nelle scienze sociali, di argomenti di
taglio individualista per interpretare le relazioni e le dinamiche sociali, proprio
nel momento in cui si affermano e talvolta dominano attori e soggetti di tipo
collettivo, che individui di certo non sono. È attraverso tali argomenti che si
percepisce per contrasto la rilevanza di questi attori/soggetti, ma è lo stesso
successo della loro diffusione che impedisce di cogliere la natura e la
consistenza delle entità collettive. Il paradosso è stato attenuato, o nascosto,
dall’indubitabile declino di alcuni dei soggetti collettivi che hanno
accompagnato l’era della società industriale, partiti politici e sindacati fra questi,
e dalla contemporanea affermazione del mercato globale come suprema forma di
regolazione e di controllo dei conflitti e delle aspirazioni. Ma l’immagine di
soggetti che si aggirano liberati per le vie del mondo, o semplicemente di
Internet, compiendo scelte e decisioni all’interno della propria sfera individuale
è del tutto fuori luogo. Talvolta le pratiche e le culture individualiste sono
proprio favorite dalle scelte degli stessi soggetti collettivi che, come le grandi
imprese multinazionali dell’informatica e della comunicazione, così operando
contribuiscono a definire e a costruire la realtà sociale, nel mentre pretendono di
fornire solo strumenti utili a favorire le scelte individuali.
Da questa percezione sono partito per tentare di approfondire la natura dei
soggetti collettivi per i quali si è disposti, nelle scienze sociali come nel
linguaggio ordinario, a utilizzare attribuzioni, proprietà, predicati verbali che
normalmente riserviamo ai soggetti individuali. È una natura che è ben presente
e dibattuta nella teoria del diritto fin dalle sue origini, ma che viene data per
scontata nella teoria sociale la quale (con le poche grandi eccezioni di cui
parlerò, prima fra tutte quella di James S. Coleman) è portata a sottovalutare il
contributo decisivo delle discipline e delle professioni giuridiche alla definizione
della realtà sociale. Dopo il paradosso si è portati perciò a scoprire una finzione,
e il suo apporto sociale, quello che ci permette di considerare i soggetti collettivi
come se fossero soggetti individuali. Talvolta, lo vedremo, la finzione si
trasforma in invenzione, e tra le due figure non riusciremo sempre a distinguere,
anche se potremo tenerle entrambe separate da una terza strada, quella del
realismo che, specie sull’eredità del diritto associativo germanico, è portata ad
attribuire ai soggetti collettivi corpo e volontà, talvolta un’anima. Tramite questa
«scoperta», tale almeno in buona parte della teoria sociale, incontreremo
individui che non sono persone, persone che non sono individui, individui che
sono persone collettive, soggetti collettivi che non sono persone. E se
l’invenzione ci richiama con il suo fascino, potremo imbatterci addirittura in
soggetti che appartengono a due nature nello stesso tempo (è la famosa
immagine dei «due corpi del re» di Kantorowicz). Una bella varietà di soggetti,
non c’è dubbio.
Dopo il paradosso e la finzione incontreremo un processo che si articola
proprio attraverso i soggetti collettivi: è il processo di rappresentanza. Sappiamo
da Hobbes, ma anche dal significato latino di persona («maschera»), che il
concetto di persona sottende sempre una forma di rappresentanza, ma in questo
caso il rapporto è più esplicito: si tratta della rappresentanza che si attua
attraverso soggetti collettivi, come accade tipicamente nelle relazioni pluraliste
fra i gruppi organizzati più che nei sistemi politici, dove la rappresentanza alla
fine si traduce sempre nell’elezione di rappresentanti individuali. Con i soggetti
collettivi, e dunque con le «persone finte», si manifesta l’intenzionalità della
ricerca di un noi rivolto a superare gli ostacoli oggettivi che gli individui
incontrano nelle diverse forme della convivenza sociale, e che impone a