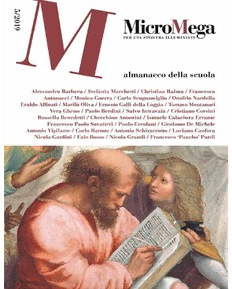Table Of ContentSe si vuole che la democrazia prima si faccia e poi
si mantenga e si perfezioni, si può dire che la Scuola
a lungo andare è più importante del Parlamento
e della Magistratura e della Corte costituzionale.
Piero Calamandrei
direttore:
Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di
Cinzia Sciuto
Ingrid Colanicchia
Giacomo Russo Spena
Roberto Vignoli
www.micromega.net
sommario
IL SASSO NELLO STAGNO
Alessandro Barbero
Se la scuola muore
ICEBERG 1
parola di insegnante
Stefania Marchetti
Confessioni (disperate) di una prof.
Christian Raimo
La scuola, cuore della città
Francesca Antonacci e Monica Guerra
Una scuola diversa è possibile (ed è già realtà)
Carlo Scognamiglio
Il paradosso dell’inclusione che esclude
Onofrio Nardella
Sostegno: luci e ombre di un sistema all’avanguardia
Eraldo Affinati
Le scuole Penny Wirton
Marilù Oliva
La scuola aperta: una proposta per le superiori
DIALOGO 1
Ernesto Galli della Loggia / Tomaso Montanari
Quale scuola per il futuro?
LABIRINTO
Vera Gheno
Felici e connessi (Per un’alfabetizzazione digitale nelle scuole)
Paolo Berdini
Per studiare servono luoghi belli
Salvo Intravaia
Professione docente
Cristiano Corsini
Luci e ombre delle prove Invalsi
Rossella Benedetti
Scuola: come funziona nel resto d’Europa
Checchino Antonini
Il ritorno delle scuole popolari
Ismaele Calaciura Errante e Francesco Paolo Savatteri
A.A.A. Politica studentesca cercasi
SAGGIO 1
Paolo Ercolani
Verso una società ottusa?
DIALOGO 2
Girolamo De Michele / Antonio Vigilante
Critica della ragione scolastica
SAGGIO 2
Carlo Barone e Antonio Schizzerotto
A che serve studiare?
ICEBERG 2
Luciano Canfora
‘Italiani, vi esorto alle storie’
Nicola Gardini
Studiare il latino fin dalle elementari
Ezio Bosso
Musica, maestro! (Insegnare le note dalla più tenera età)
Nicola Grandi
Buone pratiche per l’insegnamento delle lingue
Francesco ‘Pancho’ Pardi
Un elogio della geografia
NOTIZIE SUGLI AUTORI
COLOPHON
il sasso nello stagno
SE LA SCUOLA MUORE
Ossessionata dalla valutazione, sommersa dalle scartoffie, genuflessa al
dogma del mercato, la nostra scuola sta soffocando. E noi stiamo a
guardare. Eppure basterebbe poco per invertire la rotta. Non è neanche un
problema di soldi (che naturalmente non guasterebbero). Sarebbe
sufficiente per esempio che gli insegnanti fossero lasciati in pace a fare il
loro lavoro, anziché costringerli a buttare via il loro tempo per compilare
inutili incartamenti e stressarli con assurde valutazioni. E basterebbe
tornare a pensare che la scuola deve produrre teste pensanti, e non meri
esecutori di mansioni.
ALESSANDRO BARBERO
In tutto l’Occidente il declino della scuola pubblica è un fenomeno storico
ben riconoscibile da qualche decennio. Ovviamente esistono differenze da un
paese all’altro, perché ci sono luoghi in cui da sempre frequentare la scuola
pubblica significa ricevere un’istruzione giudicata di serie B (e dove quindi la
classe dirigente manda i suoi figli esclusivamente in scuole private, come
capita ad esempio negli Usa), e altri – come l’Italia – in cui la qualità più alta
è sempre stata garantita dai licei pubblici; e non solo da quelli famosi delle
grandi città (il Parini, il Mamiani, il D’Azeglio, scuole i cui nomi sono parte
della storia della società e della cultura italiana). Al di là delle differenze
nazionali è però evidente che in tutto l’Occidente la scuola pubblica è in crisi
e che sta subendo un progressivo abbassamento di livello.
L’allergia al pensiero critico
della classe politica e imprenditoriale
L’insufficienza delle risorse è solo uno dei problemi, anche se spiega
molte cose. Per limitarci a un esempio, nel gennaio di quest’anno il colossale
sciopero degli insegnanti a Los Angeles («frutto di anni di frustrazioni»,
osserva il Guardian) ha rivelato il declino del sistema scolastico californiano,
che una volta era il migliore degli Stati Uniti: «Gli insegnanti lottano con
classi sovraffollate e bambini le cui necessità di sostegno, assistenza
psicologica e aiuto nell’apprendimento dell’inglese superano di gran lunga le
possibilità della scuola». Nei quartieri poveri gli insegnanti comprano stracci
e detersivi e fanno loro stessi le pulizie alla fine della giornata: il tutto in uno
Stato, la California, che ha la più alta concentrazione di miliardari sulla
Terra1.
Ma la scarsità di mezzi non basta a spiegare le difficoltà in cui si dibatte
la scuola. Il problema più grave è l’approccio culturale: l’indifferenza, se non
l’ostilità, della classe politica nei confronti della scuola e degli insegnanti.
Un’ostilità neanche tanto nascosta quando si tratta della destra: in Italia è
innegabile l’antipatia di un intero settore dell’opinione pubblica nei confronti
di un mondo, quello degli insegnanti, tradizionalmente considerato di
sinistra). Ma il problema va al di là della collocazione politica e
dell’orizzonte italiano, anche se l’Italia, per l’estrema inadeguatezza e
ignoranza della classe politica, è particolarmente indifesa. La minaccia più
insidiosa è l’ideologia unica del profitto, l’esaltazione dell’imprenditoria
come sale della terra, l’attenzione esclusiva all’economia e al mercato. Ne
risulta una classe dirigente che non capisce letteralmente più a che cosa
servano la cultura e lo spirito critico e che, quando lo capisce, li considera
pericoli da neutralizzare. La scuola non deve produrre teste pensanti, ma
esecutori, tecnici: è solo in questi termini che la classe dirigente riesce a
concepirla.
Va da sé che in questa prospettiva la scuola si giustifica esclusivamente
come preparazione al lavoro, in maniera ben diversa da quando a scuola
andavano soltanto i figli della classe dirigente. Gli istituti più prestigiosi
offrivano allora una formazione completamente scollata dalla realtà pratica
del mondo del lavoro ed è proprio questo che la borghesia voleva per i propri
figli. Ora che a scuola vanno tutti, invece, improvvisamente questo non va
più bene. In passato era ovvio che andare al ginnasio anziché a una scuola di
avviamento professionale rappresentasse un enorme vantaggio, da cui infatti
le masse erano escluse; oggi nessuno osa più dire che la formazione culturale
impartita dalla scuola arricchisce e avvantaggia chi la riceve soprattutto se è
indipendente dalla formazione professionale. Durante la prima guerra
mondiale, l’esercito chiamava come ufficiali per comandare i plotoni anche
giovani di 19 anni, purché diplomati. Il latino serviva a impartire gli ordini?
Evidentemente no, ma si dava per scontato che una formazione scolastica
completa preparasse una persona più forte e più capace in ogni ambito della
vita.
Nei decenni delle lotte per i diritti, del welfare state e della crescita
dell’uguaglianza, dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni
Settanta, questa concezione si è allargata senza snaturarsi. L’idea era che la
scuola servisse a formare il libero cittadino e che per questo tutti dovessero
andarci il più a lungo possibile, fino a quattordici anni, poi fino a sedici, e che
questo dovesse essere un obbligo, per evitare che nelle classi sociali più
disagiate prevalesse la tentazione di mandare i figli a lavorare, privandoli così
di una possibilità di miglioramento (umano, prima ancora che sociale ed
economico) che invece doveva essere garantita a tutti. All’epoca un bambino,
o un ragazzo, che andava a lavorare anziché a scuola era guardato con
tristezza, visto come uno «spreco» e come un indicatore di arretratezza del
paese. Oggi invece c’è l’alternanza scuola-lavoro: per la prima volta da secoli
si è invertita la spinta a garantire a tutti un periodo di scuola il più lungo e
libero possibile e si è cominciato a dire che restare a scuola fino a diciott’anni
senza essere obbligati a lavorare è un lusso o una perdita di tempo, che
allontana dal cosiddetto mondo reale. In molti casi gli insegnanti che
gestiscono l’alternanza scuola-lavoro riescono, con grande e non
ricompensata fatica personale, a trarne un’esperienza utile per i loro ragazzi,
ma in altri casi non siamo lontani dalla concezione sovietica per cui gli
studenti d’estate dovevano andare a raccogliere le patate – salvo che qui alla
base non c’è nemmeno l’egualitarismo sovietico, ma la realizzazione del
progetto, sempre presente nei programmi dei governi di destra, di ridurre di
fatto l’obbligo scolastico sostituendolo con percorsi lavorativi.
Burocratizzazione
L’altro dramma che investe la scuola riguarda la fatica degli insegnanti e
lo spreco obbligatorio del loro tempo, frutto di un cancro di cui soffre oggi
tutta la società, ma in modo particolarmente grave il settore pubblico: la
burocratizzazione. La scuola è aggredita dalla cultura imperante della
pianificazione, dell’offerta formativa, delle sigle ridicole, della burocrazia
kafkiana e della perdita di tempo istituzionalizzata, delle riunioni inutili e dei
moduli da riempire, magari al fine conclamato di certificare il merito e la
qualità. È un’aggressione che subiamo tutti, e che nasce da un processo di cui
non si ha ancora abbastanza coscienza: la tendenza della burocrazia a
impadronirsi della società, a rendersi non solo indispensabile, ma padrona in
tutti gli ambiti. La burocrazia sa bene che per fare questo deve elaborare
sempre nuovi regolamenti, imporre nuovi adempimenti, costringere a
compilare altri moduli. (Domanda rivolta a quattro insegnanti: «Quanto
tempo passate a compilare scartoffie?». Risposta concorde: «In certi periodi,
il doppio del nostro lavoro», dove è interessante la percezione che compilare
scartoffie non sia il loro lavoro, ma solo qualcosa che sono costretti a fare2).
Il paradosso è che questo immenso spreco, che va direttamente a scapito
della produttività e del benessere individuale e collettivo, viene gabellato
come una garanzia per assicurare la qualità. L’idea, priva di qualunque
fondamento scientifico, che individui e collettivi lavorino meglio se le loro
prestazioni sono programmate, previste e dichiarate in anticipo, ovviamente
secondo griglie rigide predisposte dalla burocrazia, governa oggi indiscussa
la vita della scuola. Gli insegnanti debbono dedicare lunghe ore non a
studiare, o a preparare le lezioni, ma a produrre incartamenti in un linguaggio
occulto, che li segrega ulteriormente dal mondo: c’era una volta il Pof, il
Piano dell’offerta formativa, ora c’è il Ptof, Piano triennale dell’offerta
formativa, vulgo il «pitòff». Se poi in una scuola ci si accorge che non ci sono
soldi per comprare le lim (le lavagne interattive multimediali) o i computer,
bisogna chiedere come concessione eccezionale quello che dovrebbe spettare
di diritto a tutti, e per ottenerlo è ovviamente necessario presentare un
«progetto», altra parola magica della nostra epoca («La scuola ormai è un
progettificio»).
La cultura del progetto non serve affatto a premiare l’iniziativa e a
concedere ulteriori risorse ai più bravi; serve, invece, a fare in modo che
anche l’indispensabile sia concesso solo ad alcuni, in cambio di una
sottomissione sacrale agli idoli. La sottomissione consiste nella compilazione
di progetti dai nomi arcani («I Pon sono europei, i Por sono regionali»), che
per avere successo debbono essere compilati in una neolingua orwelliana
(«Basta sapere cosa scrivere: problem solving, inclusione, classe capovolta»),
che ovviamente costano tempo e fatica e non sono rimunerati ma sottratti a
quello che dovrebbe essere il vero lavoro dell’insegnante. Compilare i
progetti richiede una competenza specifica, perché la modulistica è
straordinariamente complessa: c’è chi ha fatto corsi di formazione di 40 ore
per imparare a compilarli. L’orgoglio di aver aiutato la propria scuola a
ottenere qualche soldo in più non elimina la sensazione di un tangibile
svilimento del proprio mestiere («Noi siamo delle puttane che si vendono al
miglior offerente. Io preparo progetti dalla mattina alla sera, perché abbiamo
bisogno di soldi, altrimenti non possiamo comprare nemmeno la carta
igienica»).
L’inganno della valutazione