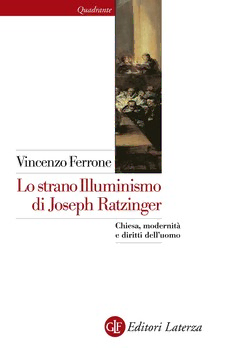Table Of ContentQuadrante Laterza
189
Vincenzo Ferrone
Lo strano Illuminismo
di Joseph Ratzinger
Chiesa, modernità e diritti
dell’uomo
Editori Laterza
© 2013, Gius. Laterza & Figli
www.laterza.it
Prima edizione febbraio 2013
Edizione
2 3 4 5 6 7
Anno
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Questo libro è stampato
su carta amica delle foreste
Stampato da
Martano editrice srl - Lecce (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-581-0441-5
È vietata la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche
ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è
lecita solo per uso personale purché
non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
Ferrone.indd 4 28/02/13 14.31
Prefazione
Appositamente argomentato come un polemico pamphlet, questo
piccolo libro1 vuole denunciare l’uso disinvolto della storia da parte
delle gerarchie vaticane quando si tratta di fare i conti con la mo-
dernità, i diritti dell’uomo e il cosiddetto post-moderno. Un uso,
condotto a fini strategici e di grande ambizione politico-culturale
sul futuro della Chiesa, che, in taluni casi, sconfina sempre più
nell’abuso mistificatorio. Tutto ciò in un momento politico crucia-
le per l’umanità: un momento in cui la storia, a fronte della crisi di
scienze umane e sociali come l’economia e la sociologia, sta tornan-
do finalmente a essere una risorsa importante per la conoscenza
della realtà, per il dibattito pubblico e i suoi processi di formazione.
Com’è noto, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso la
1 Una prima versione del testo, qui aggiornata e corretta, è stata presentata
e discussa, anche con toni talvolta aspri e polemici, il 6 febbraio 2004 in un
apposito seminario organizzato dalla Fondazione Michele Pellegrino presso l’U-
niversità di Torino. Vi parteciparono molti studiosi, personalmente o con l’invio
di commenti, tra cui Paolo Prodi, Antonio Padoa-Schioppa, Luciano Guer-
ci, Silvio Ferrari, Giovanni Miccoli, Giovanni Conso, Oreste Aime, Giorgio
Bouchard, Corrado Vivanti, Ermis Segatti, Massimo Firpo, Antonio Rotondò,
Gustavo Zagrebelsky, Roberto Repole, Claudio Ciancio, Leopoldo Elia, Franco
Bolgiani, Edoardo Tortarolo, Daniele Menozzi, Antonio Trampus, Mario Do-
gliani, Pietro Scoppola, Francesco Traniello e altri ancora. Gli atti complessivi
del seminario, con i commenti dei partecipanti, furono poi raccolti dalla Fon-
dazione Michele Pellegrino nel volume Chiesa cattolica e modernità, a cura di F.
Bolgiani, V. Ferrone e F. Margiotta Broglio, Bologna 2004.
v
vexata quaestio del post-moderno – che era stata precedentemen-
te dibattuta nel Nord America soprattutto in campo artistico e
letterario – è divenuta oggetto specifico di riflessione filosofica e
storica in ogni angolo d’Europa. Tutto ha avuto inizio in Francia
nel 1979, con La condition postmoderne di Jean-François Lyotard.
In quelle pagine si teorizzava l’avvento di una svolta epocale dei
saperi nelle società più sviluppate: la crisi e il superamento defi-
nitivo della «narrazione dei Lumi», delle filosofie emancipatorie
dominate dall’idea di progresso di matrice positivistica, idealistica
e marxista, con la conseguente liquidazione delle antiche forme di
legittimazione dei vincoli sociali2.
Il contributo italiano più significativo al dibattito apparve
nel 1985, con la pubblicazione del volume di Gianni Vattimo
La fine della modernità. L’obiettivo dichiarato era quello di ar-
ruolare Nietzsche e Heidegger tra i profeti del nuovo culto post-
moderno: il già formidabile arsenale a disposizione era arricchito
di riferimenti al definitivo superamento dell’Io e alla denuncia
degli effetti perversi della scienza e della tecnica nei processi di
disumanizzazione e nelle moderne logiche di dominio. Da teorico
del “pensiero debole”, Vattimo invitava a ripensare la verità come
esperienza sociale, estetica e retorica e non più razionale e scien-
tifica. Questo, soprattutto, significava fare finalmente i conti con
la «fine della storia».
Il segno autentico della nuova età post-moderna stava proprio
lì, nella definitiva presa di coscienza che la storia, intesa come pro-
cesso unitario, progressivo, capace di legittimare una possibile e
concreta lettura del mondo, era definitivamente evaporata. Espli-
cito era in tal senso il richiamo di Vattimo ad Arnold Gehlen che,
nei suoi lavori sulla post-histoire, rivendicava il superamento della
nozione di storicità alla base di tutta la costruzione della moderni-
tà3. Quel secolare modo di concepire la realtà pareva infatti come
2 Cfr. J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna, Milano 1981.
3 Cfr. G. Vattimo, La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella
cultura postmoderna, Milano 1985. Sulla polemica in Italia cfr. C.A. Viano, Va’ pen-
siero: il carattere della filosofia italiana contemporanea, Torino 1985; e soprattutto le
acute considerazioni di P. Rossi, Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, Bo-
logna 1989, in particolare laddove sinteticamente, ma con efficacia, afferma che «il
pensiero debole è in realtà solo una sottospecie dell’antiilluminismo forte» (p. 23).
vi
scomparso d’incanto di fronte alla sostanziale stasi delle nuove
società virtuali, in cui dominavano le comunicazioni di massa e la
potenza delle tecnologie.
E tuttavia il paese in cui con maggiore serietà, profondità e pas-
sione civile furono dibattute le ragioni e le conseguenze del post-
moderno fu certamente la Germania. Ne furono protagonisti teo-
logi, artisti, letterati come Günter Grass – autore, nel 1984, di una
serie di conferenze sul tema in cui erano acriticamente rilanciate
le tesi della Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer;
il titolo era quanto mai significativo: Miserie dell’Illuminismo4.
Jürgen Habermas fu innegabilmente tra quanti s’impegnarono di
più in quello spinoso e difficile confronto che avrebbe potuto
rimettere in discussione il modo stesso in cui la Germania stava
facendo i conti con il suo passato. Lo fece a partire dal 1980, am-
mettendo con sincera inquietudine che «da allora questo tema,
assai discusso e ricco di sfaccettature, non mi ha più dato pace»5.
E in effetti la posta in gioco era quanto mai alta e avrebbe condi-
zionato a lungo tutta l’opinione pubblica internazionale.
Sostenitore della tesi della modernità come «progetto incom-
piuto» e semmai da completare esplorando ulteriormente limiti
e potenzialità della ragione e dell’agire comunicativo, Habermas
tentò vanamente di limitare gli effetti corrosivi prodotti dal libro
celeberrimo di Adorno e Horkheimer, i quali – mescolando arbi-
trariamente storia e filosofia – avevano segnalato una fragorosa e
insospettabile paternità illuministica nella nascita dei totalitarismi
e nelle terribili tragedie del Novecento; lo fece ricostruendo au-
tore dopo autore tutto il discorso filosofico della modernità, met-
tendo in guardia da coloro che nascondevano la «complicità con
una veneranda tradizione del contro-illuminismo, spacciandola
per post-illuminismo»6. Un compito di denuncia, questo, oltre-
modo difficile, arduo da comunicare alle orecchie sorde di molti
4 Cfr. G. Grass, Der Traum der Vernunft. Rede zur Eröffnung der Veranstal-
tungsreihe «Vom Elend der Aufklärung» in der Akademie der Künste Berlin, in
Essays und Reden 1980-2007, Göttinger Ausgabe, Göttingen 2007, vol. 12, pp.
120-125.
5 J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari 20032, p. vii.
6 Ivi, p. 5. Su questi temi cfr. S. Petrucciani, L’Illuminismo “autocritico” di
Jürgen Habermas, in «Hermeneutica», 2010, pp. 47-66.
vii
laici e progressisti che non avevano mai amato l’Illuminismo, e
certamente del tutto vano nel caso del mondo cattolico.
Il clamoroso successo mediatico di quelle pagine e più in gene-
rale della querelle sul post-moderno che anche ad esse – ma non
solo ad esse – si ispiravano è infatti stato colto dal mondo catto-
lico come un via libera a un’insperata opera di aggiornamento di
antiche, rabbiose polemiche contro i Lumi, rimesse a nuovo con
il ricorso continuo e ossessivo alle raffinate argomentazioni post-
moderniste e alle pagine più controverse e discutibili di Adorno e
di Horkheimer. Non c’è ormai un solo parroco di campagna me-
diamente colto o uno studente universitario cattolico, per quanto
sprovveduto, che non sappia far tesoro di apologia delle tesi della
scuola di Francoforte, attingendo ai francofortesi per inchiodare
il povero Voltaire – per non parlare di Rousseau – alle sue respon-
sabilità nella Shoah e nei totalitarismi più sanguinari.
Ma il frutto più succoso e seducente in questa direzione, per via
della sua sottile ed elegante struttura intellettuale, era maturato sin
dal 1980 con un puntuale intervento dell’allora cardinale Joseph
Ratzinger. Si trattava niente meno che di una proposta di teologiz-
zazione dell’Illuminismo il cui fine era di impedirne la fatale dege-
nerazione totalitaria. Sulla base di una franca ed entusiastica con-
divisione delle analisi di Adorno e Horkheimer circa l’inevitabile
tralignamento totalitario della ragione illuministica allorché essa si
trasforma in autonoma ragione «positiva del pensiero funzionale»,
l’attuale pontefice candidava la Chiesa del nuovo millennio post-
moderno, forte del suo rinnovamento teologico, a trovare un’ine-
dita missione salvifica sospendendo «nella dialettica dell’Illumini-
smo [...] le condizioni dell’Illuminismo»7, salvandone la prima fase
dialettica, quella emancipatoria settecentesca, e condannandone
le derive posteriori. In tal modo la Chiesa non solo si proclamava
di fatto erede legittima di quella prima fase, ma si attribuiva il
compito di evitare il dialettico capovolgimento del progresso della
ragione in quel terrifico futuro post-moderno già annunciato dal
totalitarismo del secolo scorso e che appariva inevitabile qualora
si fosse continuato a voler escludere Dio dalla storia.
7 Cfr. il saggio Teologia e politica della Chiesa in J. Ratzinger, Chiesa, ecume-
nismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia, Milano 1987, p. 154.
viii
È in questo contesto teorico, innegabilmente suggestivo, che
ha preso corpo l’inattesa campagna filosofica e storiografica volta
a cristianizzare l’ingombrante Illuminismo dei diritti dell’uomo:
quello della sacrosanta battaglia per la libertà religiosa, la tolleranza
e la neutralità dello Stato, tanto odiato e combattuto invece in
passato da generazioni di papi, vescovi e frati come un’evidente
opera del demonio.
Dimenticando con disinvoltura il rilievo che ebbero per l’Illu-
minismo la tradizione classica, le grandi opere pagane della lette-
ratura greca e latina, la scoperta del Nuovo Mondo, la Rivoluzione
scientifica, Ratzinger non ha mai mostrato alcuna esitazione nel
rivendicare l’esistenza di improbabili radici cristiane dei Lumi,
tacendo di questi ultimi l’autentica dimensione di autonomia e di
forte discontinuità, che storicamente ne fece una vera e propria
rivoluzione culturale rispetto all’identità moderna dell’Europa:
«L’Illuminismo è di origine cristiana – così sintetizza una peren-
toria affermazione del 2005 – ed è nato non a caso proprio ed
esclusivamente nell’ambito della fede cristiana»8.
Persino il cardinale Camillo Ruini, che pure la storia, quella
vera, la conosce assai bene, ha dovuto seguire l’impegnativa linea
teologico-politica imposta dal nuovo pontefice, annunziando gau-
dio magno una paradossale santificazione di Voltaire: «È pertanto
merito dell’Illuminismo aver riproposto, per lo più in polemica
con la Chiesa, quei valori di razionalità e libertà che trovano ali-
mento nella fede cristiana»9. Come stupirsi allora del crescente
sviluppo e del successo di una storiografia internazionale – so-
prattutto americana, più recentemente10, ma già prima tedesca,
8 J. Ratzinger, L’Europa nella crisi delle culture, in «Il Regno-documenti»,
9, 2005, p. 218.
9 Prefazione di Ruini a J. Ratzinger Benedetto XVI, Fede, ragione, verità e
amore. La teologia di Joseph Ratzinger. Un’antologia, a cura di U. Casale, Torino
2009, p. 6. Il curatore dell’imponente e meritevole antologia, don Casale, non
esita nel risvolto di copertina ad affermare che «Ratzinger ha proposto un illu-
minismo sinonimo di intelligenza e di ricerca della verità, espressione dell’uomo
che, grazie alla conoscenza della verità di cui è capace, acquisisce sia la propria
dignità “trascendente”, sia il proprio potere critico e demistificatore, entrambi
sinonimi di libertà».
10 Cfr., ad esempio, D. Sorkin, The Religious Enlightenment. Protestants,
Jews, and Catholics from London to Vienna, Princeton 2008. Sull’Illuminismo
cattolico v. anche il recente A Companion to the Catholic Enlightenment in
ix
francese e italiana – decisa ad esplorare e a imporre lo studio della
katholische Aufklärung nelle università del mondo intero?
È forse inutile sottolineare quanto questo archetipo astratta-
mente filosofico, degno della migliore tradizione della teologia
politica agostiniana impastata sapientemente con la teoria hege-
liana del “superamento” – che ricorre in molti degli interventi
successivi del teologo Ratzinger sino ai giorni nostri, dando forza
e sostanza teorica anche a importanti documenti ufficiali della
Chiesa11 –, stia creando non pochi problemi nella ricerca della
verità storica, costretta quasi sempre a piegarsi alle forti torsioni
teologiche indicate dalle gerarchie.
Nel saggio che segue – come pure altrove, forse con maggiore
agio di analisi12 – abbiamo cercato di spiegare che quell’inattesa
teologizzazione dei Lumi e più in generale lo sforzo di cristianizzare
in qualche modo la modernità non sono stati affatto una brillante
trovata da liquidare con un sorriso, come è stato fatto sino ad oggi,
Europe, a cura di U.L. Lehner e M. Printy, Leiden-Boston 2010. Com’è noto,
nella Germania cattolica l’Illuminismo è stato rivalutato solo nei primi decenni
del Novecento ad opera dello storico della Chiesa Sebastian Merkle, nel sag-
gio Die katholische Beurteilung der Aufklärungszeitalters, del 1911, ora in Id.,
Ausgewählte Reden und Aufsätze, Würzburg 1965.
11 Cfr. ad esempio l’enciclica Spe salvi, dove forte è l’influenza delle idee
di Guardini e ricorrenti sono i suoi espliciti riferimenti a Bacone, ad Adorno
e all’Illuminismo. Sempre all’Illuminismo e ai diritti dell’uomo sono dedicate
pagine significative che denunciano inopinatamente il «concetto anarchico di
libertà» del povero Rousseau, accusato di aver portato la Rivoluzione francese
a diventare «inevitabilmente una dittatura sanguinaria», stigmatizzando le sue
gravi responsabilità nell’aver trasformato – attraverso la «radicalizzazione della
tendenza individualistica dell’illuminismo» – l’aborto in un diritto di libertà
delle donne (cfr. J. Ratzinger, Libertà e verità, in Id., Fede, ragione cit., pp. 537
e sgg.). Inutile dire che ogni riferimento alla verità storica è puramente casuale.
Rousseau, oltre a essere un fervente credente, era pure contrario all’aborto.
Sempre sulla «dialettica dell’età moderna» di Adorno, costantemente citata con
favore neanche fosse il vangelo, cfr. ivi, La sacralità della vita umana, pp. 551 e
sgg. Più in generale su questi temi, e in particolare sul continuo ricorso alle tesi
di Adorno e Horkheimer e alla riflessione di H. Staudinger, Christentum und
Aufklärung, in «Forum Katholische Theologie», 6, 1990, pp. 192-206, cfr. J.
Ratzinger, Svolta per l’Europa? Chiesa e modernità nell’Europa dei rivolgimenti,
Cinisello Balsamo 1992, pp. 140 e sgg.
12 Mi permetto di rinviare al capitolo Postmoderni e anti-illuministi: dal
confronto tra Cassirer e Heidegger alla katholische Aufklärung di Benedetto XVI,
in V. Ferrone, Lezioni illuministiche, Roma-Bari 2010, pp. 53 e sgg.
x