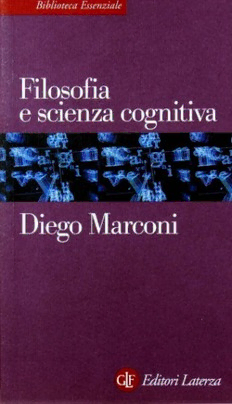Table Of ContentFilosofia
urirdirmadtt
Tito Magri
VOLUMI PUBBLICATI
Mauril:io Ferraris-L'ermeneurica
Salvatore Vcca-La fllosofìa politica
Eva Picardi -Le rcorie del significato
Michele Di Francesco -La coscienza
Piergiorgio Donarelli -La filosofia morale
Diego Marconi
Filosofia
e scienza cognitiva
© 2001, Gius. I.acerza &. Fisli
Prima edizione 2001
Secondaedizione2003
Proprieri.lecterariariservata
Gius. laterza & Fisli Spa,
Roma-Bari
Finito di stampare
nel f"ebbraio 2003
Poligrafteo Dehoniano -
Stabilimento di Bari
per conto della
Gius. Laterza & Fi&li Spa
CL20-6344-1
ISBN 88-420-6344-4
~viemalariproduziOlle,anche
paniale. con qualsiasi mezzo
effenuata,com.presalal"otocopia,
anchetdU50incernoodidauico.
Perlalesgeimlianalafotocop.ia
i lecita solo per uso personale ptmhl
,.,t!.zNmggii'•HHr~.Quindiosni
Cotocopiacheevitil"acquino
diunlibloèilleciraeminaccia
lasoprawivenzadiunmodo
diuasmeuerelaconoscenza.
ChiCorocopiaunliblo,chirneuea
disposiziOAeimeniperCotocopiare,
chi comunque liworisce quesm
pr.llicacommeneunfurtoeopera.
aidanniddlacultun..
Filosofia e scienza cognitiva
RJNGRAZIAMENTI Vari amici e colleghi hanno letto singole
parti di questo libro, aiutandomi a correggere errori e a mi
gliorare l'esposizione: Marilena Andronico, PaoloCasalegno,
Michele Di Francesco, Alfredo Paternoster, Gualtiero Picci
nini, Alberto Voltolini. Più di tutti voglio ringraziare Ema
nuela Scribano, che ha cercato di limitare gli effetti più per
versi della mia impermeabilità alla storia della filosofia.
La ricerca che ha condotto a questo libro si è svolta nel
l' ambito di due programmi di ricerca di interesse nazionale:
<<Filosofia analitica: storia, tendenze, problemi attuali» (1997-
1998; coordinatore D. Marconi) e «Conoscenza e cognizione»
(1999-2000; coordinatore P. Parrini).
li libro è dedicato agli amici del seminario «Mente e lin·
guaggio}) di Vercelli: Paolo, Michele, Alberto, Alfredo.
Videa di scienza cognitiva
l.«Matrix»
Nel film Matrix di Andy e Larry Wachowski (1999) si imma
gina che gli uomini siano stati sconfini, in una guerra disastro
sa, da una popolazione di macchine superintelligenti, che ora
li tiene in vita per estrarne l'energia che consente alle macchi
ne stesse di funzionare. La vita in questione-quella degli uo
mini e delle donne-è una sorta di sussistenza puramente ve
getativa, che sostiene però un'attività mentale in tutto corri
spondente a una vita 'normale': nella loro mente, gli esseri
umani si muovono, mangiano, lavorano e interagiscono tra lo
ro nei modi consueti. Ma nulla di tutto ciò awiene veramente:
l'illusione di vita-anzi,le molte illusioni coordinate tra loro
è opera di un programma infinitamente complesso, Matrix,
creato e gestito dalle macchine e 'fruito' dagli esseri umani, che
sono connessi al programma attraverso fLli e cavi la cui funzio
ne (owiamente) resta misteriosa. Alcuni esseri umani sono
riusciti a sconnettersi dal programma, da cui escono e in cui
rientrano a loro piacimento e che anzi sono divenuti capaci di
modificare entro certi limiti, e perseguono una loro lotta di li
berazione, impari ed eroica, scontrandosi con le macchine sia
nella realtà 'vera', sia nella realtà virtuale prodotta da Matrix
(vittorie e sconfitte virtuali e mentali hanno però effetti reali e
corporei, perché «Senza la mente, il corpo non può vivere»).
Molte delle idee dd fdm non sono nuove. L'incubo di una
ribdlione degli artefatti e di una loro possibile supremazia sul
genere umano risale agli albori della tecnologia. Già il Golem
di Rabbi Ju dah Loew ben Bezael combinava non pochi guai
(Tagliasco 1999, pp. 197 -198). Non meno antica è l'ipotesi che
il mondo e b vita abbiano consistenza solo mentale («La viu è
sogno»), sia che si tratti di una nostra autonoma elaborazione,
come ndla posizione filosofica detta 'solipsismo', sia che qual
con altro-Dio, una potenza malvagia, o persino una farfalla
sia l'autore della complessa fantasia che la nostra mente è in
dotta a scambiare per realtà. A questa seconda variante Carte
sio diede dignità filosofica, immaginando che un genio mali
gno e potente lo ingannasse, imponendo alla sua mente ogni
sorta di illusioni: «il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suo
ni c tutte le cose esterne che vediamo» (Cartesio 1641, p. 670).
È invece meno antica, per ovvie ragioni, l'ipotesi che l'il
lusione sia opera di un programma di computer: che l'esecu
zione di un programma (s'intende, di complessità fantasma
gorica) venga fruita non come rappresentazione della realtà,
o sua simulazione più o meno convincente, ma semplice
mente come la realtà di cui noi stessi facciamo parte. A dire
il vero, anche questa trovata di Matrix ha un precursore filo
sofico. All'inizio degli anni Ottanta, il fùosofo americano Hi
lary Pumam aveva immaginato che noi esseri umani fossimo
in realtà cervelli senza corpo immersi in un bagno biologico:
le nostre terminazioni nervose erano connesse a un supercal
colatore, che trasmetteva al cervello l'illusione completa di
una vita normale. «Sembra che ci siano persone, oggeui, il cic
lo ecc.; ma in realtà tutto ciò che la persona (voi stessi) espe
risce è il risultato di impulsi elcmici trasmessi dal computer
alle tcrminazioni nervose)) (Putnam 1981, p. 6).
Come già Cartesio, anche Putnam aveva formulato la sua
ipotesi solo per confutarla: secondo lui, era possibile dimo·
strare che non siamo cervelli immersi in un bagno biologico,
e che c'è davvero il mondo, persone oggetti e cielo, e non so·
lo le stimolaziom dei nostri centri nervosi prodotte da un
computer. Se la dimostrazione di Putnam sia completamente
convincente, è tuttora controverso; è invece fuor di dubbio
che né l'esperimento mentale dei cervelli ingannati dal com
puter, né l'analoga fantasia rappresentata in Matrix sarebbe-
ro venuti in mente a qualcuno se del nostro mondo intellet
tuale non facessero parte, da alcuni decenni, certe idee che si
sono dimostrate straordinariamente potenti e suggestive:
idee che riguardano il rapporto tra il computer e la mente.
La prima di queste idee va sotto il nome di 'realtà virtua
le'. Gli sviluppi della computer gTtJphics, resi familiari da mol
ti film di cui il più noto è forse Jurassic Park di Steven Spiel
berg (1993 ), hanno consentito di simulare con grande verisi
miglianza immagini tridimensionali che l'occhio umano non
riesce a distinguere da 'vere' immagini, fotografiche, cinema
tografiche o televisive. I dinosauri di juTtJssic Park non sono
robot fo[Qgrafati, ma 'disegni' animati, realizzati dal compu
ter e abilmente integrati con le 'vere' immagini degli anori
umani. Fin qui, non parliamo ancora di realtà virtuale ma sol
tanto di simulazione grafica di immagini. Sennonché, è pos
sibile coordinare queste simulazioni a certe nostre attività
percettive e motorie in modo da ottenere quegli effetti di im
mersione e integrazione che sono caratteristici del nostro rap
porto col mondo reale. In primo luogo, è possibile far coin
cidere l'immagine simulata col campo visivo dell'utente, che
a quel punto non vede più l'immagine in uno schermo e lo
schermo come oggetto tra altri oggetti del mondo reale, ma
vede soltanto l'immagine simulata dal computer; si ottiene
così un primo effetto di immersione (il mondo reale, infatti,
ci appare anzitutto come il contenuto del nostro campo visi
vo: il mondo è ciò che di volta in volta vediamo). In secondo
luogo, è possibile far determinare le proprietà dinamiche del
le immagini dai movimenti dell'utente: se l'utente si muove
all'indietro l'immagine diventa più piccola, se sposta la testa
a sinistra l'immagine si sposta e destra, e così via per tutti gli
aggiustamenti che caratterizzano, nella reahà, il nostro rap
porto di integrazione col mondo. La simulazione può essere
completata con proprietà tattili, acustiche, olfattive ecc. Di
venta cosl possibile, ad esempio, spostare un oggetto toccan
dolo Un realtà, modificare l'immagine muovendo una mano,
i cui movimenti sono comunicati al computer attraverso un
'guanto'). Si ottiene, in altre parole, una simulazione comple
ta di un frammento di realtà: per esempio una stanza ammo-