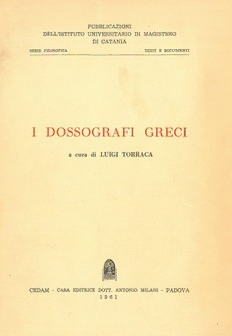Table Of ContentPUBBLICAZIONI
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO
DI CATANIA
SERIE FILOSOFICA TESTI E DOCUMENTI
I DOSSOGRAFI GRECI
a cura di LUIGI TORRACA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA
l 9 6 l
PUBBLICAZIONI
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO
DI CATANIA
SERIE FILOSOFICA - TESTI E DOCUMENTI
N. 5
I DOSSOGRAFI GRECI
tradotti da LUIGI TORRACA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILAN! - PADOVA
l 9 6 l
PROPRIETA' LETTERARIA
@ Copyright 1961 by CEDAM - PADOVA
Stampato in Italia - Printed in Italy
Tip. Art. di ALDO PALOMBI - Via Vincenzo Sartori, 80 - Roma - Tel. 62.97.68
All'Eilade antica,
luce e conforto del mio spirito.
PREFAZIONE
Il testo greco dei Dossografi, su cui ho condotto la mia tradu
zione, è: Doxographi Graeci. Collegit, recensuit, prolegomenis in
dicibusque instruxit H. DIELS, Editio iterata, Berolini et Lip
siae, 1929.
Ogni volta che mi sono allontanato dal testo del Diels, ne ho
dato ragione neLle annotazioni critiche. Ho sempre cercato di tra
durre fedelmente, interpretando il meno possibile. E' noto che tra;..
durre testi filosofici antichi è cosa ardua e rischiosa, perché la tra
duzione è continuamente insidiata dalla suggestiva tentazione di
ripensare filosoficamente il testo e di volgerlo in lingua moderna
secondo una ricostruzione soggettiva: soggettiva, non solo perché
relativa a colui che traduce, ma anche perché condizionata dalla
categoria storico-culturale a cui il traduttore appartiene.
Ben consapevole di questi limiti, mi sono studiato di rispet
tare, quanto più ho potuto, la verità filologica, ossia l'oggettiva si
gnificazione del documento. Seguendo un processo spirituale à re
bours, ho adeguato la mia anima di moderno all'antico messaggio,
rivestendo. di italiche parole la sapienza ellenica.
Esprimo la mia devota gratitudine al prof. VITTORIO DE FALCO,
maestro incomparabile per rara liberalità e generosa benevolenza.
Non poco debbo a lui: egli ha voluto rivedere attentamente tutta
la traduzione e ricontrollare gli emendamenti apportati al testo
greco.
Ringrazio di tutto cuore il prof. CARMELo OTTAVIANo, al cui sug
gerimento e al cui illuminato mecenatismo è dovuta la pubblica
zione del presente lavoro.
L'AUTORE
7
*
I N T RO D U Z I O N E
E' merito di H. Diels avere resuscitato dall'oblio dei secoli la
memoria di AETIO, dossografo vissuto tra l'età di Augusto e l'età
degli Antonini, come si desume dalla sua stessa opera e dalla for
tuna di questa: nella sezione sull'anima egli riferisce l'opinione
di Senarco, amico di Ario e di Augusto; d'altra parte, nell'età degli
Antonini, i suoi Placita erano già epitomati dal Pseudo-Plutarco.
Restringendo quindi ancor più i termini cronologici, si può as
segnare la sua fioritura al periodo tra la fine del I sec. d. C. e l'ini
zio del II sec. d. C.
Iniziato alla filosofia nella Scuola Peripatetica, Aetio divenne
ben presto un eclettico, secondo il costume intellettuale del tempo,
e non andò mai al di là della mediocrità. TEODORETO di Antiochia
(circa 393 -457 d. C.), vescovo di Cirro, nella sua opera Graecarum
affectionum curatio, composta al più tardi intorno al 437, cita il
suo nome accanto a Plutarco e a Porfirio in tre luoghi: II 95 = P.
G. LXXXIII, col. 856; IV 16 = P. G. vol. cit., col. 908; IV 31 = P. G.
vol. cit., col. 929. La menzione di Aetio, scrittore ormai ignoto nel
V sec. d. C., accanto ai celeberrimi nomi di Plutarco e di Porfirio,
non può essere spiegata in alcun altro modo, se non ammettendo
che i Placita di Aetio siano stati la fonte di Teodoreto. Questi volle
dare credito ed autorità al nome oscuro di Aetio, citando altri due
nomi famosi.
Fonte principale di Aetio sono i cosiddetti Placita vetusta,
raccolta dossografica messa insieme nell'età di Posidonio e di
Ascepiade di Prusa, all'inizio del I sec. a. C. Il compilatore dei
Placita vetusta, a sua volta, attinse largamente alle <I>ucnxwv ~61;oc~
di Teofrasto e ai commenti scolastici alle opere aristoteliche. I rap
porti con Posidonio, numerosi e diretti, dimostrano che egli appar~
tenne alla sua scuola.
* Nella presente introduzione espongo sobriamente i risultati a cui
giunge l'indagine di H. DIELS nei Prolegomena, pp. l-263. Non mancano,
tuttavia, qua e là, mie aggiunte personali.
8
I Placita di Aetio sono la fonte immediata di Teodoreto, come
si è già detto, e di NEMESIO, vescovo di Emesa nella Fenicia, vis
suto tra la fine del IV sec. d. C. e la metà del V sec. d. C.
Nemesio, nel suo libro De natura hominis, collega le teorie
antropologiche dei filosofi greci con la dottrina cristiana. Nell'e
sposizione delle opinioni dei filosofi pagani egli si avvale larga
mente dell'opera di Aetio.
La raccolta di Aetio fu compendiata dall'autore dei cinque
libri De placitis philosophorum, dalla tradizione attribuiti a Plu
tarco, e da Stobeo.
L'e p i t o m e p se u d o-p l uta r c h e a è certamente an
teriore al 177 d. C., perché è utilizzata già da ATENAGORA nella Sup
plica per i Cristiani, dedicata intorno al 177 d. C. a Marco Aurelio
Antonino e a Lucio Aurelio Comodo. Essa fu probabilmente com
posta verso la metà del II sec. d. C., quando era ormai diffusa la
moda dei compendi. L'autore divulgò la sua opera sotto il nome
del già famoso Plutarco, per assicurarle un sicuro successo. Ed
il suo inganno riuscì bene: già nel quarto secolo Eusebio credeva
alla paternità plutarchea.
L'opera pseudo-plutarchea ha avuto una straordinaria for
tuna. Molti scrittori hanno attinto ad essa. Nel De providentia di
FILONE (I 2 = p. 11 edit. armen. latin. Aucher) è riconoscibile una
traccia sicura (De placitis I 3). Naturalmente ovvie ragioni cro
nologiche vietano di ammettere che Filone abbia potuto compi
lare il Pseudo-Plutarco. Si può quindi pensare che un dotto scriba
abbia aggiunto in margine al luogo citato di Filone il passo men
zionato del Pseudo-Plutarco: la nota marginale è poi penetrata
nel testo filoneo.
Nell'età di Costantino EusEBIO di Cesarea riportò con grande
fedeltà molti passi dell'epitome pseudo-plutarchea nei libri XIV
e XV della sua Praeparatio evangelica. Il testo pseudo-plutarcheo
usato da Eusebio è esente dalle corruttele della tradizione bizan
tina, ma già in alcuni luoghi presenta le stesse lacune e gli stessi
errori dei nostri codici. Tuttavia, ancora dopo Eusebio, nella cui
età si va costituendo il testo conservato dalla nostra tradizione,
esistevano esemplari più integri e corretti. A questi attingono Ci
rillo e il Pseudo-Galeno.
CIRILLO, patriarca di Alessandria dal 412 al 444 d. C., poté ser
virsi dei libri della Biblioteca del Serapeo, unica superstite delle
biblioteche alessandrine : si spiega quindi come egli potesse avere
9
a disposizione un ottimo esemplare. L'epitome pseudo-plutarchea
è utilizzata nel libro II dell'opera Contra Iulianum. Nel sec. XI
d. C. Cirillo e Teodoreto saranno la fonte di MICHELE GLICA (1).
La Historia philosopha, tramandata sotto il nome di Galeno,
fu composta intorno al 500 d. C. L'errata attribuzione a Galeno è
dovuta forse ad una confusione avvenuta nelle scuole, dove l'ope
retta, che appartiene al genere degli tl7tO!J.V~!J.<X."t'oc crxo'Atx&, era stu
diata con le opere autentiche del celebre medico. Il Pseudo-Galeno,
nei capitoli 3-20, 22 e 23 compila un'epitome di tendenza stoica,
redatta tra l'età di Seneca e l'età degli Antonini. La stessa fonte
fu utilizzata da SESTO EMPIRico (Pyrrh. H. II 14. 15; II 81 sq.; II
100 sq.; II 157; III 30-32; III 38 sqq.; III 64 sqq.). Nei capitoli 5, 20
e 21 sono riconoscibili alcune tracce dell'epitome pseudo-plutar
chea, che dal capitolo 25 alla fine è fonte unica, fedelmente, ma
non sempre intelligentemente seguita.
Nella prima metà del VI sec. d. C. utilizzò l'epitome GIOVANNI
Lroo nel De mensibus (III 8).
Il Pseudo-Plutarco è ancora la fonte della Cohortatio ad Gen
tiles, attribuita a Giustino. L'età di composizione della Cohortatio
non può essere determinata con assoluta sicurezza, ma certamente
non è lontana dai tempi di Atenagora.
In età incerta - forse sul finire del II sec. d. C. - attinse
all'epitome il commentatore di Arato, ACHILLE, nel lessico Suda
detto Stazio e confuso con il romanziere. Del suo commento ad
Arato - dcr<X.ywy~ - abbiamo degli estratti sotto il titolo Èx "t'cilv
·AxtÀÀé:wç 7tpoç dcr<X-ywy~v dç "''<i 'Ap&"t'ou ~<X.tv6!J.eV<X.. Sono pub
blicati in D. PETAvrus, Uranologium, Paris, 1630.
Dopo il VI sec. d. C. la memoria dell'epitome pseudo-plutarchea
sembra estinguersi in Grecia, ma rifiorisce presso gli Arabi.
Nel IX sec. d. C. QosTÀ IBN LuQÀ tradusse in arabo i Placita.
Da questa versione MuHAMMED IBN IsHÀQ trasse degli estratti.
Circa un secolo dopo il cosidetto ScHAHRASTANius utilizzò i
Placita.
Presso i Bizantini l'epitome pseudo-plutarchea è usata da
MICHELE PSELLO (2) (seconda metà dell'XI sec. d. C.), da GIOVANNI
TZETZES (3) (fine del XII sec. d. C.), da uno scoliasta di Platone
(l) A nn. I p. 39. 40 B; II p. 247, 4-7 B.
(2) De omnif. doctr. c. 81. 83. 86.
(3) In Iliad. p. 67, 28 H.; In Hesiod. op. p. 66 Bas.
10