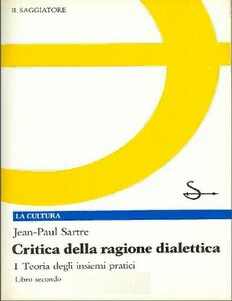Table Of ContentCome tutti i più suggestivi libri di filosofia, anche il primo volume
della Critica della ragione dialettica di Sartre ha una struttura da
poema cosmogonico: i temi iniziali, ancora ravvolti in se stessi,
sprigionano via via la loro forza espansiva fino a dispiegare in una
vasta configurazione una nuova e più ricca visione del mondo. Qui, è
il confronto con il marxismo aperto dal più celebrato maestro del
pensiero esistenzialista a inaugurare l’indagine con Questioni di
metodo. L’incontro segna una tappa decisiva nell’evoluzione della
filosofia e della cultura contemporanea, una sorta di «prolegomeni
ad ogni antropologia futura» ove si prefigura la costituzione di una
società umana interamente libera e autonoma.
Jean-Paul Sartre (Parigi 1905-1980) è uno dei grandi
protagonisti della cultura del Novecento. Capofila
dell’esistenzialismo francese, ha svolto un ’intensa attività di filosofo,
romanziere, saggista, drammaturgo. Nel 1964 nfiutò il premio Nobel
conferitogli per la letteratura. Oltre alla Critica della ragione
dialettica, il Saggiatore ha pubblicato numerose sue opere: Che
cos’è la letteratura? (1960), Le parole (1964), Baudelaire (1964),
L’Essere e il Nulla (1965), Santo Genet, commediante e martire
(1972), Autoritratto a settant'anni (1976), L’idiota della famiglia
(1977), Materialismo e rivoluzione (1977), L’universale singolare
(1980).
Jean-Paul Sartre
Critica della ragione dialettica
I Teoria degli insiemi pratici
Libro secondo
Traduzione di Paolo Caruso
ISBN 880433819-0
© Librairie Gallimard, Paris 1973
© 1990 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Titolo originale: Critique de la raison dialectique
Prima edizione « La Cultura », novembre 1963
Terza edizione «La Cultura. Nuova serie», il Saggiatore, ottobre
1990
Sommario
LIBRO II: DAL GRUPPO ALLA STORIA
A. Del gruppo.
L’equivalenza della libertà come necessità e della necessità
come libertà.
Limiti e portata d’ogni dialettica realista
B. L’essere-uno viene al gruppo dal di fuori, dagli altri.
E, in questa prima forma, l’essere-uno esiste come altro
C. Nell’interiorità del gruppo il movimento della reciprocità
mediata costituisce l’essere-uno della comunità pratica come
detotalizzazione continua generata dal movimento totalizzante
D. Dell’esperienza dialettica come totalizzazione.
Il livello del concreto, luogo della storia
CRITICA DELLA RAGIONE
DIALETTICA
LIBRO SECONDO
DAL GRUPPO ALLA STORIA
A. Del gruppo. L’equivalenza della libertà come necessità e
della necessità come libertà.
Limiti e portata d’ogni dialettica realistica
La necessità del gruppo, come abbiamo visto, non è data a priori
in un assembramento qualsiasi. Abbiamo invece notato più sopra
che l’assembramento fornisce, con la sua unità seriale (in quanto
l’unità negativa della serie può opporsi come negazione astratta alla
serialità), le condizioni elementari della possibilità per i suoi membri
di costituire un gruppo. Ma ciò rimane astratto. È ovvio che in una
dialettica trascendentale e idealista tutto sarebbe più facile : si
vedrebbe il processo d’integrazione con cui ogni organismo contiene
e domina le sue pluralità disorganiche trasformarsi da solo, al livello
della pluralità sociale, in integrazione degli individui ad una totalità
organica. Così, rispetto agli organismi singoli, il gruppo
funzionerebbe come iperorganismo. Questo ideale organicista lo si è
sempre visto rinascere come modello sociale del pensiero
conservatore (s’è opposto, sotto la Restaurazione, all’atomismo
liberale; ha tentato, dopo il 1860, di dissolvere le formazioni di classe
in seno ad una solidarietà nazionale). Ma sarebbe assolutamente
inesatto ridurre l’illusione organicista alla funzione di teoria
reazionaria. In realtà, è facile accorgersi che il carattere organico del
gruppo - cioè la sua unità biologica - si svela come un certo
momento dell’esperienza. Per noi che affrontiamo il terzo stadio
dell’esperienza dialettica, la struttura organica è anzitutto
l’apparenza illusoria e immediata del gruppo in quanto nasce nella
sfera pratico-inerte e contro quest’ultima.
Marc Bloch ha mostrato in due opere notevoli come nel secolo
XII, ed anche prima, la classe nobile, la classe borghese e la classe
dei servi - per limitarci a queste - avessero un’esistenza di fatto se
non di diritto. Nel nostro linguaggio diremo che erano dei collettivi.
Ma gli sforzi ripetuti di borghesi arricchiti, a titolo individuale, per
integrarsi alla classe nobile, provocano l’irrigidimento di quest’ultima,
che passa da uno statuto di fatto allo statuto giuridico; con
un’impresa comune, impone condizioni draconiane a chi vuole
entrare nella cavalleria, onde tale istituzione mediatrice diventa
organo selettivo. Sennonché, in pari tempo, essa condiziona la
coscienza di classe dei servi. Fino al momento in cui l’unificazione
giuridica dei castellani non è realizzata, ogni servo considera la
propria situazione come un destino particolare e la vive come un
complesso di relazioni umane con una famiglia di proprietari terrieri,
vale a dire come un accidente. Ma ponendosi per sé, la nobiltà
costituisce ipso facto la servitù in istituzione giuridica e rivela ai servi
la loro intercambiabilità, la loro comune impotenza e i loro interessi
comuni. Questa rivelazione è uno dei fattori che condizioneranno le
rivolte contadine nei secoli seguenti.
L’esempio che abbiamo fatto ha solo il fine di mostrare come, nel
processo storico, una classe di sfruttamento, chiudendo i rapporti
con il nemico e prendendo coscienza di se stessa come unità
d’individui solidali, riveli alle classi sfruttate il loro essere materiale
come collettivo e come punto di partenza di un tentativo continuo per
stabilire fra i suoi membri rapporti vissuti di solidarietà. Ciò non ha
nulla di sorprendente : in quella quasi-totalità inerte e percorsa
senza pausa da enormi sussulti di controfinalità che è la collettività
storica, vale la seguente legge dialettica : la costituzione di un
gruppo (sulla base, beninteso, di condizioni reali e materiali) come
insieme di solidarietà, ha la conseguenza dialettica di negare il resto
del campo sociale e, perciò, di suscitare in tale campo, in quanto
viene definito come non-raggruppato, le condizioni proprie ad un
raggruppamento antagonista (tutto ciò fondato sulla penuria e
all’interno di regimi dilaniati). Ma qui soprattutto importa il fatto che,
dall’esterno, i nonraggruppati si comportano nei confronti del gruppo
ponendolo, con la loro praxis, come una totalità organica. Così ogni
nuova organizzazione collettiva trova il suo archetipo in qualunque
altra più antica, poiché la praxis come unificazione del campo
pratico, riduce oggettivamente i rapporti del gruppo-oggetto.
E' sorprendente che le nostre condotte più elementari si
rivolgano ai collettivi esterni come se fossero organismi. La struttura
dello scandalo, per esempio, è per ciascuno quella di un collettivo
ripreso in totalità : ciascuno, a teatro, davanti a ogni replica d’una
scena che giudica scandalosa, è in realtà condizionato dalla
reazione seriale dei vicini, onde lo scandalo è l’Altro come ragione di
una serie. Ma, le prime manifestazioni dello scandalo, appena hanno
luogo (alludo ai primi atti di chi agisce per gli
Altri in quanto è Altro da sé) determinano l’unità vivente della sala
contro l’autore, per il semplice fatto che il primo manifestante con la
sua unità di individuo realizza questa unità per ciascuno nella
trascendenza. Resterà ancora in ciascuno una contraddizione
profonda perché tale unità è quella di tutti gli Altri (compreso lui
stesso) in quanto Altri e grazie ad un Altro : il manifestante non ha
rivelato od espresso l’opinione comune; ha presentato, nell’unità
oggettiva di un’azione diretta (grida, insulti, ecc.), quel che non
esisteva ancora per ciascuno se non come l’opinione degli Altri,
ossia come la loro unità alterna e seriale. Ma non appena lo
scandalo viene raccontato e commentato, diventa, agli occhi di tutti
coloro che non vi hanno assistito, l’apparizione di un avvenimento
sintetico che conferisce unità provvisoria di organismo al pubblico
che assisteva quella sera allo spettacolo.
Tutto è chiaro se situiamo i non-raggruppati che si rivelano come
collettivo per la loro impotenza nei confronti del gruppo che svelano.
Nella misura stessa in cui il gruppo, tramite l’unità della sua praxis, li
determina nella loro inerzia disorganica, essi colgono i suoi fini e la
sua unità attraverso la libera unità unificante della loro praxis
individuale e sul modello di quella libera sintesi che è
fondamentalmente la temporalizzazione pratica dell’organismo. Nel
campo pratico, infatti, ogni molteplicità esterna diventa, per ogni
agente, l’oggetto di una sintesi unificante (e abbiamo già visto che il
risultato di questa sintesi è di dissimulare la struttura seriale degli
assembramenti); ma il gruppo che unifico nel campo pratico sorge,
in quanto gruppo, come già unificato, vale a dire come strutturato da
un’unità che per principio sfugge alla mia unificazione e la nega (in
quanto è praxis che mi respinge nell’impotenza). Questa libera unità
attiva che mi sfugge, appare come la sostanza di una realtà di cui ho