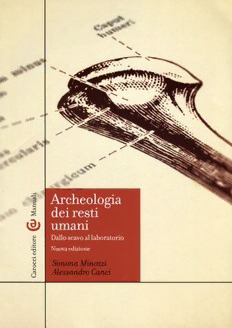Table Of Content@
Carocci editore Manuali
Il volume, in una nuova edizione riveduta e aggiornata, si propone come "guida
da campo" per archeologi ed antropologi che devono confrontarsi con resti
scheletrici umani nel contesto di uno scavo archeologico. Vengono trattate,
in modo sintetico ma esaustivo, le metodologie utili per lo scavo e per lo studio
dei resti umani rinvenuti in sepolture a inumazione e a cremazione.
I principali argomenti riguardano la tafonomia e la diagenesi, la determinazione
del sesso e dell'età alla morte, l' osteometria, l' odontologia, la paleopatologia,
la ricostruzione delle attività fisiche e l'analisi dei resti cremati. Completano
il quadro cenni di anatomia scheletrica e dentaria, metodi per il restauro
e la conservazione e applicazioni delle moderne indagini chimiche
e biomolecolari in antropologia.
Il libro è dunque un utile compendio per lo studio bioarcheologico
e per la ricostruzione delle condizioni di vita e di salute delle popolazioni umane
del passato.
Simona Minozzi, antropologa, svolge attività didattica e di ricerca nella Divisione
di Paleopatologia dell'Università di Pisa. Collabora con diverse soprintendenze
archeologiche per lo scavo e lo studio dei resti scheletrici umani. I suoi principali campi
di interesse sono la biologia scheletrica, la paleopatologia e l'antropologia forense.
Alessandro Canci, antropologo fisico, insegna Bioarcheologia nelle Università di Padova
e di Udine e nella Scuola di Specializzazione Triateneo in Archeologia di Udine, Trieste
e Venezia. Ha partecipato a missioni di scavo archeologico nazionali ed internazionali
in Sudan, Siria, Turchia e Kurdistan iracheno.
€ 26,00
9
Ai nostri genitori
l lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
Corso Vittorio Emanuele 11, 229
00186 Roma
TEL. 06 42 81 84 17
FAX 06 42 74 79 31
Siamo su:
www.ca rocci.it
www.facebook.com/caroccieditore
www.twitter.com/caroccieditore
Simona Minozzi Alessandro Canci
Archeologia
dei resti umani
Dallo scavo al laboratorio
Nuova edizione
Carocci editore
Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di
questo libro, in particolare: Paola Catalano e Walter Pantano per la collaborazione
nella stesura del CAP. 6; Gino Fornaciari per la realizzazione del riquadro 2 del CAP.
10; Francesca Odetti per i disegni dei CAPP. 5 e 10; Claudio Sorrentino per le immagini
dei resti faunistici.
2• edizione, ottobre 2015
t• edizione Università, 2005 (13 ristampe)
© copyright 2015 by Carocci editore S.p.A., Roma
Realizzazione editoriale: Progedit Srl Bari
Finito di stampare nell'ottobre 2015
da Eurolit, Roma
ISBN 978·88-430-7857-8
Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. m della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia,
anche per uso interno
o didattico.
Indice
1. Anatomia scheletrica 11
1. Scheletro assile 14
1.1. Cranio l I. l. Colonna vertebrale l 1.3. Coste e sterno
2. Cinture 22
l.I. Cintura scapolare l l.l. Cintura pelvica
3· Scheletro appendicolare superiore 24
3.1. Omero l p. Radio ed ulna l 3-3-Ossa della mano
4· Scheletro appendicolare inferiore 28
4.1. Femore l 4.l. Patella o rotula l 4·3· Tibia e fibula l 4-4-Ossa del piede
2. l denti 35
1. La struttura dei denti 35
2. Riconoscimento delle diverse categorie dentali 35
l. I. Denti decidui l l. l. Denti permanenti
3. Umano o non umano? 41
4. Dopo la morte: dal cadavere allo scheletro 49
5. Diagenesi 55
1. Suoli ed acque 55
2. Piante 57
3· Funghi e batteri 59
4· Animali 59
4.1. Insetti ed altri invertebrati l 4.l. Roditori l 4·3· Ungulati l 4-4-Carnivori
6. Tafonomia ed archeologia funeraria 65
1. Sepolture individuali 66
1.1. Modalità di deposizione e connessioni articolari l I.l. Posizione dello scheletro
e connessioni articolari l 1.3. Posizione del cranio l 1.4. Compressione l 1.s. Effetto
parete l 1.6. Misure sul campo
2. Sepolture multiple e collettive 78
3· Sepolture anomale 80
7
Archeologia dei resti umani
7. Lo scavo, il primo intervento ed il restauro 85
di Sara Emanuele
1. Le operazioni sul campo 85
2.. Il kit da scavo 86
3· Esposizione e documentazione 88
4· Il recupero 89
s. go
La pulitura sullo scavo
6. L'assemblaggio "provvisorio" 92
7· Consolidamento e prelievo in blocco 95
8. L'imballaggio 98
8. Lo studio: determinazione del sesso e dell'età alla morte 103
1. Determinazione del sesso nei resti scheletrici 103
1.1. Caratteristiche sessuali del cranio l 1.2.. Caratteristiche sessuali del bacino l 1.3.
Altri distretti scheletrici dimorfici l 1.4. Caratteri metrici discriminanti l 1.s. Deter
minazione del sesso nei resti infantili
2.. Determinazione dell'età alla morte nei soggetti immaturi 111
2..1. Grado di sviluppo ed eruzione dentaria l 2..2.. Dimensioni delle diafìsi delle ossa
lunghe l 2..3. Stadio di saldatura tra epifisi e diafìsi
3· Determinazione dell'età alla morte negli adulti 119
3.1. Determinazione dell'età in base alla dentatura l 3.2.. Saldatura delle suture crani
che l 3-3· Morfologia della sinfìsi pubica l 3-4-Superficie auricolare dell'ileo l 3·S· Strut
tura del tessuto spugnoso dell'epifisi prossimale dell'omero e del femore l 3.6. Metodo
combinato l 3·7· Modifiche dell'estremità sternale delle coste l 3.8. Metodi istologici l
3·9· Alterazioni a carico di diversi distretti scheletrici
g. Lo studio: antropometria 129
1. Principali misure scheletriche 129
1.1. Misure craniche l 1.2.. Scheletro postcraniale
2.. Indici antropometrici 136
2..1. Proporzioni corporee l 2..2.. Indice di dimorfismo sessuale l 2..3. Indice di lateraliz
zazione degli arti
3· La stima della statura 140
10. Ricostruire lo stile di vita e lo stato di salute 145
1. Malattie articolari 145
2.. Traumi 151
3· Malattie infettive 160
4· Anemia ed iperostosi porotica 165
S· Patologie da carenze vitaminiche 168
s.I. Avitaminosi C o scorbuto l 5.2.. Avitaminosi D o rachitismo
8
Indice
6. Anomalie congenite 171
7- T umori 171
7.1. Tumori maligni l 7.2. Tumori benigni
1n
8. Ricostruire l'attività
8.1. Sviluppo delle inserzioni muscolari ed entesopatie l 8.2. Faccette articolari acces
sorie l 8-3-Esostosi auricolare e ipertrofìa dei turbinati
11. l denti nella ricerca antropologica 185
r. Affezioni demo-alveolari 185
1.1. La carie l 1.2. Affezioni del parodonto ed ascessi l !.3· Perdite dentarie l 1.4. Tarta
ro l 1.s. Usura dentaria
2.. Anomalie dentarie 194
2.1. Malposizioni dentarie l 2.2. Anormalità nelle dimensioni dei denti l 2.3. Anoma
lie nel numero dei denti
3- Ipoplasia dello smalto 195
4- Caratteri discontinui dei denti ed implicazioni genetiche 196
12. l resti umani cremati 199
r. L'azione del fuoco sui tessuti 199
2. Alterazioni ossee indotte dal calore 200
3- Gli effetti del fuoco sui denti 205
4· Analisi molecolari, chimiche ed istologiche 206
s- L'esame antropologico dei resti ossei cremati 207
s.I. Le analisi radiodiagnostiche e il microscavo stratigrafico l 5.2. Identificazione dei
resti l H· Analisi ponderale e grado di frammentazione dei resti combusti l S+ Deter
minazione del numero minimo di individui l S·S· Determinazione dell'età alla morte e
del sesso l s.6. Studio paleopatologico nei resti cremati
13. L'analisi chimica dei resti scheletrici 217
di Mary Anne Tafuri
r. Gli elementi in traccia e i primi studi di paleodieta 218
2. Isotopi stabili e paleonutrizione 219
2.1. Carbonio (C) e azoto (N) l 2.2. Metodi di preparazione e indagini isotopiche
3- Isotopi stabili: paleoambiente e mobilità 224
3.1. Stronzio (Sr) l p. Ossigeno (O)
14. Le analisi biomolecolari dei resti scheletrici 227
di Sergio Tofanelli
1. Le proteine 227
9
Archeologia dei resti umani
2.. L'RNA 228
3· Il DNA 228
4· Altri codici 230
5· La difficoltà di interpretare 230
Riferimenti bibliografici 235
Indice analitico 261
l collaboratori 267
lO
1
Anatomia scheletrica
I resti scheletrici umani rinvenuti durante scavi archeologici rappresentano Riconoscere le ossa
un'importante fonte di conoscenza nella ricostruzione delle condizioni di dello scheletro
vita nel passato. Oltre ad informazioni sul sesso e l'età del defunto, talvolta, umano
essi conservano tracce di eventi come le malattie o la tipologia e il grado di
intensità dell'attività fisica praticata, che possono aiutare lo studioso a rico
struire con maggiore dettaglio il periodo della storia umana indagato. Per
questo motivo è importante avere un'adeguata conoscenza dello scheletro
umano, della sua anatomia, delle sue proprietà e delle sue funzioni. Le pagine
che seguono hanno lo scopo di fornire una sintetica descrizione dell'anato
mia dello scheletro con tavole anatomiche che consentono il riconoscimento
di ciascun elemento osseo (Chiarugi, 1937; White, Black, Folkens, 20u).
Sul campo, ben difficilmente ci si confronta con materiale ben conservato e
spesso i resti ossei sono alquanto frammentari e di difficile identificazione.
Si consiglia, quindi, di affiancare questo testo ad un atlante osteologico, con
immagini possibilmente in scala 1:1, in modo tale da poter disporre di un'i
conografia adeguata a risolvere i casi più complessi.
L'osso è un tessuto (termine con il quale si intende un sistema di cellule simili Le funzioni
per struttura e funzione) di tipo connettivo, le cui funzioni principali sono dello scheletro
protettive, meccaniche, emopoietiche e di riserva. Lo scheletro, infatti, for
nisce protezione agli organi interni (ad esempio la scatola cranica protegge
la struttura cerebrale e la gabbia toracica protegge polmoni, cuore ecc.), offre
un supporto al tessuto muscolare, permettendo il movimento del corpo, ed
a organi vitali, come cuore e polmoni, o a strutture ghiandolari (ad esempio
l' ipofisi). Il midollo osseo svolge una funzione emopoietica (origina le cellule
del sangue) ed energetica, poiché è ricco di lipidi. Inoltre l'osso rappresenta
un'importante riserva di calcio e di fosforo che può essere messa a disposizio
ne dell'organismo in caso di necessità.
Il tessuto osseo è composto per il 95% da una matrice extracellulare, mentre il
restante 5% è rappresentato da cellule chiamate osteociti immerse nella matri
ce. Circa un terzo della matrice dell'osso è costituito da fibre collagene; il resto
è una miscellanea di sali di calcio, principalmente fosfato di calcio (o idrossia
patite) ed in minor misura carbonato di calcio.
11