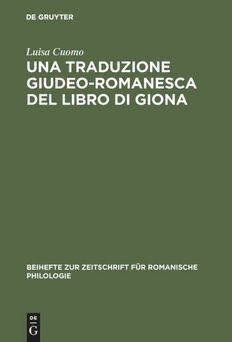Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
FORTGEFÜHRT VON WALTHER VON WARTBURG
HERAUSGEGEBEN VON KURT BALDINGER
Band 215
LUISA CUOMO
Una traduzione giudeo-romanesca
del libro di Giona
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1988
A Jossi, Hannäh, Tamär e Dinäh
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Cuomo, Luisa:
Una traduzione giudeo-romanesca del libro di Giona / Luisa Cuomo. — Tübingen : Nie-
meyer, 1988
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie ; Bd. 215)
NE: Zeitschrift für romanische Philologie / Beihefte
ISBN 3-484-52215-1 ISSN 0084-5396
© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1988
Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses
Buch oder Teile daraus photomechanisch zu vervielfältigen.
Printed in Germany.
Satz: Walter, Tübingen
Druck: Laupp & Göbel, Tübingen 3
Prefazione
Questo studio è dedicato a due gruppi di studiosi: quelli che si interessano di
italianistica e quelli che si dedicano alle <lingue degli ebrei>, o <lingue giudeo-x>
- anche se non è ancora ben chiaro a nessuno cosa si debba intendere, teori-
camente almeno, per <lingue giudeo-x>.
Proprio a questo secondo gruppo il mio lavoro intende offrire una descri-
zione dettagliata e una valutazione linguistica precisa di un testo <giudeo-x> per
eccellenza: una traduzione biblica scritta in lettere ebraiche verso la metà del
XVI secolo. Mi sembra, infatti, che ogni considerazione di carattere teorico e
generale sulle <lingue giudeo-x> debba partire dall'analisi comparata di effettivi
testi linguistici che adempiono ai presupposti minimi di appartenenza a questa
supposta categoria.
Ma a questo secondo gruppo appartengono in genere degli studiosi che non
sono particolarmente esperti di italianistica, mentre lo sono, in certa misura
almeno, di ebraistica.
Viceversa, gli studiosi appartenenti al primo gruppo, gli italianisti, spesso
non sono particolarmente esperti di ebraistica.
Ho cercato di venire incontro alle esigenze dei due gruppi con una soluzione
di compromesso, che, come spesso succede coi compromessi, probabilmente
scontenterà tutti: ma non ne rifiuto per questo la responsabilità! Ho cosi ripor-
tato nel corso della mia analisi notizie, dati, valutazioni che sono probabil-
mente superflui per gli italianisti, e viceversa ho abbondato in spiegazioni sicu-
ramente banali per chi ha un minimo di conoscenze di ebraico ed esegesi biblica
ebraica.
Se non venisse interpretato come un atto di sfacciatagine, potrei dire: «né
che poco vi dia da imputar sono, se quanto posso dar, tutto vi dono».
•
E' un piacere per me ricordare che questo lavoro è stato concepito ed elaborato
nella cornice dei seminari sul giudeo-italiano da me diretti nel Dipartimento
di Lingua e Letteratura Italiane dell'Università Ebraica di Gerusalemme,
durante gli anni accademici 1982-83, 83-84, 84-85. Ringrazio i miei studenti
e i colleghi, a cui ho sottoposto alcuni dei risultati della mia ricerca, per i loro
consigli ed il loro incoraggiamento: mi è gradito qui ricordare in particolare il
V
prof. G. Sermoneta, il prof. G. Goldenberg, il prof. M. Bar Ascer, il dott. I.
Ben Abu, e gli altri amici del Centro di Studi sulle <lingue degli ebrei>, presso
l'Università Ebraica, Centro a cui io stessa appartengo.
Debbo un ringraziamento particolare al prof. U. Vignuzzi, che ha paziente-
mente letto con me una prima stesura del mio manoscritto, dimostrandosi prodi-
go di consigli e suggerimenti, con una gentilezza pari solo alla sua competenza.
*
Last but noi least, la mia gratitudine va alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-
versità Ebraica: in particolare al sig. A. Lang, Segretario della Facoltà, che ha
messo a mia disposizione il word processor con cui ho dattiloscritto questo lavo-
ro; e a mio marito, dott. E. I. Cuomo, Direttore della Biblioteca Giuridica,
che mi ha pazientemente assistito nei momenti di panico durante il lungo e sof-
ferto <dialogo> con questa macchina incantevole e traditrice.
VI
Indice
PREMESSA 1
IL TESTO 9
A. Il testo in lettere ebraiche 9
B. Trascrizione e testo biblico ebraico 12
PROSPETTO GRAMMATICALE 19
A. Grafia
1. Criteri di trascrizione 19
1.2 Grafemi vocalici 20
1.3 Grafemi consonantici 22
1.4 Divisione delle parole 28
B. Fonetica
2. Vocalismo 28
2.1 Vocalismo tonico 28
2.2 Vocalismo atono 34
2.3 Consonantismo 37
2.3.13 Fenomeni generali 41
C. Morfologia
3.1 Nome 42
3.2 Articolo 47
3.3 Aggettivi possessivi 48
3.4 Pronomi personali 50
3.5 Pronomi dimostrativi 51
3.6 Pronomi relativi ed interrogativi 52
3.7 Pronomi indefiniti 55
3.8 Indeclinabili 55
3.9 Forme verbali 56
3.9.1 Presente indicativo 56
3.9.3 Futuro indicativo 59
3.9.4 Passato remoto 59
3.9.5 Imperfetto indicativo 63
3.9.6 Imperativo 63
VII
3.9.7 Infinito 70
3.9.9 Participio passato 71
3.9.10 Metaplasmi di coniugazione 71
3.10 Suffissi nominali 71
3.11 Volgare di traduzione ed ebraico 71
D. Sintassi
4.1 Generalità 73
4.2 Regolarità e razionalizzazione 73
4.2.1 II morfema ebraico 'al 73
4.2.2 II morfema ebraico me- 75
4.2.3 I morfemi ebraici 'et e he- 76
4.2.4 Posizione dell'aggettivo 76
4.2.5 Calco e uso italiano 77
4.2.6 Modi e tempi verbali 78
4.3 La struttura del periodo 79
4.3.1 Calchi sintattici 80
4.3.2 Equilibrio instabile fra la forma ebraica e possibili
esiti italiani non canonici 81
4.3.21 Se interrogativo 81
4.3.22 Infinito preposizionale 81
4.3.23 Modello ebraico, versioni <ebraiche> e versioni <cristiane> . 84
4.3.24 Essere nella predicazione nominale 85
4.3.25 Costruzioni impersonali 86
4.4 La traduzione del Jewish Theological Seminary 86
4.4.1 Affievolirsi dell'entusiasmo di revisione in J. Th. S.:
la traduzione è condotta direttamente sul testo ebraico . .. 87
4.4.2 II morfema ebraico 'al 88
4.4.3 II morfema ebraico me- 89
4.4.4 II morfema ebraico 'et 89
4.4.5 Uso degli articoli 90
4.4.6 Struttura del periodo: valore stilisico delle scelte
di P e di J. Th. S 90
E. Lessico
5.1 Dialettismi, voci letterarie, termini tecnici
di traduzione biblica giudeo-italiani 99
5.2 Tradizione, conservatorismo e innovazione lemmatica
nelle traduzioni bibliche giudeo-italiane 100
5.3 Le scelte lemmatiche di P e quelle del Cantico dei Cantici,
del Maqré Dardeqé, del Galùt Jehudàh e di J. Th. S.:
varianti intertestuali 100
5.4 Le scelte lemmatiche: concordanze intertestuali 104
5.5 Varianti di traduzione intratestuali in P 105
Vili
CONCLUSIONE 107
GLOSSARIO ILI
LISTA DELLE SIGLE CONTENUTE NEL GLOSSARIO ILI
GLOSSARIO 112
INDICE DEI LEMMI EBRAICI 143
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 147
BIBLIOGRAFIA 149
IX
«Melius est autem in divinis libris
transferre quod dictum est licet
non intelligas quare dictum sit, quam
aufferre quod nescias»
«Poiché la proposizione è come un
muro davanti alla lingua dell'origi-
nale, mentre la parola singola è
l'arcata ... Di fronte ad esso si richie-
de, da parte della traduzione, una
fiducia cosi illimitata che, come in
esso lingua e rivelazione, cosi in
essa giungano a fondersi, senza
tensione, letteralità e libertà nella
forma della versione interlineare.»