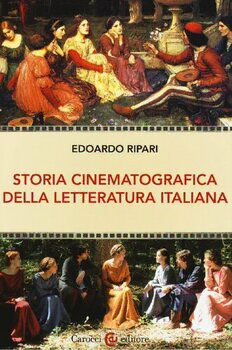Table Of ContentBIBLIOTECA DI TESTI E STUDI/ 1029
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A Michael Papio
Perché realizzare un'opera quando
è così bello sognarla soltanto?
Un allievo di Giotto
I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
Corso Vittorio Emanuele II, 229
00186 Roma
telefono 06 42 81 84 17
fax 06 42 74 79 31
Siamo su:
www.carocc1.1t
www.facebook.com/ caroccieditore
www.twitter.com/ caroccieditore
Edoardo Ripari
Stocriinae matografica
dellleat teirtaatluiraan a
@
Carocci editore
Si ringrazia l'associazione "La Specola di Bolognà'
per aver contribuito al finanziamento di questo volume.
1a ristampa, febbraio 2017
1a edizione, ottobre 2015
© copyright by Carocci editore S.p.A., Roma
2015
Impaginazione e servizi editoriali:
Pagina soc. coop., Bari
Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.
Indice
Premessa
7
Introduzione 8
Attraverso il visibile parlare. Strumenti
14
Medioevo
I.
41
Il Duecento
I.I.
41
Dante Alighieri
1.2. 51
Giovanni Boccaccio
I.
3. 76
Rinascimento
2. 97
Niccolò Machiavelli
2.1. 97
Angelo Beolco detto Ruzante
2.2. 103
Bibbiena, Aretino, Bandello e altre storie scellerate
2.3. 109
Le donne, i cavalier, l'armi, gli amori
2.4. 114
Et in Arcadia ego
2.5. 120
Il Seicento
3. 122
Uno sguardo panoramico
3.1. 122
Croce, Bertoldo e l'eclettismo monicelliano
3.2. 126
Vite illustri di uomini di scienza
3.3. 131
Il Settecento
4. 143
Tra filologia e fantasia
4.1. 143
Carlo Goldoni
4.2. 147
Giacomo Casanova
4.3. 152
INDICE
5. L'Ottocento 159
5.1. Tra letteratura, cinema e storia: il Risorgimento 159
5.2. Ottocento primo 163
5.3. La stagione verista 177
5.4. Scapigliatura e dintorni 190
5.5. Splendori e miserie dell'Italia umbertina 194
6. Il Novecento
210
6.I. Gabriele D'Annunzio
210
6.2. Italo Svevo 218
6.3. Futurismo e dintorni
220
6.4. Luigi Pirandello 224
6.5. Novecento secondo ... e terzo 236
6.6. I libri al cinema 279
Indice degli scrittori e delle opere letterarie
Indice dei film 97
2
Indice dei nomi
Premessa
Era credenza condivisa che i sogni antelucani rappresentassero ciò che stava
accadendo nella realtà, preannunciando talvolta eventi futuri. Così nel sogno
dantesco del nono canto del Purgatorio l' «aguglia» che solleva il poeta "rap
presenta" santa Lucia che conduce il viator dal vestibolo alla porta del secondo
regno oltremondano. Così in un grande film di Federico Fellini, E la nave va,
la principessa Lherimia sogna un'aquila che solleva da un giardino il granduca
Harzock suo fratello, un uomo così corpulento e pesante che l'uccello è costret
to a farlo cadere, «e lui precipita verso la terra in un grande buco» che lo in
ghiotte: profezia di vicina catastrofe.
Ma è possibile sognare l'idea di un libro? A chi scrive, a dire la verità, è ca
pitato, così come è capitato di sorriderne divertito e di non pensarci più. Alme
no fino a quando alcuni amici e colleghi, nell'ascoltare il racconto del sogno, lo
hanno incoraggiato a prendere sul serio l'antica e condivisa credenza sui sogni
antelucani. Vinte le diffidenze dettate dalla ragione, scritta la parola fine al li
bro, a chi lo ha scritto non resta che ringraziare quanti, più coraggiosi di lui, gli
hanno suggerito che in fondo certi sogni sono soltanto l'espressione simbolica
di qualcosa che già conosciamo ( e desideriamo) prima ancora che la ragione ne
abbia preso effettiva coscienza. Per questo ringrazio sentitamente gli amici
Marco Veglia e Mike Papio, i primi narratari dell'esperienza onirica nel corso di
una calda serata dell'agosto bolognese, tra una birra ghiacciata e i caldi ricordi
di fredde sere newyorkesi, vissute a rievocare e progettare nella fumosa atmosfe
ra di McSorley's o del Perfect Pint. E ringrazio il professor Gino Ruozzi e Gian
luca Mori della Carocci, che non sanno ancora dello strano sogno ma hanno
subito creduto nel libro. Anche il professor Giacomo Manzoli ne scoprirà la
vera origine leggendo queste righe: sono certo che i suoi preziosi consigli sareb
bero comunque arrivati a chi scrive anche se avesse saputo prima la verità: per
questo lo ringrazio. Come ringrazio infine, per il loro costante, affettuoso ap
poggio, Angelo Maria Mangini e Francesco Sberlati, che del sogno hanno sor
riso, senza per questo smettere di credere nella necessità di realizzarlo.
Bologna, estate
2015
7
Introduzione
Un'opera letteraria vive ben oltre la stagione del suo successo. Essa respira i se
coli che attraversa e l'attraversano, e si proietta sul nostro tempo arricchendosi
delle proiezioni che il nostro tempo le riversa addosso. La storia delle fortuna
di un classico della letteratura diventa parte essenziale del movimento ermeneu
tico che lo riporta continuamente in un orizzonte d'attesa prossimo, che gli
conferisce significato nuovo e lori-codifica agli occhi del presente nel cammino
mai definitivo della comprensione. Il dovere del lettore non si compie nel col
locare un'opera nelle coordinate spazio-temporali in cui essa ha preso forma, né
si arresta nel marcare l'alterità fra le dinamiche politico-sociali e ideologiche di
un testo e quelle del presente. Un'azione imprescindibile questa, certo, senza la
quale il vero significato della parola scritta si perderebbe nel brusio confuso di
un quotidiano sfuggente, inconsapevole della storia che lo sostanzia e giustifica.
Né il compito del critico letterario si esaurisce nell'altrettanto indispensabile
processo di fusione degli orizzonti che Hans-Georg Gadamer, in Verita e meto
do, ha scoperto connaturato al percorso ermeneutico. Un'opera letteraria, in
breve, resta se stessa ancorandosi al sapore e ai colori del suo tempo, ma insieme
naviga a vele spiegate in un viaggio senza fine che fa tappa nel porto del lettore
e poi riparte, carica di nuovo equipaggio, verso orizzonti lontani e indefiniti.
Molti dei nostri manuali di storia della letteratura chiudono le sezioni de
dicate ai singoli autori e alle loro opere con un paragrafo sulla loro fortuna nel
corso dei secoli. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, essi non si spingono oltre
la constatazione dei fenomeni di influenza, riscrittura e intertestualità che fan
no di un libro il prodotto dei libri che l'hanno preceduto; in altri invece la
storia della fortuna finisce per identificarsi con la storia della critica. Raramen
te i film tratti da un'opera letteraria vengono considerati parte integrante della
sua storia della fortuna, quasi mancasse la consapevolezza che sempre più spes
so è proprio il cinema a consacrare presso il pubblico la percezione del valore di
un libro e del suo autore: è questa lacuna che il nostro volume vorrebbe colma
re. In effetti, chi può negare ormai che dal lontano 1895, data di nascita del ci-
8
INTRODUZIONE
nematografo, anche il testo letterario è cambiato in modo irreversibile, così
come sono cambiati i suoi modi di rappresentazione? Chi può negare, sull'altro
versante, che il cinema stesso si avvale di tecniche di rappresentazione e creazio
ne che gli scrittori hanno sperimentato nel corso dei secoli? Lo ha ricordato
qualche anno fa Cristina Bragaglia, che nel suo libro Il piacere del racconto ha
esplorato gli stretti legami tra narrativa italiana e cinema dall'affermazione di
quest'ultimo agli anni Novanta del secolo scorso1 lo ha ribadito, un lustro più
;
tardi, Giuliana Nuvoli, che nel suo Storie ricreate ha preso in esame alcuni nodi
cruciali del tenace legame tra schermo e pagina scritta, offrendo per la prima
volta un breve quadro diacronico del passaggio dal testo al film a partire dagli
albori della letteratura italiana per giungere ai nostri giorni2. È quest'ultimo
breve quadro che il presente libro ha intenzione di estendere e sviluppare, cer
cando di fornire un panorama quanto più sistematico possibile dell'ormai più
che centenario rapporto fra scrittori e registi, fra cinema e letteratura italiana.
Si tratta, è vero, di un rapporto impari, che sin dall'inizio ha visto il cinemato
grafo corteggiare la letteratura per trovare una sua legittimità agli occhi di uno
spettatore restio a considerarne il valore artistico, mentre gli scrittori manifesta
vano nei suoi confronti una comprensibile ambiguità, ora scorgendovi un peri
coloso rivale, ora invece una mera occasione di guadagno. Fino ad accorgersi,
tuttavia, che la differenza del mezzo non era tale da impedire al nuovo medium
di estendere ed esaltare ciò che invece più accomuna la pagina allo schermo:
quella capacità di "fabbricare storie" che, sin da epoche ancestrali, dai dipinti
rupestri ai videogames, è esigenza consustanziale all'essere umano, non solo per
ché gli consente di lasciare una traccia delle sue esperienze ed emozioni, ma
anche e soprattutto perché, come ha mostrato Jerome Bruner in un suo affasci
nante libro3, è proprio attraverso il racconto e la costruzione narrativa che l' in
dividuo forma il proprio sé e la collettività umana la propria identità. Non è
tanto il linguaggio verbale a distinguere il sapiens da ogni altra specie di homo
apparsa sul pianeta, ma la sua immaginazione, che ci rende i soli animali esisten
ti in grado di parlare di cose che non esistono se non nella nostra stessa imma
ginazione, dando loro forma narrativa: ce lo ricorda Yuval Noah Harari nel suo
straordinario Da animali a dei4
•
La relazione letteratura-cinema è da sempre oggetto di interesse e indagine
1. C. Bragaglia, Il piacere del racconto. Narrativa italiana e cinema (IS95-I990), La Nuova
Italia, Firenze 1993.
2. G. Nuvoli, Storie ricreate. Dall'opera letteraria alfi lm, UTET, Torino 1998.
3.J. Bruner, Lafa bbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari 2002.
4. Y. N. Harari, Da animali a dei. Breve storia dell'umanita, Bompiani, Milano 2014.
9