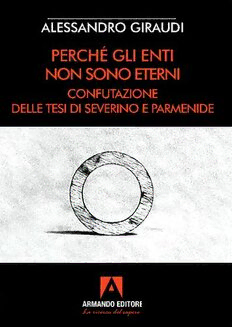Table Of ContentSCAFFALE APERTO
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 11 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 22 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
Alessandro Giraudi
PERCHÉ GLI ENTI NON SONO ETERNI
CONFUTAZIONE DELLE TESI DI
SEVERINO E PARMENIDE
Il nulla è il limite, non è il contrario dell’essere
Prefazione di Marco Gatto
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 33 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
ISBN: 978-88-6992-957-1
Tutti i diritti riservati – All rights reserved
Copyright © 2021 Armando Armando s.r.l.
Via Leon Pancaldo 26, Roma.
www.armandoeditore.it
[email protected] – 06/5894525
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 44 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
Sommario
Prefazione di Marco Gatto:
Una filosofia del limite 7
Avvertenza 13
Capitolo primo
Perché gli enti non sono eterni. Confutazione
delle tesi di Severino e di Parmenide 15
Capitolo secondo
Il divenire è sostanza. Il nulla è il limite
della sostanza 37
Capitolo terzo
La fede nel divenire 49
Capitolo quarto
Sul concetto di essenza 55
Capitolo quinto
Sulla distinzione tra sostanza e accidente 69
Conclusione:
False fondamenta per grandi costruzioni 79
Riferimenti bibliografici 85
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 55 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 66 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
Prefazione
Una filosofia del limite
Con questo ultimo e impegnativo contributo, Ales-
sandro Giraudi aggiunge un ulteriore tassello alla sua
interessante ricerca filosofica, che lo vede impegnato
sul fronte, oggi certamente inusuale e proprio per questo
audace, di una ricostruzione concettualmente rigorosa
di alcuni principi fondamentali del pensiero occidenta-
le. E siccome Giraudi conosce l’arte della dialettica e
sa scavare nell’idea attraverso le armi della logica, ogni
restituzione speculativa, espressa non solo in questo
aureo libretto, ma anche nei contributi più ampi e già
editi, appare nelle forme di un confronto con le filoso-
fie del passato, di un contrasto edificante e rispettoso
con i predecessori, in una prospettiva – anche questa, è
bene ribadirlo, purtroppo non di gran moda, e invece la
sola, forse, davvero utile al disordinato presente che ci
troviamo a vivere – di storia della filosofia e di teoresi
dinamica.
Credo sia da intendersi in questo senso il dibattito
che l’autore allestisce con due voci fra loro lontane nel
tempo, ma legate dal filo doppio della storicità dei con-
cetti. Da un lato, Parmenide, il filosofo dell’Essere, il
cui pensiero ha esercitato, lungo il corso del Novecen-
to, un fascino indiscusso e un vero e proprio magistero
7
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 77 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
per chi ha voluto vedervi la fonte di una certa ontologia
che, con non poche controversie, ha incontrato ragioni
altre, magari legate alla cosiddetta “svolta linguistica”
della postmodernità; dall’altro lato, Emanuele Severino,
un filosofo per molti aspetti solitario, teso a edificare,
nel suo percorso di pensatore, un’originalità che certa-
mente troviamo in pochi altri protagonisti della filosofia
italiana contemporanea: nello stesso tempo, un filosofo
da discutere, da leggere attentamente nella costruzione,
a volte fin troppo voluttuosa, del proprio messaggio e
per questo da relativizzare o, di fronte a certe sinuose
asserzioni, da esorcizzare. Giraudi innesca un confronto
vivissimo con entrambi, ma sa di confrontarsi con il fiu-
me carsico del pensiero ontologico e con tutte le dovute
conseguenze che esso si porta dietro, in termini di risul-
tanti concettuali e in termini di storia filosofica.
Ecco perché, nell’arguta decostruzione concettuale dei
primi due capitoli, nei quali l’autore ribalta l’usuale dicoto-
mia tra l’essere (con questo termine con l’iniziale minusco-
la Giraudi intende ogni singolo ente e la totalità degli enti)
e il nulla, fondando la sua gnoseologia sull’idea di limite
– e riprendendo così una delle direttrici fondamentali del
lavoro depositato ne La visione universale del mondo. Per
la rivoluzione inclusiva (Armando editore, 2019), un testo
che dovrebbe essere letto insieme al seguente –, il lettore
ha sempre l’impressione di trovarsi al centro di una proie-
zione necessaria verso l’oggi o di sentire pressante l’om-
bra lunga di un pensiero che predispone al conflitto con
una porzione importante della filosofia novecentesca, dalla
8
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 88 0055//0033//22002211 1122::3355::4499
presenza di Martin Heidegger fino a quel capitolo fonda-
mentale del pensiero relazionale e dialettico che è L’Essere
e il Nulla di Jean-Paul Sartre. Ciò per un motivo essenzia-
le: i concetti che Giraudi maneggia con tanto acume e con
l’ambizione di trarne una sua riflessione, e non l’ennesimo
saggio di rilettura del lascito altrui, sono l’ossessione co-
stante del pensiero occidentale nella sua ultima fase. Sono,
direi, il centro nevralgico di due grandi pulsioni che conti-
nuano, nonostante i mala tempora, ad animare la riflessio-
ne sul senso dell’esistere e dell’esserci oggi: da un lato, la
pulsione nichilista, che ha trovato nella postmodernità una
sua netta incarnazione, con l’apoteosi di Nietzsche quale
filosofo della crisi e il ritorno di Heidegger quale pastore
dell’Essere, certo, ma anche dell’Essere come Linguaggio;
dall’altro, la resistenza (non potrei chiamarla altrimenti)
dell’antinichilismo, che forse trova proprio in un rinnova-
to, ma minoritario, pensiero dialettico – ovvero in grado di
riproporre la centralità dei nessi, delle categorie e di una
loro organizzazione sistematica – il modo per forzare i
limiti dell’ermeneutica e aprire a nuove possibilità teore-
tiche. Giraudi, a mio parere, è consapevole di rispondere
alle sollecitazioni di questa ultima esigenza e di collocarsi
dalla parte di un pensiero che possa riabilitare la forza del
concetto e di un ragionamento sui fondamenti. E, difatti,
guardando alla sua produzione filosofica, tenta di essere
pensatore di un dinamismo universale, una volta si sarebbe
detto “totalizzante”, estraneo alle lusinghe di un tempo che
ha fatto, al contrario, della disarticolazione e del culto del
frammento una ragione utilitaristica di sopravvivenza.
9
IImmppaaggiinnaazziioonnee GGiirraauuddii__PPeerrcchhéé ggllii eennttii nnoonn ssoonnoo eetteerrnnii ((nnoottee ggiiuussttee))..iinndddd 99 0055//0033//22002211 1122::3355::4499