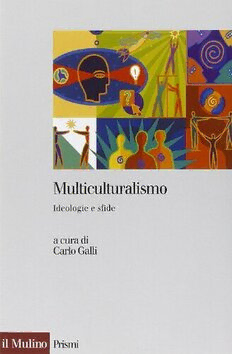Table Of ContentISBN 88-15-10550-6
Copyright © 2006 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono
riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, ri
prodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo
- elettronico, meccanico, reprografico, digitale - se non nei termini previsti
dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. Per altre informazioni si veda il sito
www.mulino.it/edizioni/fotocopie
Indice
Introduzione, di Carlo Galli p. 7
I. Le basi filosofiche del multiculturalismo, di Fran
cesca Rigotti 29
1. Epistemologia monoculturale ed epistemologia
multiculturale 29
2. Il pensiero multiculturale 30
3. Principi di epistemologia multiculturale 32
4. Pluralismo culturale, etnocentrismo e relativismo 34
5. La terza via o il pluralismo culturale 35
6. H pensiero monoculturale 37
7. Principi di epistemologia monoculturale 37
8. Multiculturalismo, riconoscimento e merito 39
9. Multiculturalismo e diffusione della democrazia 43
IL Esistono davvero i conflitti tra culture? Una ri
flessione storico-metodologica, di Alessandro Dal
Lago 45
1. Questioni di civiltà 45
2. La genealogia immaginaria dello «scontro di ci
viltà» 49
3. Digressione epistemologica 60
4. La cultura come risorsa 63
5. La cultura «fluida» 72
III. Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia,
riconoscimento, di Maria Laura Lanzillo 81
1. Comunitarismo, liberalismo, multiculturalismo 82
2. La cittadinanza multiculturale: tra diritti di grup
po e tolleranza 87
3. Multiculturalismo e universalismo 91
Indice
4 Culture ibride p. 95
5 Decostruire il multiculturalismo 104
IV L’educazione civica democratica di fronte alla
sfida del multiculturalismo, di Marcello Ostinelli 109
1. Un dilemma insolubile? 109
2. Il caso francese 112
3. L’arcipelago multiculturale 117
4. Minimalismo civico 122
5. L’educazione civica secondo i principi del liberali
smo politico 125
6. Concezione politica e concezione comprensiva
dell’educazione 131
7. Le virtù dell’educazione civica liberale in una so
cietà multiculturale 135
V. Un’agenda psicologica per una società multicul
turale. I. Ridurre l’incertezza per aprirsi alla di
versità, di Patrizia Catellani 139
1. Incertezza e crisi di appartenenza: le origini della
discriminazione e del conflitto tra gruppi 139
2. Strategie e politiche per la convivenza sociale 142
3. I nativi, gli immigrati e le percezioni reciproche 149
4. Conclusioni 151
VI. Un’agenda psicologica per una società multicul
turale. II. Idee che possono diventare progetto,
di Augusto Palmonari 153
1. Identità e riconoscimento sociale 155
2. Il fenomeno migratorio come incontro di culture 160
VII. Come reagiscono gli ordinamenti giuridici alle
culture altre?, di Stefano Ceccanti e Susanna
Mancini 167
1. H diritto all’identità culturale come diritto fonda
mentale dei singoli e dei gruppi 167
2. I crocifissi nelle scuole italiane prima e dopo l’or
dinanza della Corte costituzionale 170
3. Le ragioni del velo negato 178
Riferimenti bibliografici 197
Carlo Galli
Introduzione
1. Quando, negli anni Ottanta del secolo scorso, giunse a ma
turazione la crisi (economica, fiscale, di rappresentanza) degli as
setti universalistici delle società occidentali e delle politiche che
implementavano la cittadinanza democratica - lo Stato sociale, con
le sue linee d’intervento attivo in nome della giustizia e dell’ugua
glianza, e della tutela affermativa dei diritti individuali e collet
tivi -, uno degli effetti dell’indebolirsi dell’azione politica di for
mazione dell’unità degli spazi pubblici fu che le differenze interne,
che vi si venivano sempre più accentuando, si disponessero lungo
vettori e linee di faglia «culturali».
Dapprima negli Stati Uniti, l’incepparsi dei dispositivi dell’assi
milazione e del nation building universalistico, tanto verso le mino
ranze native quanto verso gli afroamericani quanto inoltre verso le
susseguentisi ondate migratorie che hanno storicamente costituito
il popolo americano, ebbe come risultato l’emergenza di «culture»
- insieme di lingue, religioni, costumi, simbolismi, ritualità, assetti
familiari, autopercezioni di gruppi - che non solo resistevano al
l’azione assimilazionista, più o meno ideologicamente enfatizzata,
del melting pot, ma che pretendevano di far valere come diretta-
mente «politiche» le proprie specifiche differenze. Così, all’affievo
lirsi dall’alto, dallo Stato, delle politiche volte alla realizzazione di
diritti universali, si rispose dal basso, dalla società, con l’afferma
zione del diritto alla particolarità; un diritto che non era attribuibi
le in primis agli individui singoli, come i diritti di prima generazio
ne, ma a gruppi e collettività: il diritto all’identità culturale, ossia a
promuovere un’esistenza fondata su una specifica idea di «Bene»,
su «Valori» peculiari. E nella politica non si sottolineò più l’azione
di neutralizzazione e spoliticizzazione delle differenze, dì produzio
ne universalistica di uguaglianza, ma l’espressione anche conflittua
le delle diverse identità collettive; anzi, la stessa logica della politi
ca moderna, col suo nesso fra individualismo e universalismo, fra
individuazione e identificazione nello Stato, fu criticata, o esalta-
8 C. Galli
ta, come peculiarità di una specifica cultura, quella dell’occidente
bianco razionalistico. Così, in alternativa al modello liberale della
politica orientata alla cittadinanza universale, si affermò il modello
multiculturale, che implica un’arena politica frammentata e divisa,
percorsa da conflitti per il riconoscimento delle diverse identità
collettive; o al limite implica la conquista, da parte di una cultura,
di spazi politici differenziati - in forme che vanno dall’autonomia
alla secessione - rispetto a quelli di altre culture. Pur senza coin
cidere, multiculturalismo e postmodernità convergevano così in al
cuni aspetti fondamentali.
In generale, il multiculturalismo è quindi un complesso di sfide
alla capacità inclusiva e ordinativa della politica, alla posizione uni
versalistica liberale - che tende all’emancipazione attraverso l’ugua
glianza formale -, a cui è stata opposta l’appartenenza sostanziale
a un’entità collettiva che ha il nome di «cultura» ma a volte anche
di «etnia». Ma, prima e più che una coerente serie di soluzioni, è
stato tanto il riconoscimento di un fenomeno su larga scala - il dif
ferenziarsi delle società avanzate lungo linee culturali - quanto l’ac
cettazione e la difesa di questo fenomeno, assecondato attraverso
svariate strategie intellettuali e argomentative, per nulla convergenti:
se in generale le posizioni multiculturali attribuiscono alla politica il
compito di far coesistere le diverse culture, senza intaccarne i diritti
identitari, in un piano di parità, in realtà al multiculturalismo appar
tengono tanto il relativismo - che accetta politicamente la pluralità
delle culture perché depotenzia la politica, e la traduce in un gioco
linguistico: il «politicamente corretto», che si sforza di neutralizza
re il linguaggio e di sterilizzarne le origini culturali particolari, per
fame un mezzo di comunicazione neutrale e universale (ma anche
minimale) fra culture differenti e altrimenti incomunicabili - quanto
l’interpretazione della politica come conflitto delle «differenze» (del
le «culture») per il riconoscimento reciproco (e qui l’identità è quel
la della comunità, a cui il singolo partecipa esistenzialmente).
Anche la polemica «comunitaria» contro l’ultima manifestazio
ne in grande stile del razionalismo politico moderno - il liberali
smo normativo di Rawls, che non può non sottolineare che l’iden
tità politicamente più rilevante è quella dell’individuo e non delle
culture, mentre queste, per essere legittimate, devono essere sotto
poste a un severo criterio di congruenza con assiomi razionalistici
e universalistici di derivazione illuministica - è stata centrata sulla
critica della definizione liberale di identità, di diritti, e di politica;
la soggettività assunta dal liberalismo prescinderebbe infatti dalle
condizioni del suo concreto costituirsi e prodursi, cioè appunto
dalla dimensione dell’appartenenza a una comunità, a un orizzonte
Introduzione 9
storico e geografico determinato. In quest’ottica, la politica è l’in
sieme delle strategie di riconoscimento delle peculiarità concrete e
non la costruzione razionalistico-contrattualistica di un universale
indeterminato, da parte di un soggetto astratto.
A questa critica - condotta dal canadese Taylor, il più struttu
rato dei pensatori comunitari, secondo un modello hegeliano sem
plificato - Rawls rispose con la proposta del «liberalismo politico»;
e anche da altre parti si avanzarono strategie di composizione fra
liberalismo e comunitarismo. Così oggi varie posizioni intermedie,
più sfumate, non chiedono alle culture di essere integralmente li
berali, ma solo di consentire ai loro membri una vita orientata al
fiorire delle potenzialità di ciascuno, cioè una vita «buona» secon
do le convinzioni di ognuno; in questi casi si fa a volte ricorso a
modelli di democrazia non classicamente statuali ma repubblicani
(ossia, di democrazia deliberativa e partecipativa).
Nel complesso, è evidente che intorno alla tematica del mul
ticulturalismo ruotano problematizzazioni dei livelli profondi del
pensiero politico moderno: si pone la domanda di quanto spazio
si debba e si possa lasciare alle diverse idee di Bene che le diverse
comunità (o culture) esprimono per affermare la propria identità,
e quanto invece si debbano e si possano neutralizzare politicamen
te le pretese, inevitabilmente parziali e confliggenti, dei Valori, e
fare della politica la realizzazione dei diritti uguali per tutti, e in
parallelo restringere il Bene in spazi particolari, dalla politica ga
rantiti ma a questa subordinati.
2. Che il multiculturalismo come fatto e come sfida implichi
la necessità di affrontare la questione del nesso oppositivo bene
diritto, identità-uguaglianza, valore-neutralità, è poi chiaro quando
l’insieme dei fenomeni multiculturali emerge nelle società europee,
cioè quando, dopo il crollo dei sistemi comunisti, si innescano le
dinamiche politiche, economiche e sociali della globalizzazione,
e hanno origine i grandi movimenti migratori che fanno nascere
all’interno degli Stati europei numerose comunità di persone che
per lingua, religione, costumi, attitudine verso la politica, paiono
costituire appunto «culture» nettamente differenziate da quelle dei
paesi ospitanti, e mettono questi davanti a problemi inediti.
Il multiculturalismo, in ambito europeo, è il nome con cui
oggi si designa un complesso di problematiche riconducibili alla
presenza - per la prima volta all’interno delle omogeneità nazio
nali e sociali, delle identificazioni e delle individuazioni costrui
te nei secoli in Europa dall’azione uniformante della statualità
moderna - di differenze culturali di :ui sono portatori non tan-
10 C. Galli
to «nativi» quanto immigrati di diverse etnie e religioni che - a
differenza di quanto è avvenuto nella storia degli Stati Uniti - sono
una realtà del tutto nuova. Un complesso di problematiche che
mettono in crisi la già calante capacità integrativa dello Stato
continentale, delle sue istituzioni e delle sue culture politiche,
del suo assetto giuridico, del suo ordine unitario centrato sulla
sovranità rappresentativa, sul giuspositivismo; su un sistema isti
tuzionale diverso da quello statunitense, federale e strutturato al
meno in parte sul common law, e più indifeso di quello davanti
alle sfide del multiculturalismo.
Storicamente, le statualità europee si sono infatti date il com
pito di neutralizzare politicamente le differenze culturali al proprio
interno, e di fare dello spazio pubblico una superficie liscia, rego
lata solo dal diritto e istituita allo scopo di implementare i diritti
universali e collettivi di tutti, in regime di uguaglianza. Assai più
rigida e formalizzata di quella statunitense, l’arena politica costi
tuita da uno Stato europeo è il risultato della prestazione teorica
e pratica della moderna sovranità rappresentativa - dello Stato -,
quale si è configurata nel pensiero del razionalismo politico mo
derno e nelle istituzioni postrivoluzionarie: reliminazione dallo
spazio politico delle differenti pretese di Valore e di Bene - che
storicamente avevano preso l’aspetto devastante delle guerre civi
li di religione la nuova centralità epistemologica e politica del
l’individuo e dei suoi diritti naturali alla vita, alla libertà, alla pro
prietà; l’implementazione di tali diritti attraverso l’attribuzione alla
politica del compito di produrre l’unità formale, neutrale e traspa
rente, di tutti gli individui su un piano di uguaglianza, cioè di co
struire la cittadinanza legale; la trasformazione del tradizionale po
tere di governo, con le sue caratteristiche concrete e prudenziali,
nel comando razionale (irresistibile, perché prodotto dal sovrano
rappresentativo) della legge universale e astratta. A fronte di que
sta uniformità giuridica pubblica, le differenze di ogni tipo - par
ticolarmente quelle di religione - sono spoliticizzate, e relegate
nella sfera privata, trasformate in peculiarità che per la legge sono
insignificanti e indifferenti e solo perciò sono libere (la libertà di
credenza e di culto): private di rilievo specificamente sociale e po
litico, possono generare, semmai, solo problemi di ordine pubbli
co. Anche quando questo severo modello razionalistico - che non
può non essere anche laico - assume l’aspetto dello Stato costitu
zionale di diritto, resta portatore di una politica di tolleranza «dal
l’alto», resa possibile dalla giuridificazione universale della politica,
secondo una linea monistico-formale che ne esclude il pluralismo
in senso forte: si tollera - o meglio, è legale - ciò che non attenta
Introduzione 11
all’uguaglianza dei cittadini e all’unità politica formale dello Stato
che la deve promuovere e garantire.
Questo universalismo razionalistico-illuministico si è pensa
to non solo come interno ma anche come esterno - cioè non solo
come l’uguaglianza, nella libertà, di tutti i cittadini in uno Stato, ma
anche, in potenza, di tutto il genere umano si è pensato, cioè,
come progresso reale e oggettivo rispetto a forme di politica fon
date su Valori o Beni particolari. E ha ritenuto, inoltre, e continua
per molti versi a ritenere, che il prezzo da pagare per ottenere la
civile convivenza e per garantire a tutti e a ciascuno i propri dirit
ti - ossia la privatizzazione delle culture e la trasformazione dello
spazio pubblico in unità formale e cogente - non sia troppo onero
so, davanti al rischio della politicizzazione delle differenze culturali,
cioè al rischio del conflitto. Dietro l’universalismo c’è, quindi, un
presupposto specifico e particolare: c’è l’idea che fine della politica
siano soprattutto l’unità e la pace, come assenza di conflitti giuridi
camente garantita e come condizione per l’ordinato godimento di
diritti individuali e collettivi.
Un’idea che non solo è figlia della stagione europea delle guer
re civili di religione, e,.in tempi più vicini a noi, dell’esperienza
della terribile violenza associata al conflitto delle ideologie, ma che
dell’Europa conserva il tratto culturale più specifico, ossia l’eredi
tà del cristianesimo, benché secolarizzata e formalizzata: due secoli
di dibattiti sulla secolarizzazione - da Hegel a Heidegger passando
per Feuerbach e Weber, per Schmitt, Strauss, Lowith - permetto
no di riconoscere, con diversi giudizi di valore, che i concetti della
moderna politica laica e universalistica, tanto come sistema dei di
ritti individuali quanto come impianto del diritto pubblico stata
le, hanno una specifica dipendenza, benché solo strutturale (cioè
privata del riferimento al sacro, alla trascendenza, ai Valori), dalla
tradizione intellettuale cristiana, dalla sua metafisica monistica.
Cogliere questa dialettica fra universalità dei modelli politici
razionalistici e la loro origine particolare è ancora più facile se si
passa dai concetti alla realtà storica: gli Stati moderni sono nati e
hanno affermato la propria potenza promuovendo al loro interno
un’unità non solo giuridico-formale ma anche empirico-sostanzia
le, non solo cioè come Stati-di-norme, sì come Stati dinastico-cri-
stiani prima, e come Stati-nazione poi: la politica moderna non è
stata solo sottrazione e privatizzazione di divergenti Valori dallo
spazio politico, ma anche positiva affermazione e produzione del
Bene e del Valore; il cemento della convivenza non è stata solo la
cittadinanza, ma la religione e la nazionalità; e ciò a cui si mirava
non era solo l’uniformità su base di uguaglianza, sì anche l’omoge