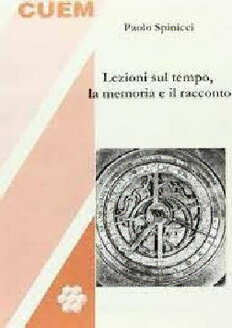Table Of ContentPaolo Spinicci
Lezioni sul tempo, la memoria e il
racconto
(Filosofia teoretica I, anno accademico 2003-2004)
in appendice:
Paola Basso
«Tout se tient»: l'immagine dell'orologio nella filosofia
moderna
GIUGNO 2004, CUEM, MILANO
LEZIONI INTRODUTTIVE.........................................................6
Lezione prima.................................................................................7
1 Considerazioni introduttive.......................................................7
Lezione seconda............................................................................17
1. Una favola antica....................................................................17
2. Le ragione di una favola.........................................................28
PARTE PRIMA............................................................................31
Due immagini della temporalità.................................................31
Lezione terza.................................................................................32
1. L’irrealtà del tempo: due diversi modi di intendere la
temporalità..................................................................................32
2. L’argomento di McTaggart.....................................................42
Lezione quarta..............................................................................47
1. La contraddizione nella serie A..............................................47
2. Argomenti e dimostrazioni.....................................................57
Lezione quinta...............................................................................62
1. Proposizioni e fatti temporali..................................................62
2. Delle proposizioni di tipo A non si può fare a meno..............68
Lezione sesta..................................................................................73
1. Il presente: una determinazione soggettiva?...........................73
2. La grammatica del presente, la grammatica dei vissuti..........80
Lezione settima.............................................................................86
1. Una piega pragmatica.............................................................86
2. Siamo sempre ora...................................................................91
Lezione ottava.............................................................................102
1. Uno sguardo indietro............................................................102
2. La fenomenologia: considerazioni introduttive....................110
Lezione nona...............................................................................116
3
1. Qualche considerazioni metodologica..................................116
2. Oggetti temporali, oggetti «nel loro come» e la struttura
soggettiva della temporalità......................................................123
Lezione decima............................................................................130
1. Il diagramma temporale........................................................130
2. Il senso del diagramma temporale e le serie di McTaggart..140
Lezione undicesima.....................................................................147
1. Uno sguardo indietro............................................................147
2. Il sole, la sabbia, le ruote dentate..........................................152
Lezione dodicesima.....................................................................168
1. Considerazioni conclusive....................................................168
2. Un nuovo aspetto del nostro problema.................................176
PARTE SECONDA....................................................................178
La memoria...............................................................................178
Lezione tredicesima....................................................................179
1. Considerazioni introduttive..................................................179
2. I ricordi ci appartengono.......................................................189
Lezione quattordicesima............................................................195
1. La chiusura del ricordo.........................................................195
2. Il ricordo e il presente...........................................................199
Lezione quindicesima.................................................................206
1. Due immagini della memoria...............................................206
2. Un esempio...........................................................................215
PARTE TERZA..........................................................................229
Racconto......................................................................................229
Lezione sedicesima......................................................................230
1. Le ragioni del signore dei venti............................................230
2. Calendari solari, calendari lunari..........................................241
4
Lezione diciassettesima..............................................................249
1. Misurare e scandire...............................................................249
2. Ritmi semplici e ritmi composti...........................................258
Lezione diciottesima...................................................................263
1. Mircea Eliade: fenomenologia e storia del sacro..................263
2. Il significato del sacro...........................................................270
Lezione diciannovesima.............................................................277
1. Archetipi e ripetizione..........................................................277
2. La rigenerazione del tempo..................................................285
Lezione ventesima.......................................................................295
1. Il sacro: un concetto originario?...........................................295
2. Qualche conclusione.............................................................305
APPENDICE...............................................................................309
«Tout se tient»: l’immagine dell’orologio nella filosofia moderna.....309
1. Considerazioni introduttive..................................................310
2. Le caratteristiche ‘fenomenologiche’ dell’orologio.............310
3. Concetti esemplificati dall’orologio.....................................317
5
LEZIONI INTRODUTTIVE
6
LEZIONE PRIMA
1 Considerazioni introduttive
Il tema che quest’anno vorrei affrontare con voi — il tema del tem-
po — credo superi le mie capacità. Si tratta di un tema complesso,
che ha una sua storia intricata nella riflessione filosofica e che tocca
una molteplicità di questioni molto difficili. Il tempo è una realtà
che in vario modo pervade la nostra vita e la nostra cultura, e del
tempo infatti parliamo come di una dimensione che ha un significa-
to esistenziale e sociologico: il tempo è una delle grandezze intorno
alle quali ruota la nostra vita e la nostra cultura, e diverse società
hanno diverse immagini del tempo. La storia degli uomini è anche
storia delle diverse forme in cui si comprende il tempo e del diffe-
rente ruolo che la sua misurazione assume nelle diverse epoche e
nelle diverse culture. La nostra è una società dominata dall’orologio
e dalla misurazione esatta del tempo, ma non è sempre stato così:
per molti e molti anni il Sole è stato l’unico metro del tempo — un
metro impreciso che scandiva ala durata dei giorni con il passo mu-
tevole che il ciclo delle stagioni gli attribuiva. Ma il tempo non è
soltanto uno dei cardini su cui ruota la nostra esistenza: è anche, e
soprattutto, una delle grandezze elementari della fisica. Il tempo è il
cardine su cui ruota la nozione di movimento e di cambiamento, ed
è anche chiamato direttamente in causa dalla nozione di causalità:
l’ordinamento obiettivo nel tempo è in vario modo intrecciato con il
nesso che determina la successione degli effetti alle cause, e non c’è
bisogno di addentrarsi più di tanto nella fisica novecentesca per
scoprire quanti problemi si annidino in queste considerazioni che
appaiono in una forma più semplice già nelle pagine kantiane della
Critica della ragion pura.
Di questi problemi, tuttavia, non parleremo e non soltanto perché
un corso di lezioni deve comunque delimitare l’orizzonte entro cui
intende muoversi e rinunciare fin da principio ad abbracciare un ter-
reno troppo vasto, ma anche perché è comunque opportuno distin-
guere la prospettiva teorica che compete ad un’analisi epistemolo-
gica in senso stretto dalle riflessioni che sono proprie di una dottri-
7
na dell’esperienza. Sul terreno delle indagini scientifiche i concetti
debbono essere in vario modo riformulati, e la storia di questa con-
tinua revisione concettuale è un segno della complessità del cam-
mino che la riflessione compie per delineare un’immagine del mon-
do che meglio risponda ai requisiti che la realtà impone.
Questo punto deve tuttavia essere ben chiaro: se di realtà obiettiva
parliamo, allora non possiamo che discutere di ciò che la scienza ci
propone. E tuttavia sarebbe, credo, privo di senso sostenere che i
concetti di cui le scienze si avvalgono debbano essere imposti an-
che sul terreno della nostra esistenza quotidiana. La fisica sostiene,
e a ragione, che non vi sono colori nelle cose, ma solo differenti ca-
pacità di reagire alla luce; riconoscere che così stanno le cose non
significa tuttavia storcere la bocca quando sentiamo parlare dei co-
lori. La neve è bianca, il cielo è azzurro, quest’inchiostro è nero ─
normalmente ci esprimiamo proprio così, almeno sin quando non ci
immergiamo nel linguaggio teorico della fisica; e tuttavia negare
queste affermazioni così ovvie non vuol dire disporsi sul terreno di
una superiore esattezza: vuol dire invece confondere gli oggetti che
percepiamo e che esperiamo con le entità della fisica. La neve è
bianca per la buona ragione che con la parola «neve» intendo pro-
prio questo oggetto che vedo e che tocco, e non un qualche altro
oggetto fatto di atomi e di elettroni. La fisica ha le sue ragioni per
costringerci ad avvalersi dei suoi concetti e il mondo di cui ci parla
non è un altro mondo rispetto al nostro; tutt’altro: è proprio questo
nostro mondo che dobbiamo pensare così, come la fisica ci insegna.
Ma questo non significa che le partizioni che tracciamo nel mondo
sensibile abbiano un loro corrispettivo sul terreno della fisica o del-
le scienze in generale. E proprio come non vi è ragione di costringe-
re la fisica ad accettare come significative le partizioni e le classifi-
cazioni che l’esperienza traccia, così non vi è un motivo particolare
per sentirsi costretti a far valere sul terreno del mondo della vita i
concetti e le verità delle scienze naturali.
Vi è, comunque, un’ulteriore ragione per non costringere il mon-
do della vita nel linguaggio della scienza, ed è che i concetti di cui
le scienze si avvalgono implicano le certezze che animano la nostra
comune esperienza. Del mondo così come lo conosciamo le scienze
scoprono la natura reale, ma questo non toglie che la stessa possibi-
lità di pensare e conoscere la realtà così come le scienze vengono
nel tempo scoprendola poggia infine sulle forme di categorizzazio-
8
ne dell’esperienza che appartengono al mondo della vita e che sono
presupposte dalla stessa possibilità di un orizzonte dialogico. Di qui
l’andamento di queste lezioni che avranno come tema il concetto di
tempo che l’esperienza comune ci porge — un concetto che proprio
in virtù della sua elementarità deve essere discusso per primo.
A questa prima delimitazione del terreno di indagine dovremo tut-
tavia farne seguire molte altre, che non hanno alle spalle altre ra-
gioni se non questa — quando ci si imbatte in un problema difficile
è opportuno riconoscere i propri limiti. E così vi chiedo fin da prin-
cipio il permesso di dimenticarmi di tanti problemi che pure an-
drebbero affrontati e discussi, ma che dobbiamo invece mettere da
canto, per concentrare la nostra attenzione innanzitutto su un aspet-
to della grammatica della temporalità: il suo esser sospesa tra la di-
mensione del fluire e del permanere. Il tempo passa, eppure è una
forma d’ordinamento che c’è — una volta per tutte. L’istante che
ora viviamo è un punto senza dimensione che precipita nel passato
— è un’osservazione che abbiamo sentito molte volte, e che ha dal-
la sua molte buone ragioni. E tuttavia alla retorica del divenire e al-
le sue immagini così familiari — l’immagine del fiume che scorre,
della sabbia che cade nella clessidra, della fiamma che divora la
candela — non è difficile opporre le immagini del permanere: per
quanto debbano di continuo muoversi, le lancette non possono ab-
bandonare il quadrante ed ogni loro possibile posizione (e insieme
ogni futura posizione degli ingranaggi dell’orologio) è già come
racchiusa nella natura stessa di quei meccanismi, nello spettro dei
suoi possibili movimenti.
Parleremo dunque solo del tempo e del nesso che lega il fluire al
permanere. Del resto, anche se ci manteniamo vicini a questa cop-
pia di concetti, le cose da dire sono molte e il tempo non perde
quella sua particolarissima centralità che nella nostra vita gli spetta.
Il tempo passa, — questo lo sappiamo davvero tutti, e non possiamo
nemmeno pensare che un istante si sottragga a questa legge o che
possa davvero aprirsi nuovamente un varco nella presenza. E tutta-
via il passare del tempo non è soltanto un continuo fluire, ma è an-
che ciò che determina una forma di ordinamento immutabile. Ciò
che accade si dispone nella dialettica temporale del divenire che dal
futuro conduce al presente e dal presente al passato, e tuttavia al di
là del gioco mutevole della prospettiva temporale, gli eventi si le-
gano ad un istante di tempo, e nel loro accadere si appropriano di
9
una posizione temporale che non potrà più mutare. Il futuro si fa
presente e il presente passato, ma a questo divenire fa da contrap-
punto il tempo come successione ordinati di luoghi disposti secondo
il criterio del prima e del poi — un ordinamento rigido, che non
muta con il passare del tempo, poiché non accadrà mai che nel suo
sprofondare nel passato la battaglia di Canne si faccia più o meno
discosta dalla battaglia del Trasimeno o che accada prima di essa.
Del resto, questa duplice forma del tempo sembra radicarsi anche
nella natura dei giudizi che al tempo si legano. Sin quando ci muo-
viamo sul terreno del senso comune e delle forme del linguaggio
quotidiano dire di qualcosa che c’è significa anche riconoscerne la
presenza. Se diciamo a qualcuno di prendere il libro sul tavolo è
perché sul tavolo ora c’è il libro che ci serve: il suo esserci fa
tutt’uno con il suo esserci ora. Di un’azione non fatta possiamo dire
che la faremo e, alla stessa stregua, dire ad una persona reduce da
uno spavento che è tutto passato vuol dire semplicemente ricono-
scere che ciò di cui ci si preoccupava non esiste più e che non vi è
più nulla da temere. Le cose passate non ci sono più, e questa mas-
sima così ovvia risuona in una veste più aulica nelle parole di Mefi-
stofele che nel Faust ci ricorda che parlare del passato significa in-
dugiare su una parola sciocca, poiché passato e nulla sono un’unica
cosa.
All’immagine del tempo come un processo che conduce gli eventi
sul palcoscenico dell’esistenza per poi nuovamente sottrarli al ter-
reno dell’essere fa eco la tesi secondo la quale la temporalità altro
non sarebbe che un sistema di relazioni che possono essere descritte
e constatate in un linguaggio privo di determinazioni temporali. E
quanto più cerchiamo di connettere le une alle altre le determina-
zioni del flusso e della permanenza, tanto più ci imbattiamo in dif-
ficoltà che sembra difficile sanare. Il tempo passa, ma il tempo è
anche un sistema di relazioni che permane. La pace di Nimega è
prima della battaglia di Waterloo e lo resterà per sempre, proprio
come ciò che tra breve accadrà è comunque già da ora in un rappor-
to temporale determinato con ogni altro evento — un rapporto che
può essere asserito in un linguaggio privo di flessione temporale,
proprio come accade quando diciamo che 5 è maggiore di 3 o che
un pentagono ha 5 lati. Del resto, se ci poniamo in questa nuova
prospettiva, proprio le osservazioni che abbiamo dianzi avanzato e
che miravano a stringere in un unico nodo l’esserci e la presenza ci
10