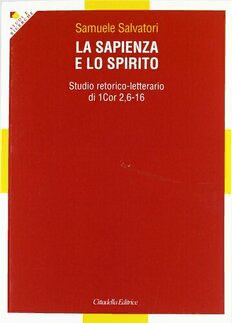Table Of ContentSTUDI E RICERCHE
Sezione biblica
SAMUELE SALVATORI
LA SAPIENZA
E LO SPIRITO
Studio retorico-letterario
di 1Cor 2,6-16
Presentazione di Andrzej Gieniusz C.R.
CITTADELLA EDITRICE
ASSISI
Cura redazionale
ANTONIO LOVA
© CITTADELLA EDITRICE - ASSISI
www.cittadellaeditrice.com
1a edizione: novembre 2011
ISBN 978-88-308-1167-6
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei
limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del com-
penso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633,
ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTI-
GIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI
il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avve-
nire solo a seguito di specifca autorizzazione rilasciata dall’editore.
PRESENTAZIONE
Gli ultimi decenni hanno visto la pubblicazione di numerosi
studi sulla retorica degli scritti paolini e il diffondersi di un
grande entusiasmo per questo nuovo approccio all’interpreta-
zione dell’eredità letteraria dell’Apostolo delle Genti. Inizial-
mente i modelli retorici attribuiti alle singole lettere di Paolo
erano piuttosto uniformi, tanto da diventare, non di rado, una
camicia di forza o un “letto di Procuste”, impedendo la perce-
zione dell’originalità propria dell’Apostolo invece che aiutare
a scoprire la profondità del suo pensiero e la ricchezza delle
tecniche persuasive adoperate.
Con il passar del tempo la nuova metodologia si è raffi na-
ta e adeguata maggiormente al suo oggetto di studio. Oltre a
scoprire l’elasticità della dispositio paolina e ad ammettere la
varietà dei generi retorici presenti all’interno dello stesso scrit-
to di Paolo, ci si è interessati anche della diversità delle prove
da lui fornite e soprattutto della ricchezza e dell’originalità
dell’ornatus dei suoi discorsi. L’approccio retorico-letterario
si è trasformato in questo modo da una tappa ausiliare, sui cui
risultati fondare l’analisi esegetica vera e propria, in un metodo
esegetico completo, non soltanto complementare a tutti gli altri
approcci ma anche un loro indispensabile correttivo.
Lo studio di Samuele Salvatori su 1Cor 2,6-16 rappresenta
un esempio dell’analisi retorico-letteraria al suo meglio, ap-
plicata ad un testo notoriamente diffi cile, che da secoli vede
schierarsi gli studiosi in diverse interpretazioni che si escludo-
no a vicenda, senza che nessuna possa imporsi come l’unica
valida. Si tratta perciò di una sfi da notevole, portata a buon
6 Presentazione
fi ne grazie non solo al sapiente uso dell’analisi letteraria e della
retorica, ma anche grazie ad un ammirevolmente ampio uso e
confronto con la letteratura secondaria.
Questa dissertazione onora il Pontifi cio Istituto Biblico e la
Pontifi cia Università Urbaniana, le due facoltà dove Samuele
Salvatori ha acquisito la sua competenza esegetica. Il lettore
interessato al pensiero dell’Apostolo troverà in questo studio
una solida e sostanziosa presentazione di uno degli aspetti
centrali della teologia paolina (Spirito e sapienza) e inoltre sarà
iniziato a tutta l’offi cina esegetica, così da potersi poi avventu-
rare con le proprie gambe nei meandri e nelle profondità delle
argomentazioni paoline.
ANDRZEJ GIENIUSZ C.R.
Pontifi cia Università Urbaniana
PREMESSA
Questa pubblicazione è il testo integrale della tesi di Dotto-
rato in Teologia Biblica, difesa presso la Pontifi cia Università
Urbaniana il 15 dicembre 2009. Il lungo periodo di studio e di
ricerca che ha portato a questo frutto – spero il più possibile
maturo – non è stato per me solamente un percorso di forma-
zione esegetica e teologica, ma anche una tappa fondamentale
della mia esperienza di fede.
Fin dai primi studi teologici sono rimasto affascinato dalla
profondità e dall’attualità della fi gura di Paolo di Tarso e soprat-
tutto da come l’Apostolo interpreta l’identità cristiana alla luce
della logica della croce. Per questo motivo ho scelto come tema
specifi co della mia dissertazione la mediazione dello Spirito
Santo nell’intelligentia crucis, ovvero nella capacità di discer-
nere nell’evento scandaloso della croce di Cristo la salvezza di
Dio donata gratuitamente all’uomo. Questo discernimento nello
Spirito non è una realtà astratta o intellettualistica, ma tocca la
vita concreta del credente, chiamato a pensare e ad agire secon-
do i criteri della croce e, come dice l’Apostolo, a “non confor-
marsi alla mentalità di questo mondo” (cfr. Rm 12,2).
Nel lungo e faticoso cammino di ricerca non sono mai stato
solo, ma ho avuto vicino tante persone che, in diversi modi, mi
hanno aiutato a raggiungere una meta molto importante. Ad
ognuno di loro va il mio pensiero di gratitudine e di affetto.
Il primo ringraziamento è per la mia famiglia, una scuola di
fede dove ho imparato ad amare il Signore grazie alla testimo-
nianza di vita dei miei genitori, dei miei fratelli e dei miei parenti.
Voglio esprimere la mia profonda gratitudine verso la mia
Provincia dei Frati Minori delle Marche, il mio maestro e ora
8 Premessa
Ministro provinciale Fr. Ferdinando Campana, i frati con cui
condivido la mia vita, le sorelle del Santissimo Nome di Gesù
e tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini con il loro
affetto fraterno. Insieme a loro voglio ricordare le mie sorelle
Clarisse, non solo per avermi sostenuto con la loro incessante
preghiera, ma anche perché è grazie ad un loro suggerimento
illuminante che vari anni fa ho intuito quello che sarebbe stato
il tema di questa ricerca.
Nel libro del Siracide si dice: “Se vedi una persona saggia,
và presto da lei; il tuo piede logori i gradini della sua porta” (Sir
6,36). Il mio lavoro non sarebbe mai giunto alla sua meta senza
la sapiente guida di “maestri” che mi hanno guidato per le vie
impervie del pensiero teologico di S. Paolo. Per questo motivo
sento di dover ringraziare il prof. Andrzej Gieniusz C. R., della
Pontifi cia Università Urbaniana, moderatore di questa tesi, che
mi ha accompagnato nello sviluppo del mio lavoro con attenzio-
ne e competenza e mi ha insegnato la diffi cile ma appassionante
arte dell’esegesi; insieme a lui ringrazio anche il prof. J.-N. Alet-
ti , che durante i miei studi di Licenza presso il Pontifi cio Istituto
Biblico mi ha introdotto sapientemente nell’analisi retorico-
letteraria delle lettere di Paolo. Ringrazio inoltre il prof. G. Bi-
guzzi e il prof. C. Bazzi, correlatori di questa tesi, per i preziosi
suggerimenti con i quali hanno arricchito la mia ricerca.
Ringrazio l’Istituto Teologico Marchigiano nella persona
del Preside don Mario Florio e tutti i docenti che hanno curato
la mia formazione teologica e con i quali ho l’onore di colla-
borare nell’insegnamento.
In ultimo, voglio rivolgere un ringraziamento particolare
a Mons. Agostino Gasperoni, la cui passione per la Parola di
Dio e specialmente per S. Paolo mi ha letteralmente contagiato
durante i miei studi teologici. Dedico a lui, con tanto affetto e
gratitudine, questa mia pubblicazione.
Fr. SAMUELE SALVATORI, OFM
Gerusalemme, Pasqua 2011
INTRODUZIONE GENERALE
All’interno della prima lettera ai Corinzi, la funzione argo-
mentativa di 1Cor 2,6-16 nel contesto di 1Cor 1–4 è uno dei
temi più dibattuti nel panorama esegetico degli ultimi decenni.
Con un improvviso cambio di linguaggio e di tono Paolo intro-
duce in 2,6 un’argomentazione che sembra essere in contraddi-
zione con ciò che era stato detto precedentemente. Se, infatti,
egli aveva affermato che la sapienza del mondo è stata resa
impotente per mezzo dell’annuncio di Cristo crocifi sso, ora
egli stesso riconosce che i “maturi” possiedono e comunicano
la sapienza.
Per questo motivo, secondo un autorevole commentatore
come H. Conzelmann , 1Cor 2,6-16 non è coerente con il suo
contesto, dal momento che il modello di “sapienza” sviluppato
in questa pericope si discosta dalle precedenti affermazioni di
Paolo1.
Questa discontinuità rispetto al contesto è data anche dal
vocabolario usato in 1Cor 2,6-16, che sembra riprendere alcuni
schemi di pensiero della fi losofi a stoica, o i modelli interpreta-
tivi della Scrittura del giudaismo ellenistico, di cui il fi losofo
alessandrino Filone è il maggiore esponente. Ne sono degli
esempi l’immagine del sapiente inteso come “maturo” (tel, eioj:
1Cor 2,6) e contrapposto al principiante che è equiparato al
“bambino” (nhp, ioj: 1Cor 3,1), come anche la contrapposizione
tra l’uomo “spirituale” (pneumatikoj, : 1Cor 2,15) e l’uomo che si
pone esclusivamente sul piano umano (yucikoj, : 1Cor 2,14).
1 H. CONZELMANN , 1Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the
Corinthians, Hermeneia, Philadelphia, PA 1975, 57.