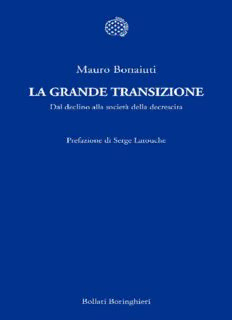Table Of ContentLDB
Presentazione
Ormai entrata nel nostro lessico quotidiano, la parola
«decrescita» si carica di significati opposti, qualificando – a
seconda delle valutazioni – sia il problema sia la sua soluzione.
Il coro degli economisti ufficiali assimila la «decrescita reale»
che oggi flagella i paesi sviluppati a un fenomeno
congiunturale, destinato prima o poi a risolversi nella ripresa.
Altri invece giudicano quella che attraversiamo una vera e
propria crisi di sistema, al tempo stesso economica, ecologica,
sociale e culturale. Sono gli obiettori di crescita, per i quali la
fase espansiva si è irrevocabilmente conclusa e il declino delle
società capitalistiche avanzate è un fatto paradossalmente
benaugurante. Mauro Bonaiuti, tra i primi in Italia a muoversi
in questa prospettiva avviata da Serge Latouche, riflette sui
presupposti della «grande transizione» che ci aspetta: dalla
durezza senza sbocco dello sviluppo a tutti i costi, causa di
malessere sociale, predazione di risorse e danni ambientali,
alla resilienza o «decrescita serena», sinonimo di ritessitura
delle relazioni umane in uno spazio di prossimità e in una
dimensione di reciprocità. L’arroganza dei mercati non
esaurisce l’orizzonte. Esiste anche un progetto di società di
decrescita, e secondo Bonaiuti è l’unico a poterci salvare dal
baratro.
Mauro Bonaiuti insegna Finanza etica presso l’Università di
Torino. È cofondatore della Associazione per la Decrescita e tra
i promotori della Rete Italiana di Economia Solidale. Ha scritto
La teoria bioeconomica. La nuova economia di Nicholas
Georgescu-Roegen (2001), e curato Obiettivo decrescita (2004)
e, per Bollati Boringhieri, la raccolta di saggi di Georgescu-
Roegen Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente
e socialmente sostenibile (2003).
Temi
231
Per la Prefazione © 2013 Serge Latouche
Traduzione di Fabrizio Grillenzoni
© 2013 Bollati Boringhieri editore
Torino, corso Vittorio Emanuele II, 86
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
ISBN 978-88-3397229-9
Schema grafico della copertina di Pierluigi Cerri www.bollatiboringhieri.it
Prima edizione digitale aprile 2013
Quest'opera è protetta dalla Legge sul diritto d'autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata
Prefazione
*
Serge Latouche
L’espressione «decrescita» fa la sua comparsa come slogan
provocatorio nel febbraio del 2002, per denunciare la
mistificazione dell’ideologia dello sviluppo sostenibile. Questa
«parola proiettile», questa «bomba semantica» (Paul Ariès
dixit) vuole rompere il consenso rassegnato all’ordine
1
produttivista dominante. Per tentare di salvare la religione
della crescita di fronte alla crisi ecologica, il PNUA
(Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) aveva lanciato
la parola d’ordine dello sviluppo sostenibile, ossimoro geniale
in termini semantici, ma che non è riuscito a risolvere il
problema, perché lo sviluppo, per sua essenza, non è
sostenibile.
Lanciata dunque, quasi per caso, per rompere con l’ipocrisia
dello sviluppo sostenibile, la decrescita, almeno all’inizio non è
un concetto, e in ogni caso non è il corrispettivo simmetrico
della crescita. La decrescita non è né la recessione né la
crescita negativa. Diventata rapidamente la parola d’ordine e la
bandiera di tutti quelli che aspirano alla costruzione di una
vera alternativa a una società dei consumi ecologicamente e
socialmente insostenibile, la decrescita costituisce ormai una
finzione performativa che indica la necessità di una rottura con
la società della crescita. Più rigorosamente, si dovrebbe parlare
di a-crescita, così come si parla di a-teismo. Perché si tratta per
l’appunto dell’abbandono di una fede e di una religione: quelle
del progresso e dello sviluppo. Si tratta di diventare degli atei
della crescita e dell’economia. La rottura operata dalla
decrescita implica di conseguenza una decolonizzazione
dell’immaginario e la realizzazione di un altro mondo possibile.
Si tratta di uscire da una società della crescita, cioè da una
società fagocitata da un’economia che ha come solo obiettivo la
crescita per la crescita, e la cui logica non è di far crescere la
produzione per soddisfare dei bisogni ma di farla crescere
all’infinito con il pretesto dell’illimitatezza dei consumi e con la
conseguenza dell’aumento insensato dei rifiuti e
dell’inquinamento. Insomma, la distruzione del pianeta.
Mauro Bonaiuti, che dal grande economista e studioso
Nicholas Georgescu-Roegen ha ripreso l’idea fondamentale che
una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito, è
stato un «obiettore di crescita» ante litteram. Ma, in un mondo
in cui la scena politica e intellettuale è fagocitata dai media, il
ricercatore impegnato occupa un posto tanto essenziale quanto
ingrato. Indifferente alle mode, traccia il proprio solco lontano
dai riflettori dell’attualità effimera. Si spiega così il posto che
Mauro Bonaiuti occupa nella galassia della decrescita e
l’importanza del suo percorso. Bonaiuti tenta in primo luogo di
approfondire il tema della bioeconomia, il progetto improbabile
sostenuto da Georgescu-Roegen, e poi, trasformando lo slogan
della decrescita in un vero e proprio concetto, ne deriva una
teoria organica.
Il posto di Mauro Bonaiuti nella galassia della decrescita
Ho incontrato per la prima volta Mauro Bonaiuti, se la
memoria non mi inganna, all’inizio degli anni duemila a Lecce,
in occasione di un convegno organizzato dall’Associazione
Italiana per la Storia del Pensiero Economico (AISPE).