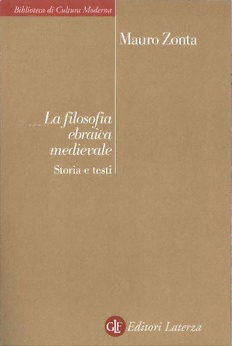Table Of ContentZonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina I
Biblioteca di Cultura Moderna
1158
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina II
© 2002, Gius. Laterza & Figli
Prima edizione 2002
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina III
Mauro Zonta
La filosofia
ebraica
medievale
Storia e testi
Editori Laterza
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina IV
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel gennaio 2002
Poligrafico Dehoniano -
Stabilimento di Bari
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
CL 20-6521-5
ISBN 88-420-6521-8
È vietata la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche
ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è
lecita solo per uso personalepurché non
danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina V
Premessa
La filosofia ebraica medievale rappresenta probabilmente una delle
più interessanti, ma anche delle meno conosciute, manifestazioni del
pensiero e della produzione letteraria della cultura ebraica post-bibli-
ca, che si presenta molto spesso, soprattutto ai non specialisti, appiat-
tita sulla sola dimensione della «mistica», la qabbalah. Eppure, nella fi-
losofia si rivelano con evidenza gli aspetti più significativi del rappor-
to tra la cultura ebraica e le culture prossime (quella greca antica, quel-
la arabo-islamica e quella latino-cristiana medievale), e specialmente la
capacità di rifondere temi e testi ripresi da altri ambienti, adattandoli
alle proprie esigenze nazionali e religiose. La lettura dei testi della fi-
losofia ebraica medievale, infatti, consente di vedere riflesso, come in
uno specchio, l’avvicendarsi delle diverse tendenze del pensiero e del-
la letteratura di area mediterranea tra l’800 e il 1500, mostrando quel-
la ebraica non come una cultura puramente esoterica, chiusa in se stes-
sa, ma come una cultura aperta alle più differenti influenze – quale, al
di là dell’approccio più miope diffuso in certi studi anche recenti, es-
sa è stata riconosciuta fin dagli inizi della giudaistica moderna, nel se-
colo XIX.
Le linee storiche generali e le figure dei principali protagonisti di
questa filosofia sono, per il vero, stati resi ampiamente noti al lettore
italiano, soprattutto dopo la recente pubblicazione della versione ita-
liana di un’opera di Colette Sirat (La filosofia ebraica medievale secondo
i testi editi e inediti, ed. it. a cura di Bruno Chiesa, Brescia 1990). Man-
ca però al grande pubblico del nostro paese la possibilità di un approc-
cio diretto ai testi: in effetti, al di fuori dei brevi brani citati nell’o pera
della stessa Sirat, di poche versioni integrali (quella dell’Introduzione ai
doveri dei cuoridi Bah.ya Ibn Paq∂da, e quella del Libro del Cazarodi
Yehudah ha-Levi), e di una buona antologia dell’opera di Maimonide,
non esistono ancora traduzioni italiane moderne ed affidabili della
maggioranza, se non della totalità, della produzione letteraria della fi-
V
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina VI
losofia ebraica medievale, sia di quella redatta in lingua ebraica, sia di
quella redatta nell’altra importante lingua letteraria del pensiero ebrai-
co del Medioevo: l’arabo. Basti pensare che, di quello che è considera-
to il capolavoro della filosofia ebraica, La guida dei perplessi di Mai-
monide, è reperibile in italiano, a tutt’oggi, solo una incompleta tradu-
zione (copre grosso modo la prima metà dell’opera) della versione fran-
cese di Salomon Munk, risalente peraltro a circa centotrenta anni fa1.
Scopo di quest’opera è, quindi, quello di fornire al lettore italiano
non specialista un’antologia ragionata, con concise introduzioni e an-
notazioni, di alcuni tra i più significativi scritti della letteratura filoso-
fica ebraica medievale, in traduzione italiana. I testi in questione, tra-
dotti per circa un terzo dall’arabo (laddove il testo originale in questa
lingua è ancora disponibile) e per il resto dall’ebraico, sono stati scelti
anche sulla base del loro interesse contenutistico, privilegiando quelli
nei quali si rivela in misura maggiore l’influenza del pensiero filosofico
antico e medievale non ebraico; talora si è preferito tradurre alcuni te-
sti perché di essi non è disponibile neppure una versione in una lingua
straniera moderna (tale è il caso di buona parte del Libro degli elemen-
tidi Isaac Israeli, del Libro del microcosmodi Yosef Ibn S.addiq, del Li-
bro del giardinodi Mosheh Ibn ‘Ezra – che è tuttora inedito –, ma an-
che dei passi qui tradotti di Shem Tov Ibn Falaquera, di Abraham Bi-
bago e di Yehudah Messer Leon). Va sottolineato che i riferimenti bi-
bliografici, dato lo scopo anche didattico dell’opera, non intendono es-
sere esaustivi, ma mirano soprattutto a fornire un quadro sintetico de-
gli scritti recenti, in italiano o almeno in una delle principali lingue
moderne, con cui il pubblico può eventualmente perfezionare la sua
conoscenza degli autori e dei temi qui sommariamente presentati.
Devo un ringraziamento particolare a mia moglie Francesca, che
mi ha aiutato nella revisione generale del testo, e specialmente nella re-
dazione degli indici.
Mauro Zonta
Pavia, maggio 2001
1Per un elenco delle poche traduzioni italiane dei classici della letteratura
filosofica ebraica medievale risalenti al secolo XIX, cfr. Tamani 1999.
VI
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina 1
La filosofia ebraica medievale
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina 2
Zonta_8842065218_Zonta.QXD 29/04/14 12.26 Pagina 3
Capitolo primo
Le premesse storiche e culturali
1. Il giudaismo classico e la civiltà greca
La filosofia compare per la prima volta nel mondo ebraico sotto le ve-
sti che conserverà sostanzialmente per tutto il Medioevo: quelle di una
h.okmah zarah, una «sapienza straniera», o, meglio ancora, di h.okmat
ha-Yawwanim, «sapienza dei greci». Essa verrà infatti sempre perce-
pita come una disciplina non nazionale e non tradizionale, mutuata da
una civiltà straniera (quella greca, appunto) e non completamente con-
ciliabile con le strutture religiose del giudaismo. Il confronto tra la cul-
tura ebraica, incarnata dalla tradizione del giudaismo classico, e la cul-
tura greca, incarnata dalla filosofia e dalla scienza, viene avviato sin
dall’epoca talmudica (secoli II-V d.C.) e continuerà sino alla sostan-
ziale sconfitta della seconda, alla fine del Medioevo.
Con «giudaismo classico»1si intende il periodo di formazione del-
le strutture della religione degli ebrei così come oggi le conosciamo; e
la data d’inizio del periodo può essere individuata nel 70 d.C. Il trauma
rappresentato dalla distruzione – avvenuta in quell’anno – del tempio
di Gerusalemme, che era stato fino ad allora uno, se non l’unico centro
del culto ebraico, comportò un sostanziale, anche se non immediato
mutamento di prospettiva: come centro di culto, al tempio si sostituì la
sinagoga; come oggetto di venerazione, al Santo dei Santi (il cuore del
tempio stesso) si sostituirono i rotoli della Bibbia, e in particolare della
Torah(ossia, il Pentateuco, la Legge religiosa ebraica per eccellenza);
come pratica cultuale, ai sacrifici officiati dai sacerdoti nel tempio si so-
stituì la rigorosa osservanza dei precetti da parte di tutta la popolazione
ebraica in grado di adempierli; come classe dirigente e guida religiosa
degli ebrei, ai sacerdoti, ormai forzatamente inattivi, si sostituirono i
1Riprendo questa classificazione storica da Stemberger 1991, che rappre-
senta una delle migliori introduzioni disponibili in lingua italiana ai temi som-
mariamente presentati in questo capitolo.
3