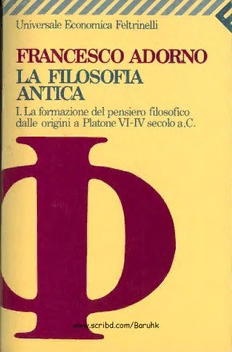Table Of Contentwww.scribd.com/Baruhk
FR4\NCESCO ADORNO
fl(~ FILOSOFIA AN'IliC4
t~a (ofm,~iòne del pensiero diosolico dalle origini a_ Pla.t.oJJe
V f. IV ~ecùlo a.C.
t'a presente edizi1ìne il quallri> volumi ;<le J;Q filqsofta a/l.ftca
di FJ;àl)cé.~co A<lorni>J>rosp~ha, in Ml'a rtuoxa e !Aiglìore,..s~ansii>ne,
l vasti c complessi p~tiodi del.l'à filosofia ànUca. Ne; J>rimi èluc
"Volumi ~<,\n<\ìlel(neatni,u ?a ~>arti~e <!all'ambillnte "culturale"~ \'Iile"(o
(VII-VI. SCC910 a.G.O a Platone h.-volo'II\e~e <falla Scuol",!h "'Platone
e da Ans16tél'e rm~· Mllnèontro-sc<l~r() c<m Koma al tempo
dèlllambasceria <li Carneade, Cj:ifiolao e Diogene di B-abilonia
(156-155 a,C.) - Ii volume. , i iMmeJ>lt mol~epllçi e diversi de[ a
slorii" del vensÌer_y che ,j J>UQ dirç~çl ~\W ]a~sj e StSf:erÌÌ\Irsi,
prqp~ialfle,pfe g~teco, ):\ei §eeondi dòt!:voluthi \ii ved<>no i vari os.pe\~
cò-n l:tii si n osLituilà la cultura f•l<>sofka _ne1f~'1cop.tro .c?n Ròtria e
nel formar"' delli•mpero 011 volllntel; .$1 d1scut.e pOI é SI 1llustra
(\V volume) Ull, Hlngo perioào, non omo'geneo, anz~m6lt<,> var'jog~o
cl~e v>~_. dal II alla l'l'Pia ~>arte del W seçolo d.O., d~l principio
dçJI'lmJ>.!'ro R<,>mano al suo disfacimento, dallo scoalr?> e dall'incontro
!'N
cl> t~ 'il Crl);t1,a"!esj.lù.o e con ali.~t co~ce<ioni relìJ;iO~~ alta usura
dell.,licuo\e d1ot:lene 1t5 2!1 d.Q.). '[), <IUe~to por~odo, tll èm
s'intrcçCianqJc !I(,Rvarig,ctlltQ.~e provenienti dà pae~si diversi e< a
$'Vi!rse_te.ra diziòni, non v'era ancora un quadro qòinsi~mc. J;li%QgJ1~'a
repecire clmneti.ére slQricamenfe i mot.iyi tu_olttplid fendendl'Hiel\e
1
C9.1l{\)ivqdonctOl)C rcJ qpnplc,sso, Ì vari esitì; Ìt'/a bisogl)aVà aneh~ n~m
1 non
sèhtplioizzare tròp:po, vèdérè-in una sola parabola, unila1cJ:<I.hl).e~te
'\ nòn sloricamen(e, il significato del fa ciflcssione agNca eh~ •ana
fV'e~h'~ cQstitlJi..t'Q il..(o~ct\!Jl\Cl),to e la cosdenza noni)Olò tle1 pensiero
n\~dioevale~ ma anche èlélla cUllura europea l'loderna.
Il ~ritm'volu~ de L!l [il~ofia antica ~1'rF':ancesco A(!0rno jJIQstra
le compimenti del R•nslero greco da 'T'al\!te a SoOJ:.ate lino a :PJalone
e ~Ila sua Scu~a. iJf. completato da l.IJia nu'Ova, cospltuaihibliografia.
www.scribd.com/Baruhk
~raii'G<.·wl";\dopu, no(.Q ~ S~racusa, Ha stu':'!i~~o a l:)renze. In"''!:~"-s~qria della
~j.!o~91.ia aulìclf1'cl/a (acoltà <~ Lettere deii'Y'I'i>iv~r~ità di Fiw\z<. ]<; ouwe di
>J:trlé f.mbJlhca~IOlll sllt Su(\&t~,'S~rar,e,,.Platone, ~h"?to\CI.
Cdl~ob<5;a, a nvtale filosofiéhe o <h cultura
Francesco Adorno
LA FILOSOFIA ANTICA
l. La formazione del pensiero filosofico dalle origini a Platone
VI-IV secolo a.C.
LA FILOSOFIA ANTICA
Il. Filosofia, cultura, scuole, tra Aristotele e Augusto
IV-II secolo a.C.
LA FILOSOFIA ANTICA
III. Pensiero, culture e concezioni religiose
I secolo a.C.-II secolo d.C.
LA FILOSOFIA ANTICA
IV. Cultura, filosofia, politica e religiosità
II-VI secolo d.C.
II
www.scribd.com/Baruhk
FRANCESCO ADORNO
LA FILOSOFIA
ANTICA
l. La formazione del pensiero filosofico
dalle origini a Platone VI-N secolo a.C.
~
Feltrinelli
www.scribd.com/Baruhk
© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Prima edizione: agosto 1961
Ottava edizione: gennaio 1987
Prima edizione neli'"Universale Economica" marzo 1991
ISBN 88-07-81135-9
www.scribd.com/Baruhk
Premessa
La presente edizione
Manteniamo intatto il testo della prima edizione. Nostri più recenti studi
hanno portato a proporre in maniera diversa le problematiche di Platone e di
Aristotele, calati nei loro ambienti e impegnati in precise discussioni sul
significato delle condizioni che permettono i sapere nel 'sapere'. Avremmo
dovuto intervenire in modo radicale. Al momento la 'ricerca' non è conclusa.
È ancora 'ricerca aperta'; è in fase di 'scepsi' (di 'ricerca') e, perciò, 'sospen
diamo il giudizio'. Per questo abbiamo preferito lasciare testo e interpretazio
ne storica di Platone e di Aristotele come la proponemmo allora. Ci limitiamo
a rimandare ai nostri ulteriori studi sul periodo che va da Talete alla scuola di
Aristotele (cfr. Bibliografia).
Si è data, invece, formalmente, altra divisione ai volumi (da due a quat
tro). La divisione stabilisce meglio la 'periodizzazione' storica già suggerita
nella prima edizione e che già allora indicava un diverso metodo storiografi
co e una puntuale attenzione alla storicità del pensiero: I vol., Le componenti
del pensiero greco dalle origini a Platone e alla sua Scuola; II vol., Aristotele,
il pensiero greco romano e altre componenti 'culturali' dal II secolo a.C. al
156 a.C.; III vol., Pensiero, culture e concezioni religiose dal I secolo a.C. al
II secolo d.C.; IV vol., Cultura, filosofia, politica, religiosità dal II secolo d.C.
allti d.C. (529).
Rinnovata e aggiornata è la Bibliografta. Si offrono prima gli strumenti di
lavoro per studiare l'antichità; si mostrano poi i vari metodi storici e gli inte
ressi che si sono mossi, via via e in vari momenti, per l'una o l'altra faccia del
pensiero classico, per uno o altro periodo, per uno o altro autore, per uno o
altro singolo testo: per ogni periodo, per ogni autore si è preferito presentare
la bibliografia in ordine cronologico e non alfabetico; si delinea, in tal modo,
una prima rassegna bibliografica, che è, ad un tempo, un abbozzo -un sug
gerimento - per una storia della storiografia. Non si pretende di dare una
bibliografia completa (impossibile), ma 'selecta': sì utile.
F. A.
v
www.scribd.com/Baruhk
www.scribd.com/Baruhk
Introduzione
Prammatica vorrebbe che si cominciasse l'esposizione della storia
del .p ensiero greco distinguendo una prima fase in cui si avrebbe una
visione mitica dell'Universo - ma ove già sarebbe sottesa l'esigenza di
andar di là dall'apparire fisico e molteplice della realtà per ridurre la
molteplicità all'unità - e una seconda fase, in cui, nella ricerca del
" principio," l'esigenza si farebbe consapevole, e che sarebbe, appunto,
il momento dal quale avrebbe inizio, con Talete, la riflessione filo
sofica. Sotto questo aspetto, in tale passaggio dal mito - inteso come
"categoria," come. un tipo primitivo di spiegazione - al Mgos - in
teso come altra " categoria," come il tipo di spiegazione razionale e
scientifica del reale, - si è in genere veduto il ritmo entro cui si sa
rebbe scandito il primo muoversi della filosofia occidentale. Cosi, fin
dalle origini del pensiero greco, si è parlato di " precorrimenti" e di
" superamenti " e si è detto che l'oceano di Omero avrebbe precorso
l'acqua di Talete, che l'dpeiron di Anassimandro avrebbe. superato l'ac
qua taletiana e cosi via, quando non si è giunti a vedere nelle varie
concezioni dei filosofi greci gli inizii e gli albori di quelle che saranno
le filosofie dei secoli posteriori o contemporanee.
Impostata cosi la questione, si è potuto parlare~ ad esempio, di
" parmenidismo " e di " eraclitismo," e dire che l' eterno problema
dell'Essere e del Divenire, il massimo problema del divino, furono indi
viduati dai cosiddetti Presocratici. Oppure, anche quan,do; giustamente,
si è cercato di precisare, indipendentemente da precorrimenti e supe
ramenti, il significato del pensiero greco, il significato dd pensiero
medievale, di quello umanistico e cosi via, cercando di cogliere né un
in piu né un in meno, ma in che e perché si diversificassero l'uno
dall'altro, si è, infine, almeno per qud che riguarda il pensiero antico,
considerato quel pensiero come avente una sola caratteristica, che· si
VII
www.scribd.com/Baruhk
sarebbe sviluppata e sempre piu svelata · dagli inizii in poi. Si è cosi
potuto dire che il significato intimo dd pensiero greco è consistito nel
l'ideale filosofico della vita culminante nella pura contemplazione, o
che ciò che precisa il pensiero greco è stata la conquista di una conce
zione razionale del tutto, che avrebbe avuto i suoi inizii fin da un Ta
lete, attraverso la purificazione e il disincantamento dal mito, in cui
già, comunque, sarebbe stato presente il medesimo ideale. E, ancora
una volta, in f~zione dd poi si è visto il prima, dalla fantasia e dal
sentimento si è voluto vedere. gradualmente il passaggio alla razionalità,
o meglio a un tipo di razionalità. ·
Certo, oggi, la visione di un mondo greco in sé compiuto e per
fetto, di una civiltà armoniosa e razionale, senza lotte e dolori, serena
in una esemplare misura, è visione che, dopo F. Nietzsche, si è dimo
strata storicamente insostenibile, e per piu vie, giustamente, si· è andati
- eliminati via via certi presupposti teorici e dialettici di Nictzsche
-rintracciando e determinando tutto quello che v'è d'irrazionale (e la
sua influenza) nel mondo greco (E. R. Dodds); mentre per altre vie
si è cercato di rintracciare, tra le componenti della cultura greca, un
unico filone, che, in una specie di lotta contro il torbido e l'irrazionale,
ha composto il dissidio nell'ideale di un'armonia e di una razionalità
non date, ma frutto di una consapevole e progressiva conquista, da
parte; dell'uomo che costruisce se stesso e il mondo che lo circonda
(W. Jaeger, P. M. Schuhl, B. Snell).
E cosi, relativamente alle stesse origini della civiltà greca, mediante
la paziente scomposizione delle varie stratificazioni e di concezioni piu
tarde proiettate al passato, si è potuto negare sia il motivo del cosid
detto " miracolo greco," per cui la civiltà greca sarebbe miracolosa
mente nata da se stessa, indipendentemente da qualsiasi altra forma
di cultura; sia l'opposto motivo - già precisatosi al tempo di Pia. .
tone e pio ancora al tempo in cui si voleva che tutta la luce venisse
dall'Oriente - di una derivazione della civiltà greca da superiori e
pio antiche civiltà orientali. In effetto, una pio affinata coscienza sto
rica tende oggi a rintracciare le origini della civiltà greca - e anche
questa è, in fondo, un'indicazione estremamente vaga e pericolosa, -
in ben pio ampii contesti, con indagini che vanno dallo studio delle
situazioni politiche, sociali, linguistiche del cosiddetto mondo pregreco
e asiatico, allo studio analitico dei primi monumenti greci, con raffronti
e precisazioni indicanti flussi e reflussi, che, alla fine, sempre meglio
dimostrano come sia antistorico parlare di origine di una civiltà.
E poi, molti dei documenti che in genere si sono usati per rico-
Wl
www.scribd.com/Baruhk
struire, ad esempio, l'antitesi tra l'olimpo omerico c la concezione della
vita quale si ricava dall'Iliade - concezione della classe monarchico
aristocratica di un ideale esaltante la vita eroico-achillea - c la poste
riore concezione nata dalle lotte dei demi contro le aristocrazie, di
cui già sarebbero un indice l'esaltazione. del lavoro e della giustizia
e la teogonia di Esiodo e che si sarebbe fondata su piu antiche, au
toctone c asiatiche, concezioni . religiose agrarie - riti dionisiaci, il
culto di Dèmetra e cosi via - per sublimarsi infine nel mistero orfico,
in una visione religiosa dd tutto, sono, a .b en guardare, presunti docu
menti, poiché sono tutti assai posteriori a Omero ed Esiodo, e, con par
ticolare abbondanza, si trovano da Platone io poi. Diremo, anzi, a mo'
di esempio, che i documenti piu ampli per ricostruire il significato, se
vogliamo filosofico, dcll'orfismo son ricavati proprio da Platone e là
dove Platone interpreta per i suoi fini " antiche tradizioni." Il che
non significa che realmente questi contrasti non siano esistiti, che real
mente i poemi omerici non segnino una certa concezione e altra ii
dionisismo; che realmente non vi siano. state tradizioni rituali, agrarie
e cosi via, antichissime e radicate in popoli di origini diverse; ma
è altrettanto vero che quando si crede di ricostruire la teogonia orfica,
anche quando ci si rifà ad Aristofane o a Platone, o di ricostruire le
teogonie di }cronico, di Ellanico, di Museo, di Acusilao, di Epimc
nide, di FerccidediSiro- i cui presunti frammenti sono tutti ricavati
da tardi neopitagorici o neoplatonict, - si corre il rischio di proiet
tare Platone, o Aristotele, o Proclo, o Damascio in epoche ben di
verse dalle loro, e d'interpretare quei singoli e distaccati frammenti
fuor• dei loro contesti, facendo piu opera di montaggio che di sto
ria. Sarebbe, dunque, piu utile fare una storia del dionisismo, del
l'orfismo, del culto di Dèmetra per un verso e, per l'altro verso, del
lo stesso Omerq c di Esiodo e delle massime dei poeti arcaici e di
quelle che, poi, la tradizione ha messo in bocca ai leggendari e
molti " sette sapicnti " \ la misura è la cosa migliore," " osserva
re la pietà," " nulla di troppo," " quando hai appreso a essere co
mandato, saprai comandare," •• conosci te stesso," " non dir male dei
vicini," "l'esercizio è tutto," e cos1 via: Stobeo, III, l, 172), alla fine
di una storia del pensiero antico, ripercorrendo le fasi e gli ambienti
in cui questa o quella tradizione ha assunto questo o quel significato,
senza cosi presumere di " rivivere " il significato mitico o la verità del
la rc:ligiosità orfica con tutto il suo peso dato al peccato originale, al ri
torno dell'anima purificatasi alla patria cc:leste d'onde è venuta, indi
viduando una presunta sapienza riposta, ancora miticamente e poetica
mente espressa.
www.scribd.com/Baruhk