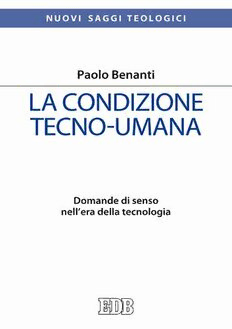Table Of Content2
Edizione digitale della prima edizione cartacea pubblicata nel 2016
Questo e-book contiene materiale protetto da copyright e non può
essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato
o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione
di quanto è stato specificatamente autorizzato dall’editore, ai termini e
alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente
previsto dalla legge applicabile.
Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così
come l’alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti
costituisce una violazione dei diritti dell’editore e dell’autore e sarà
sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla
Legge 633/1941 e successive modifiche.
Questo libro elettronico/e-book non potrà in alcun modo esser oggetto
di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti
diffuso senza il preventivo consenso scritto dell’editore. In caso di
consenso, tale libro elettronico non potrà avere alcuna forma diversa
da quella in cui l’opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla
presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.
Edizione cartacea nel catalogo EDB®:
© 2016 Centro editoriale dehoniano
Edizione digitale:
© 2016 Centro editoriale dehoniano
via Scipione Dal Ferro, 4 – 40138 Bologna
www.dehoniane.it
EDB®
ISBN e-book: 978-88-10-962312
3
INDICE
INTRODUZIONE. IL SENSO DI UN PERCORSO
I – L’ARTEFATTO TECNOLOGICO COME QUESTIONE
ANTROPOLOGICA: UNA MESSA A FUOCO
II – LA COSTITUZIONE TECNOLOGICA DELL’OCCIDENTE
1. La concezione del tempo
2. La concezione dello spazio
3. La matematica
III – SCIENZA E TECNICA DAL SODALIZIO AL DIVORZIO: LE
QUATTRO RIVOLUZIONI
1. La crisi della scienza e la fine della sottomissione
della tecnica
2. La matematica e il problema del suo fondamento
3. Dalla fisica alle fisiche
4. Il divorzio della tecnica
5. L’era dell’informazione e la sfida di elaborare una teoria
dell’informazione
6. Dalla tecnologia una nuova comprensione dell’umano: il caso
serio dell’enhancement
7. La condizione tecno-umana dopo il secolo breve
IV – LA TECNOLOGIA
1. La tecnica-tecnologia come technò (visione classica)
2. La tecnica-tecnologia come essenza della modernità (teoria
critica)
3. La tecnica-tecnologia come costrutto sociale (svolta empirica)
V – LA CONDIZIONE TECNO-UMANA
CONCLUSIONI
APPENDICE. DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E
TECNOLOGIA: UNO SGUARDO SINTETICO
Un’intelligenza in grado di capire la tecnica: l’originalità della
4
Caritas in veritate
5
A don Fausto Sciurpa, maestro e guida
nell’intellectus quaerens fidem della mia formazione
6
Introduzione
IL SENSO DI UN PERCORSO
Zu jeder ω-widerspruchsfreien rekursiven Klasse x von Formeln gibt es rekursive
Klassenzeichen r, so dass weder v Gen r noch Neg (v Gen r) zu Flg (x) gehört (wobei v die
freie Variable auf r ist).
K. GÖDEL, Satz VI1
Karl Rahner, in un piccolo saggio sul libro religioso scritto nella
seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, si chiede come
dovrà essere tale forma di letteratura per essere adeguata al nostro
tempo.2 Il teologo tedesco sottolinea come la letteratura religiosa
dovrebbe essere anzitutto introduzione alle fonti originarie della genui‐
na attività religiosa e non l’elaborazione di un complicato apparato
religioso-ascetico, per il quale quelle scaturigini sono cose
implicitamente ovvie o puri presupposti.
Questa letteratura, prosegue sempre Rahner, per poter essere
letteratura significativa, dovrà poter essere letta anche dagli «uomini
nuovi», cioè da tutti quegli uomini che hanno un modo di guardare al
mondo e all’essere umano plasmato da una mentalità di scienziati e
tecnici moderni, tanto più che noi tutti ne portiamo l’impronta e ne
siamo influenzati. Inoltre essa non potrà, in questa fase post-
individualistica dell’umanità, generare l’impressione di essere un
analgesico per il bisogno e il dolore, in fondo insignificanti, di
un’«anima bella» introvertita. Non sostituirà la medicina, la
psicofarmacologia, la psicologia del profondo, ma le presupporrà.
Un’adeguata letteratura religiosa dovrà saper lasciare incominciare i
problemi morali solo là ove essi veramente hanno inizio.
Secondo il teologo tedesco, questo si tradurrà nel fatto che tale forma
di libro non parlerà mai di Dio come se fosse riuscita a intendersela
con lui e lo avesse ben circoscritto con proposizioni filosofiche e
massime morali. Dovrà osservare e accettare, seguendo il
ragionamento di Rahner, l’interiore pluralismo dell’uomo; nell’uomo
non «integrerà» tutto nella religione con fretta e indiscrezione;
7
dimostrerà la sua autenticità lasciando che il mondano sia mondano e
rendendolo così comprensibile come presupposto della genuina
religiosità. Tuttavia, conclude Rahner, il libro religioso avrà anche il
coraggio di esigere che l’uomo riconosca e accetti di essere
infinitamente di più che un uomo: la beatitudine del dolore accettato,
nel quale il finito scopre l’incomprensibilità dell’Amore infinito.
Questo testo prende ispirazione da queste coordinate e cerca di
presentarsi come un contributo di tipo religioso, nel senso descritto da
Rahner, alla comprensione del mondo della tecnica e della tecnologia.
Il contributo è di tipo religioso per due motivi: da un lato si interroga
sulla relazione uomo-mondo attraverso l’artefatto tecnologico
(«religioso» inteso quindi nell’etimo latino di religere come guardare
con attenzione), dall’altro è religioso perché ha la pretesa di dire
qualcosa sull’uomo e sulla sua condizione nel mondo, una pretesa
animata dalla fede, cioè aperta all’intrinseca trascendenza della
persona.
Viviamo oggi in una realtà immersa nella tecnologia: quotidianamente
il nostro rapporto con la realtà è mediato da artefatti tecnologici.
Tuttavia una comprensione sistematica di cosa sia la tecnologia non è
semplice né banale.
A ben guardare la nostra contemporaneità si affacciano alla coscienza
numerose e, talvolta, inquietanti domande. Che cosa significa essere
umani in un’epoca di incomprensibile complessità tecnologica e
cambiamento come la presente? Come gestire lo sviluppo tecnologico?
Quali sono i limiti da porre? E come far sì che tali limiti siano soglie
invalicabili e non un inefficace flatum vocis?
Se vogliamo avere qualche prospettiva di gestione di tale
complessità, avremo bisogno di ricomprendere le, e talvolta anche
sfuggire dalle, catene dell’attuale ipotesi sulla razionalità tecnologica,
del progresso e dalla presunzione di una certa neutralità dell’artefatto
tecnologico in sé. Dovremmo trovare il modo di ricordare che è una
priorità ineludibile il mantenere l’impegno dei valori.
Se da un lato è innegabile che gli esseri umani sono in co-evoluzione
con le loro tecnologie fin dagli albori della preistoria, ciò che ora
appare diverso e nuovo è il fatto che siamo passati al di là di interventi
tecnologici esterni per trasformare noi stessi dall’interno verso
l’esterno – fino a poter rifare il sistema Terra stesso. Far fronte a
8
questa nuova realtà significa liberarci da tali categorie come umano,
tecnologico e naturale per abbracciare una nuova relazione al mondo
che potremmo definire tecno-umana?
Il testo che segue vuole provare a fornire una comprensione
filosofica e teologica del fenomeno tecnologico mettendo
contemporaneamente in luce le dimensioni etiche ad esso associate.
Nel costruire una visione d’insieme della tecnica-tecnologia, ci si
chiederà in un primo momento come guardare agli artefatti tecnologici
(c. 1), come è stato possibile che l’Occidente abbia conosciuto uno
sviluppo tecnologico senza precedenti né paragoni rispetto ad ogni
altra cultura umana e cosa questo sveli e significhi per la tecnica (c. 2)
e quale sia il contesto in cui oggi si attua e si comprende la tecnica (c.
3).
Dopo aver descritto, mediante questa sorta di fenomenologia
problematizzante, il mondo degli artefatti tecnologici, si avrà cura di
presentare i diversi livelli a cui si può comprendere la tecnologia (c.
4).
Alla luce degli elementi emersi e della natura del fenomeno
tecnologico, si potrà delineare e approfondire cosa significhi per
l’uomo questa precipua e singolare relazione con il mondo che avviene
mediante l’artefatto tecnologico: quello che abbiamo definito come
condizione tecno-umana (c. 5). Chiuderà il percorso proposto, a mo’
di appendice, una sintesi della comprensione che della tecnologia offre
la dottrina sociale della Chiesa, per far vedere come alcune istanze
emerse dal percorso proposto trovino eco e riflesso in questi contributi
del magistero.
Infine una piccola nota di stile. Abbiamo scelto di cominciare ogni
capitolo con una sorta di citazione evidenziata dalla diversa fattezza
tipografica del testo. I brani proposti vogliono essere una sorta di
commento a quanto verrà approfondito nel capitolo. Abbiamo scelto di
fare questo nella forma del segno: cercheranno di offrire nella
continuità di senso un’ulteriorità di significato. Questo oltre è offerto al
lettore in una modalità che a nostro giudizio è evocativa e narrativa:
cerca di rendere evidente come la tecnologia sia una componente
antropologica dell’esistere umano che coinvolge non solo la tecnica e
la scienza ma tutti i modi di comprendere e comprendersi dell’uomo.
9
1 K. GÖDEL, «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter
Systeme I», in Monatshefte für Mathematik und Physik 38(1931), 187.
2 Il saggio in questione è intitolato «Die Zukunft des religiösen Buches»; è stato pubblicato in
Schriften zur Theologie, VII, Benziger, Einsiedeln 1966, 511-515, ed è apparso in lingua italiana
in Nuovi saggi 2, Paoline, Roma 1968, 645-651.
10