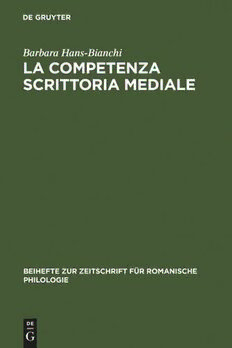Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
HERAUSGEGEBEN VON GÜNTER HOLTUS
Band 330
BARBARA HANS-BIANCHI
La competenza
scrittoria mediale
Studi sulla scrittura popolare
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
2005
Gedruckt mit Unterstützung der Kurt-Ringger-Stiftung, Mainz
Dedico questa ricerca alla memoria di
Diomira Sabina Barile
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 3-484-52330-1 ISSN 0084-5396
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 2005
http://www.niemeyer.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: Laupp & Göbel, Nehren
Einband: Norbert Klotz, Jettingen-Scheppach
Sommario
Introduzione 1
1. II corpus e i parametri dell'indagine 3
1.1. Caratteristiche generali 3
1.2. Parametri socioculturali 5
1.3. Parametri testuali e situazionali 9
1.4. Rapporti di correlazione tra i parametri 14
2. Che cos'e la scrittura? 17
2.1. Lo status teorico del segno linguistico scritto 17
2.1.1. II filone dipendentista 17
2.1.2. L'interpretazione autonomista 19
2.2. Le mille facce della scrittura 26
2.2.1. Sistema grafico-visivo vs. sistema fonico-uditivo 26
2.2.1.1. Le caratteristiche del canale 26
2.2.1.2. Le unitä dello scritto 30
2.2.1.3. I sistemi di scrittura 32
2.2.2. Scrittura vs. oralitä 35
2.2.3. Lingua scritta vs. lingua parlata 42
2.2.3.1. Le dimensioni di variabilitä 42
2.2.3.2. La lingua scritta nel diasistema 43
2.2.3.3. La dimensione diamesica di variabilitä 47
2.2.3.4. II diasistema dell'italiano contemporaneo 48
2.2.4. Le condizioni comunicative tra distanza e immediatezza.... 50
2.2.4.1. La variazione diamesica: universale e contingente 50
2.2.4.2. II rapporto tra concezione e mezzo 53
2.2.5. L'aspetto mediale della scrittura 57
2.2.5.1. Oltre la fonografia 57
2.2.5.2. I principi ortografici 62
2.2.5.3. L'architettura del sistema ortografico 65
2.2.5.4. Interpunzione e forma esteriore del testo 67
2.2.6. II processo dello scrivere (e del leggere) 70
2.2.6.1. L'atto scrittorio 70
2.2.6.2. La lettura 77
2.3. La competenza scrittoria 82
V
2.3.1. L'acquisizione della competenza scrittoria mediale 86
2.3.2. L'inadeguatezza scrittoria mediale 91
3. La forma esteriore del testo 103
3.1. Introduzione 103
3.2. Rilevamento dei dati 106
3.2.1. L'impaginazione del testo scritto 106
3.2.2. II tipo di scrittura 109
3.2.3. L'articolazione del testo nello spazio scrittorio Ill
3.2.4. La segnalazione della sequenza delle pagine 113
3.2.5. Le revisioni nel testo 115
3.2.6. II grado di leggibilitä 117
3.3. Analisi dei dati 121
3.3.1. II livello di istruzione scolastica 121
3.3.2. II periodo di redazione 123
3.3.3. L'etä degli scriventi al momento della redazione 125
3.3.4. La generazione scolastica 127
3.3.5. II sesso 128
3.3.6. II settore occupazionale 129
3.3.7. La localitä di provenienza 132
3.3.8. II tipo di testo e il grado di distanza comunicativa 135
3.4. Conclusione 137
4. I segni di interpunzione 141
4.1. Introduzione 141
4.2. Rilevamento dei dati 145
4.2.1. II repertorio di segni interpuntori 145
4.2.2. L'uso dei segni interpuntori 151
4.2.3. La segnalazione del discorso diretto 153
4.2.4. II grado di articolazione interpuntoria del testo 156
4.3. Analisi dei dati 158
4.3.1. II livello di istruzione scolastica 158
4.3.2. II periodo di redazione 159
4.3.3. L'etä 160
4.3.4. La generazione scolastica 161
4.3.5. II sesso 162
4.3.6. II settore occupazionale 164
4.3.7. La localitä di provenienza 166
4.3.8. II tipo di testo e il grado di distanza comunicativa 167
4.4. Conclusione 169
5. I segni grafematici e paragrafematici 173
5.1. Introduzione 173
5.2. Rilevamento dei dati 179
VI
5.2.1. Devianze «fonicografiche» 179
5.2.1.1. Le grafie complesse (digrammi, trigrammi e allografie).... 179
5.2.1.2. Le grafie «fonetiche» 183
5.2.1.3. Le grafie «dialettali» 188
5.2.1.4. L'accento «soprasegmentale» 197
5.2.1.5. Sintesi 200
5.2.2. Devianze «morfologicografiche» 201
5.2.2.1. Le maiuscole 202
5.2.2.2. L'agglutinazione lessicale 209
5.2.2.3. La deagglutinazione 215
5.2.2.4. La discrezione 215
5.2.2.5. L'apostrofo 220
5.2.2.6. La distinzione tra omofoni 224
5.2.2.7. Sintesi 227
5.2.3. Devianze «visivografiche» 229
5.2.4. II grado di correttezza grafica 235
5.3. Analisi dei dati 243
5.3.1. II livello di istruzione scolastica 243
5.3.2. II periodo di redazione 245
5.3.3. L'etä 246
5.3.4. La generazione scolastica 247
5.3.5. II sesso 249
5.3.6. II settore occupazionale 251
5.3.7. La localitä di provenienza 253
5.3.8. II tipo di testo e il grado di distanza comunicativa 256
5.4. Conclusione 258
6. Conclusioni 269
6.1. II profilo della competenza scrittoria mediale 269
6.2. La rilevanza dei diversi fattori socioculturali 274
6.2.1. II livello di istruzione scolastica 274
6.2.2. II periodo di redazione 275
6.2.3. L'etä 276
6.2.4. La generazione scolastica 277
6.2.5. II sesso 278
6.2.6. II settore occupazionale 281
6.2.7. La localitä di provenienza 283
6.3. L'adeguamento alia situazione comunicativa 285
6.4. Tirando le somme 289
Bibliografia 291
Appendice 309
Appendice 1. Lunghezza dei testi 309
VII
Appendice 2.a Quadro sinottico dei dati nel corpus totale 310
Appendice 2.b Quadro sinottico dei parametri nel corpus totale ... 312
Appendice 2.c Testi redatti dallo stesso scrivente 313
Appendice 3. Distribuzione percentuale dei dati socioculturali
e testuali nel Cbase (29 testi) 313
Appendice 4. Percentuali comparative nei gruppi socioculturali
e testuali 315
Appendice 5. Tabelle contenenti i dati empirici dei singoli testi .... 319
Appendice 6. Trascrizione di un brano di ciascun testo del Ctot.... 338
Indice Analitico 349
VIII
Introduzione
La presente analisi linguistica parte dalla ricchissima raccolta di testi delMr-
chivio Diaristico Nationale di Pieve S. Stefano, in provincia di Arezzo, con
l'aiuto della quale cercherö di dare una risposta alia domanda, per ora molto
generica: Come scrive chi ha un basso livello di istruzione scolastica?
II rapporto tra livello socioculturale e scrittura e stato oggetto di molte-
plici indagini di varia ispirazione: sociolinguistiche, filologiche, dialettologiche,
antropologiche, pedagogiche (v. cap. 2.2.). Sono stati cosi focalizzati diversi
aspetti di tale rapporto:
le varietä di lingua e di repertorio usate nei testi di origine «popolare» e
la loro collocazione nel diasistema dell'italiano;
la storia linguistica delle forme oggi relegate nell'ambito della diastratia
bassa;
il ruolo dei dialetti nell'espressione scritta dei dialettofoni;
i mezzi espressivi non ortodossi della scrittura popolare, anche in chiave
socio-politica;
il processo di apprendimento della scrittura e il legame con la lettura.
Spesso, perö, la classe socioculturale viene definita in modo circolare sulla base
dell'espressione scritta. Nei termini «scrittura dei semicolti» e «italiano popo-
lare» si fa riferimento, perlomeno implicitamente, al criterio della competenza
scrittoria imperfetta (rispetto alia norma) per definire il gruppo socioculturale
cui appartengono gli scriventi; questo procedimento sembra inevitabile, quando
manchino altre informazioni sull'autore di un testo, per cui lo scritto stesso
costituisce Tunica chiave interpretativa. In questo modo, tuttavia, manca uno
strumento affidabile per capire, prima di aver esaminato un testo, chi farä parte
del gruppo dei «semicolti» ο chi userä «l'italiano popolare» scritto.
La seguente indagine si propone di rovesciare tale prospettiva, partendo
dal livello di istruzione scolastica (quale principale indice del livello culturale)
per arrivare alle competenze effettive nella scrittura. Inizialmente ero orien-
tata verso un'analisi di tipo prevalentemente variazionale e sintattico, ma nel
corso dello studio sui testi ho avvertito la necessitä di approfondire e sistema-
tizzare maggiormente l'aspetto della scrittura mediale, e ho deciso perciö di
concentrarmi sugli ambiti dell'aspetto esteriore dei testi (cap. 3.), della grafia
(cap. 5.) e dell'interpunzione (cap. 4.). Infatti, le indagini esistenti sugli aspetti
grafici e formali dell'italiano popolare rimangono di norma ad un livello di
1
pura descrizione dei fenomeni riscontrati. Mi sono quindi prefissa l'obiettivo
di inserire i dati rilevabili riguardanti la scrittura mediale in un quadro teorico
che focalizzasse la scrittura in quanto sistema, i processi dello scrivere, e i mec-
canismi di acquisizione della scrittura: cerchero di mettere a frutto i risultati
delle ricerche in questi campi nello specifico contesto della scrittura popolare
italiana, avvicinando cosi delle discipline sinora senza contatto fra di loro.
II rilevamento dei dati procederä sia a livello qualitativo (con la descri-
zione e classificazione dei fenomeni riscontrati) che a livello quantitativo (con
le occorrenze totali e percentuali dei vari dati). Nell'analisi dei dati verificherö
l'influenza di diversi fattori socioculturali sui risultati ottenuti, al fine di for-
mulare delle ipotesi sugli elementi che contribuiscono a formare e ad orientare
la competenza mediale degli scriventi.
Possiamo dunque riformulare la domanda iniziale in modo piü preciso:
Qual e la reale competenza scrittoria mediale dei nostri scriventi con istruzione
elementare e quali fattori sono da ritenere costitutivi di tale competenza?
Prenderö in considerazione, inoltre, il peso della situazione comunicativa
(cioe del tipo di testo e delle condizioni comunicative concrete) nelle scelte
che lo scrivente compie all'interno della propria competenza, mettendo a con-
fronto con il nostro corpus di base un secondo gruppo di testi di scriventi con
piü alta scolaritä.
I miei ringraziamenti vanno alia Nachwuchsförderung Berlin e alia Studien-
stiftung des Deutschen Volkes per il loro contributo economico e ideale.
Ringrazio Saverio Tutino e tutti i collaboratori dell'Archivio Diaristico
Nazionale per la loro disponibilitä e accoglienza.
Sono riconoscente per gli innumerevoli suggerimenti, fertili critiche e per
l'ospitalitä offerti dai professori Peter Koch, Andreas Blank, Wulf Oesterrei-
cher, Daniela Pirazzini e Richard Waltereit. Ringrazio in particolare il prof.
Günter Holtus per aver accolto questo lavoro per la pubblicazione nei Beihefte
zur Zeitschrift für romanische Philologie.
Sono altresi in debito per il loro aiuto concreto e disinteressato con i pro-
fessori Ugo Vignuzzi, Paolo D'Achille, Luciano Giannelli, Miriam Voghera,
Francesco Avolio, Gabriele Iannäccaro e Luca Renzi.
Ringrazio in particolare la prof. Silvia Eichhorn-Jung del suo sostegno
importante e dell'amicizia.
Per la comprensione amichevole e generosa ringrazio la prof. Giovanna
Cermelli e le mie colleghe dott. Gabriele Knorre-Fiordigiglio e dott. Violet
Schlossarek.
Tutta la mia gratitudine spetta alia mia famiglia, a mio marito, dott. Gino
Bianchi, che mi ha accompagnato con tanta pazienza e dedizione in questa
impresa, ai miei genitori Hannelinde Dausend e Werner Hans che mi hanno
dato forza e fiducia, a Daniel e Luisa Sabina che mi illuminano la vita.
2