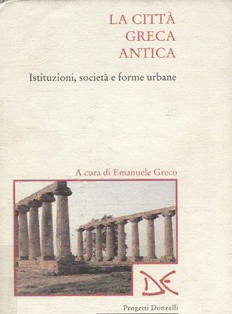Table Of Content•
•
•
•
•
•
•
•
.
,
•
I s t i t u z i o n i , società e f o r m e u r b a n e
•
•
•
-
-
•
~
•
-
.
-
•
•
•
•.
.
Gli
A c u r a E m a n u e l e G r e c o
•
•
Progetti Donzelli
LA CITTÀ GRECA ANTICA
Istituzioni, società e forme urbane
a cura di Emanuele Greco
© 1999 Donzelli editore, Roma
ISBN 88-7989-507-9
_ _ _ _ _ _ _ LA CITTÀ GRECA ANTICA _ _ _ _ _ __
Indice
Introduzione
p.
VII
di Emanuele Greco
Parte prima. La città
La polis: società e istituzioni
5
di Mario Lombardo
La polis e lo sfruttamento della terra
37
di Luigi Gallo
Le necropoli e i riti funerari
55
di Angela Pontrandolfo
Verso il canone della polis
83
di Piero Lo Sardo
Parte seconda. Le città
L'Eubea
• 99
di Fabrizio Pesando
Le città cretesi
111
di Athanasis Kalpaxis
Il Peloponneso
129
di Massimo Osanna
Atene
161
di Emanuele Greco e Massimo Osanna
V
',Indice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mileto
183
di Fausto Longo
Le città del Mar Nero
205
di Aleksandra Wasowicz
Thasos
221
di Didier Viviers
Megara Iblea
251
o
di Miche! Gras e Henri Tréziny
!mera
• 269
di Nunzio Allegro
Ischia e Cuma
303
di Lorena Jannelli
\
••
Metaponto
• 329
di Liliana Giardino e Antonio De Siena
Poseidonia
di Fausto Longo
Cirene
385
di Ida Baldassarre
Le città focee
395
di Miche! Bats e Henri Tréziny
0413 Turi
di Emanuele Greco
Alessandria
431
di Fabrizio Pesando
453 Indice dei nomi e dei luoghi
462 Elenco delle illustrazioni
464 Gli autori
VI
_ _ _ _ _ _ _ LA CITTÀ GRECA ANTICA _ _ _ _ _ __
Introduzione
Obiettivo principale di questo libro è il tentativo di fondere i due
aspetti principali riguardanti la città greca antica che, anche a una scor
sa solo superficiale della immane bibliografia sull'argomento, risultano
tradizionalmente separati: la città nel senso di comµnità (quella che i
civitas city
romani chiamavano e che oggi gli inglesi chiamano e i fran
cite') urbs
cesi e la città nella sua dimensione materiale (cioè le latine e
oppidum, town ville).
o l'inglese e la francese Si vedrà che anche nella
lingua greca questi due concetti erano connotati da due distinte paro
!~, al contrario di quanto avviene nella lingua italiana, che usa la paro
la città in entrambi i sensi.
L'argomento occupa una sua indiscussa e ininterrotta centralità nel
dibattito che la cultura contemporanea destina allo studio del!' Antico
in generale1 Nella prefazione a un suo recente libro sullo spazio pub
•
blico nelle città greche, Tonio Holscher (1998) dopo aver riproposto
sui diversi approcci alla città greca una gustosa ed acuta osservazione
di Oswyn Murray (1990), per il quale, se per un tedesco la città greca
può essere descritta solo in un manuale di diritto costituzionale, per un
francese è una santa comunione, per un inglese è un incidente storico e
per un americano un misto di pratiche mafiose e di libertà individuali,
annuncia di voler seguire nel suo studio una prospettiva generazionale
piuttosto che nazionale. Ciò vuol dire, per lo studioso tedesco, recu
perare la dimensione più squisitamente politica e protestare contro la
diffusa, attuale tendenza a privilegiare la sfera sacrale come fattore de
terminante, quando si procede alla definizione della città greca2 A noi
•
sia consentito ricordare anche la buona tradizione italiana, che al pro
blema ha dato contributi di grande rilevanza, di norma non adeguata
mente utilizzati; mi riferisco in particolare a tutta quella serie di studi
' Per una riflessione storiografica su questo punto, cfr. Finley 1984.
1 Cfr. per esempio de Polignac 1984 e le osservazioni di van Effenterre 1985.
VII
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emanuele Greco _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
segnati dall'approccio socio-economico, che in Italia è stato usato, nel
la stragrande maggioranza dei casi, con equilibrio e misurato senso cri
tico3; argomenti ora ripresi e rilanciati da uno studioso americano4
•
Lo scopo di questo libro non è però quello di produrre una nuova
sintesi sul problema delle origini della città greca, ma di offrire elementi
di riflessione a partire da situazioni concrete, per un periodo che va
polis
dalla formazione della fino alla morte di Alessandro Magno, se
condo una periodizzazione che, se pure generica e non certo valida a
dare conto dei momenti di cesura (specialmente quello finale) in ogni
angolo del Mediterraneo, viene comunemente utilizzata per segnare il
poleis.
percorso dell'esperienza civile delle libere
Non pochi autori5 ma solo a partire da qualche anno a questa parte,
,
tenuto conto della produzione scientifica corrente, hanno lamentato la
separazione di cui si diceva tra la città greca in quanto oggetto di studio
storico e la dimensione materiale e archeologica del problema. Le ragio
ni sono abbastanza evidenti e qui le riassumiamo solo schematicamente.
Il punto di osservazione storico dominante (già nell'Antichità stes
sa, se solo si pensi a Tucidide) è sempre stato quello politico; la storia è
fondamentalmente (e per alcuni ancora oggi solamente) storia politica.
È evidente come, in questo quadro, il contributo dell'archeologia sia
assolutamente insignificante, per non dire nullo. Ne consegue che oc
corre diffidare degli archeologi, che si rifugiano nella storia politica con
i ferri del loro mestiere, senza discrezione metodica e con una imme
diatezza di sconcertante ingenuità. Punto di incontro tra la storia poli
tica e l'archeologia finiscono così per essere solo le belle illustrazioni
(vasi, edifici, statue) che quest'ultima può fornire per montare eleganti
copertine o apparati iconografici di saggi di storia.
Tuttavia, se una caratterizzazione fondamentale dobbiamo ricono
scere all'andamento dei nostri studi, specialmente nel secondo dopo
guerra, questa non può che riguardare il profondo allargamento della
prospettiva storica a una serie di aspetti (società, economia, commer
cio, abitudini alimentari, riti funerari ecc.) per i quali la ricerca archeo
logica non solo è i,nportante, ma addirittura insostituibile. Dall'altro
canto, è avvenuto che l'archeologo - e qui mi riferisco essenzialmente
a quello che indaga lo spazio urbano antico - difficilmente ha affronta
to la ricerca sul terreno con strumentazione concettuale adeguata, ri
manendo, per lo più, prigioniero della sua matrice di storico dell'arte.
'Cfr. per esempio Mele 1978, 1979; Ampolo 1980; Musti 1981; Lepore 1987.
'Tandy 1997.
'Snodgrass 1993; Greco - Torelli 1983; Greco 1989; Fischer-Hansen 1996.
VIII
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Introduzione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
La conclusione è che la storia dell'urbanistica greca non ha dato fin qui,
al polis
a ben vedere, un contributo rilevante dibattito sulla in generale.
Inoltre, i recenti tentativi di ripercorrere lo sviluppo della città gre
ca in età classica prodotti da architetti e studiosi di storia dell'architet
tura6 hanno suscitato più critiche che consensi, non solo per il caratte
re spesso aleatorio e filologicamente infondato di molte delle loro ri
costruzioni, ma per la povertà e l'angustia della prospettiva storica, tut
ta dominata da ansie teleologiche mirate all'esaltazione della perfezio
ne greca e del modello democratico, ovviamente presunto, come è sta
to ben messo in luce dai critici più avveduti7 Di ben altro spessore so
•
no invece alcune delle ricerche avviate da qualche anno dal Copenha
gen Polis Centre, diretto da M. H. Hansen, che si propongono come
importante punto di riferimento, proprio perché tentano la sintesi tra
tradizione letteraria, documentazione epigrafica e stato delle cono
scenza archeologiche8
•
Nel libro che qui presentiamo, abbiamo voluto perciò procedere
partendo dalla necessità di valorizzare la documentazione materiale,
archeologica. È una scelta che ha bisogno di qualche chiarimento. Rac
poleis
colte enciclopediche specifiche o articoli relativi a singole in en
ciclopedie più generali certo non difettano9 In questi repertori noi pos
•
siamo consultare le voci corrispondenti alle singole città, nelle quali
troveremo, di norma, una breve informazione sulle vicende del sito,
una scheda sintetica con la storia delle scoperte, lo stato delle ricerche,
l'esame di singole situazioni monumentali, la bibliografia e, a volte, an
che qualche illustrazione. Nella recente collana einaudiana / Greci, a
cura di Salvatore Settis, ancora in corso di pubblicazione, il lettore tro
verà invece una serie di capitoli di inquadramento generale, di grande
utilità e con un taglio critico-problematico di notevole spessore, per
orientarsi entro il dibattito scientifico più avanzato che, ovviamente, ri
guarda tutta la cultura greca.
Dal nostro canto, abbiamo da un lato selezionato un certo numero di
città (e tra breve diremo con quali criteri); dall'altro, abbiamo cercato di
evitare di dare ai singoli contributi un taglio da voce d'enciclopedia o da
guida archeologica del sito preso in esame. L'approccio che abbiamo pri
vilegiato e cercato di rispettare è quello di mettere in evidenza i proble-
'Mi riferisce> al ben noto libro di Hoepfner e Schwandner (1994).
' Musti 1995; Ferrucci 1996.
. 'A questo proposito si segnala soprattutto la grossa raccolta relativa all'architettura de
gli edifici pubblici della città greca (Hansen - I'ischer Hansen I 994 ).
' Si pensi alle singole voci della Realencyclopaedie, del!' Enciclopedia dell'Arte Antica o
della Princeton Encyclopaedia of Classil·al Sites, per fare qualche esempio.
IX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emanuele Greco _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
mi fondamentali che lo stato delle nostre conoscenze permette di defini
re e valorizzare nelle città di volta in volta prese in considerazione, com
presi brevissimi cenni alla storia delle scoperte, che riteniamo necessari
non al fine di redigere una cronaca, ma per mettere in evidenza i diversi
modi con cui gli studiosi hanno affrontato la ricerca sul terreno.
Carmine Ampolo ha, giustamente, in più di un' occasione' attirato
0
l'attenzione su un'acuta osservazione di Gaetano De Sanctis 11 Vi si pro
•
pone un approccio di straordinaria attualità, che vale la pena di rileggere:
polis
Lo stesso concetto di per abbracciare del pari Atene, Sparta, Marsiglia,
la Parrasia, I' Atamania, deve ridursi a tale astranezza, deve talmente spogliarsi
di ogni lineamento concreto da rassomigliare assai al concetto che sant' Agosti
prope nihil.
no dava della materia come metafisico componente della sostanza:
Tendenze più o meno manifeste alla generalizzazione non mancano
anche ai nostri giorni e non tutte vanno respinte, ovviamente, se è vero
che le riflessioni, soprattutto quelle di carattere teorico, sono da utilizza
re come strumenti euristici, quando si vanno ad aggregare le diverse do
cumentazioni12. Ma certamente la generalizzazione è sconsigliata quando
si parla di urbanistica greca, tranne che per quella serie di elementi co
muni che segnano, per così dire, il paesaggio di una città greca, renden
dola riconoscibile e distinguibile da un'altra, come avvertiva Strabone
4, 2) che invitava a non confondere una città fenicia con una greca,
(111,
facendo ricorso allo schema, cioè al disegno del suo impianto urbano.
Dunque la storia della città greca, sotto il profilo materiale, è essen
zialmente la storia delle singole città. La nostra selezione doveva perciò
procedere secondo due coordinate, quella geografica, regionale, e quella
cronologica, in modo da forni re una significativa esemplificazione dei va
ri ,,modelli» di città a partire dal continente greco e dalle isole, fino ali' A
sia minore, al Mar Nero, alla Magna Grecia, alla Sicilia, ali' Africa, alle co
ste meridionali della Francia e a quelle orientali della Penisola iberica.
Anche il critico più distratto potrà facilmente elencare la serie di città
non comprese in questa silloge; per fare un esempio, non vi si trovano
Olinto né Priene né Cassope, ma la loro esclusione sarà più facilmente
giustificabile se si tiene conto che avendo privilegiato gli aspetti proble
matici della storia degli impianti urbani greci abbiamo evitato di moltipli
care gli esempi, trattandosi in quei casi di città inquadrabili nella tradizio-
•
'' Ampolo 1980, 1987-89.
" Si tratta della recensione, apparsa in «Rivista di Filologia e istruzione classica•, 1934,
12, pp. 95 sgg., alla prima edizione ( 1932) del libro di V. Ehrcnbcrg, Der Staat der Griechen,
i,1 seguito più volte ristan1patl> e tradotto in varie lingue.
'' Si vedano, per esempio Lepore 1987; Sakellariou 1989; Ampolo 1987-89; Murray 1990;
A,npolo 1996.
X
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Introduzione _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ne che discende nettamente dagli ambiti coloniali (come nel caso di Olin
to e Cassope), o sortite dalle esperienze urbanistiche greche successive al
i'
adozione dei principi della città regolare a scacchiera, introdotti per la
prima volta nel corso del V sec. a.C, come nel caso di Priene.
Fin qui possiamo aver dato l'impressione di seguire un concetto ul
polis,
tratradizionale di intendendone la storia urbana unicamente co
me articolazione dei monumenti compresi entro le mura. Avendo già
avuto in passato l'occasione di affrontare il problema sotto un'angola
zione ben diversa 13 ci limiteremo qui a riassumere brevemente la so
,
stanza della questione.
polis
È diventato ormai banale affermare che il concetto di è il risul
tato della inscindibile fusione dei due elementi principali che lo com
l'asty chora, Polis
pongono, (cioè lo spazio urbano) e la il territorio. è
generalmente la comunità dei cittadini, che si distribuisce nello spazio di
cui è sovrana, all'interno del quale distinguiamo l'abitato principale
(quella che noi chiamiamo città) e la campagna, sede delle attività pro
duttive primarie (quelle agrarie) esercitate da cittadini che risiedono in
città o nei distretti rurali, villaggi, demi o fattorie isolate, senza che la re
polites
sidenza sia dirimente per quanto attiene lo statuto di (cittadino),
cioè di colui che gode dei pieni diritti (vale a dire i maschi adulti). Me
no banale risulta la riaffermazione del concetto, se si considera la storia
archeologica del problema. Così, per quanto riguarda la storia monu
mentale della città greca, la letteratura scientifica è stata a lungo domi
solo
nata dalla convinzione che per urbanistica si debba intendere la sto
ria dello spazio urbano entro le mura. È fin troppo facile obiettare, se
questo dovesse essere il punto di vista da cui osservare il fenomeno, che,
per fare un esempio macroscopico, Sparta non sarebbe una città, perché
mantenne a lungo la sua organizzazione politica in forma di distretti ru
rali, cd ebbe le mura solo nel III scc. a. C. Anche la scelta di studiare in
tal modo la storia urbana finisce così con il rientrare entro quell'ottica
generalizzante che non arriva a comprendere la grande diversità spazia
le e temporale con cui il fenomeno si manifestò, e che produce risultati
parziali, dominata com'è da una visione largamente modernizzante. C'è
poi un altro aspetto che non va sottovalutato; certamente, dal punto di
vista fenomenico (e l'archeologia studia le cose che appaiono, quelle
concrete) non si possono mettere sullo stesso piano i monumenti della
chora,
città con quelli della campagna; nella se si fa astrazione da quei
casi in cui la città ha impiantato nel territorio grandi santuari (templi cd
'' Greco - Torelli 1983.
Xl