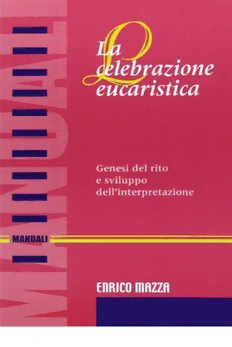Table Of Contentqrtebjazione
eucaristica
Genesi del rito
e sviluppo
dell'interpretazione
mozzo
ehrico
Naio nel 1940. sacerdote della dioce
si di ionio (nllla - Guastalla ha stu
dialo teologia alla Pontificia Univer
sità Gregoriana, specializzandosi gol
In liturgia e teologia del sacrameutl
al Pontificio Istituto Liturgico dell'A
teneo S. Anselmo di Roma. Docente di
liturgia e teologia dei sacramenti al
lo Studio Teologico Interdlocesano
di Reggio Emilia dal 1968, dal 1987 à
docente di storia della liturgia all'U
niversità Cattolica del S. Cuore di Ml-
lane e ha tenuto corsi e seminari In
varie istituzioni accademiche (Facol
tà Teologica dell'Italia Settentrionale
di Milano; Peniilicio Istituto Liturgico
di Roma: Institut Supàrleur de litur
gie - Facultà de Théologie de l'Institut
Cathollque di Parigi). Tra le sue pub
blicazioni: le odierne preghiere eu
caristiche (2 voli.. EDB. Bologna 1991;
trad. inglese): l'anafora eucaristica.
Studi sulle 0f7g/0/(C.l.V. - Edizioni Litur
giche. Roma 1992: trad. Inglese); taml-
stagogla. le catechesi liturgiche della li
ne del Quarto secolo e il loro metodo
IC.LU. - Edizioni Liturgiche. Roma 1996;
trad. inglese); Continuità e disconti
nuità. Conce/ioni medievali dell'euca
ristia a conironto con la tradizione del
Padri e della liturgia (C.l.W. - Edizioni
Liturgiche. Roma 2001): la celebrazio
ne della penitenza. Spiritualità e pa
storale IEDB. Bologna 2001); la cele
brazione eucaristica. Genesi del rito
e sviluppo dell interpretazione (E8B.
Bologna ‘2018: tr. francese e Inglese).
ENRICO MAZZA
LA CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione
SUB
EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA
®2003 Centro editoriale dehoniano
via Nosadella, 6 - 40123 Bologna
EDB (marchio depositato)
ISBN 88-10-43004-2
Stampa: Grafiche Dehoniane, Bologna 2003
PREMESSA
Chi fosse abituato a una liturgia come quella dell’ultima cena, nel cenacolo,
o a quella descritta nel libro VII delle Costituzioni apostoliche, farebbe fatica a
ritrovarsi in una liturgia come quella, ad esempio, del Pontificale di Guglielmo
Durando. Effettivamente la liturgia eucaristica è differente a seconda dei vari se
coli e delle differenti Chiese. Bisogna dunque riconoscere che, se si vuole tratta
re della liturgia eucaristica, è necessario fare un’opera storica.
Lungo i secoli la liturgia eucaristica non ha mai camminato da sola: è
sempre stata accompagnata dalle interpretazioni che nelle varie epoche le sono
state date, al punto che, talvolta, la celebrazione è stata trasformata per corri
spondere meglio all’interpretazione. L’interpretazione, ossia la teologia sacra
mentaria, nasce dal rito, ma, trasformatasi nel tempo, si riflette sul rito e lo
riforma. Non avrei potuto trattare della liturgia eucaristica senza affrontare
contemporaneamente l’interpretazione che ne è stata data lungo i secoli. In
questa monografia dunque si troverà sia il dato liturgico, sia la sua interpreta
zione nella storia, ossia la teologia eucaristica.
Prima tratto dell’origine e dello sviluppo dell’eucaristia e, successivamente,
della teologia eucaristica a seconda dei vari autori, padri della Chiesa e medie
vali, che ho scelto come esponenti caratteristici delle maggiori tappe dello svi
luppo del pensiero sull’eucaristia nella storia. Quando si sceglie di presentare il
pensiero di un autore, si sceglie di escluderne un altro: è fatale. Mi rendo conto
che ho dovuto escludere autori che sono di primo piano.
Che cos’è dunque l’eucaristia? L’eucaristia è imitazione dell’ultima cena, e
questa è figura e annuncio della passione: si tratta di due dati costanti nelle pre
ghiere eucaristiche della Chiesa delle origini. Gli stessi dati hanno guidato la ri
flessione dei padri della Chiesa dei primi quattro secoli. In quest’epoca, dun
que, la teologia si è mossa all’unisono con la liturgia, conservando le stesse con
cezioni e le stesse categorie interpretative. Qui la concezione dell’eucaristia è
costantemente affermata come obbedienza al mandato di Cristo: «Fate questo
in memoria di me», e imitazione del rito del cenacolo. Allo stesso modo, tutti gli
elementi del rito saranno imitazione dei vari elementi presenti nella celebrazio
ne del cenacolo: il pane, il vino, la preghiera eucaristica, e il sacerdote stesso.
5
Antitypa1 è il vocabolo che troviamo nelle più arcaiche liturgie per designare il
pane e il vino della cena eucaristica. Per rendere ragione di questo dato e per
comprendere questa terminologia è necessario elaborare un’interpretazione ti
pologica della cena eucaristica, dato che il termine antitypos, e il suo correlativo
typos, hanno la loro origine nella tipologia che, nell’epoca delle origini cristiane
e nell’epoca patristica, è il principale sistema d’interpretazione delle Scritture.
Questa terminologia viene utilizzata in due ambiti diversi ma strettamente col
legati: nell’interpretazione delle Scritture e nella descrizione della liturgia.
L’uso di antitypa per designare il pane e il vino dell’eucaristia significa che
questi elementi hanno la loro corrispondenza nell’ultima cena che è concepita
come modello.2 Anche se la terminologia non è fissa ma fluttuante, l’ultima cena
è il tipo mentre l’eucaristia della Chiesa è 1 ’antitipo: Yantitipo corrisponde al tipo.
1 Ad esempio: «Ancora ti rendiamo grazie, Padre nostro, per il prezioso sangue di Gesù Cristo,
versato per noi, e per il prezioso corpo, di cui noi portiamo a compimento questi anticipi, avendoci or
dinato egli stesso di annunziare la sua morte. Per mezzo suo a te la gloria nei secoli. Amen» (Costitu
zioni apostoliche, VII,25,4; M. Metzger (ed.], Les Constitutions apostoliques. Livres VII et Vili
[Sources chrétiennes 336], Cerf, Paris 1987, III, 52). Nelle primitive testimonianze delle liturgie in lin
gua latina, troviamo il termine figura che svolge lo stesso ruolo di antitypos.
2 Nel cristianesimo la tipologia biblica viene applicata alla lettura dell’Antico Testamento per
garantire la sua unità con il Nuovo. In tal modo si ottiene un’unica economia di salvezza e un unico
Salvatore, il Cristo. Questo metodo è usato anche da Paolo in ICor 10,1-4. Per riuscire a creare questa
unità bisogna far emergere dal Nuovo Testamento o, nel caso, dalla liturgia, delle analogie o corri
spondenze con i fatti del Nuovo Testamento. Ciò comporta l’uso del metodo allegorico, in modo che
il testo dell’Antico Testamento parli veramente dei fatti del Nuovo, come afferma Gesù in Le 24,44:
«Poi disse “Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”». Solo perché compimento
della promessa antica gli eventi neotestamentari possono essere qualificati come eventi salvifici au
tenticati da Dio: infatti solo così corrispondono agli eventi anticotestamentari che, in Israele, sono la
salvezza in quanto tale. In questa concezione i fatti e gli accadimenti dell’Antico Testamento acqui
stano una funzione particolare, quella di paradigma della salvezza. Per avere funzione paradigmatica
tali eventi debbono avere subito un processo di «standardizzazione» che ha posto in evidenza i carat-
tri nei quali si è espressa l’opera di Dio intesa come salvezza. In epoche successive saranno salvifici
quei fatti che avranno una certa corrispondenza con i paradigmi degli eventi anticotestamentari. Que
sta è l’interpretazione «figurale» o «tipologica» delle Scritture, che è stata applicata anche ai riti litur
gici dando origine a una vera e propria «teoria» (nel senso patristico del termine) e «interpretazione»
della liturgia in senso «salvifico». C’è una certa differenza tra la semplice tipologia biblica e la tipolo
gia applicata alla liturgia; nel caso della liturgia infatti viene accentuato il carattere paradigmatico
delle figure bibliche fino ad attribuire loro la funzione di modello della celebrazione liturgica. Per
modello si intendono due cose: 1) il rito, tanto per il suo contenuto quanto per il suo aspetto esteriore,
ossia per la successione delle varie unità rituali; anche per la successione delle varie unità rituali il rito
dell’ultima cena è modello o tipo dell’eucaristia della Chiesa; 2) il carattere salvifico, che, descritto in
modo autentico nelle Scritture, è riconosciuto anche all’azione liturgica della Chiesa (Melchisedech
e la sua offerta di pane e vino sono riconosciuti come «tipo» di Cristo e dell’eucaristia cristiana; non
solo Melchisedech, ma anche il dono della manna nel deserto, e anche, tra gli altri casi, Davide con i
pani di proposizione). Nei testi evangelici hanno valore «tipico», e quindi di «modello» dell’eucari
stia, sia i vari racconti della moltiplicazione dei pani, sia i pasti con il Risorto; in questi casi si tratta
non tanto di un «modello» rituale (anche se alcuni elementi rituali ci sono effettivamente), quanto di
fatti paradigmatici in ordine alla salvezza; il nesso con l’eucaristia sta nel fatto che questi episodi, le
gati alla salvezza, sono connessi con il rito del pasto. Sulla tipologia biblica la bibliografia è molto am
pia, mi limito a segnalare alcuni studi classici come: J. Daniélou, Sacramentum futuri. Etudes sur les
origines de la typologie biblique (Etudes de théologie historique), Beauchesne, Paris 1950; Id., Plato-
nisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégroire de Nysse, Paris 1954; H.
De Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture, Aubier, Paris 1959; J. Daniélou, «Fi
gure et événement chez Méliton de Sardes», in Neotestamentica et patristica. Festgabe O. Cullmann,
6
La nozione di imitazione (tipo-antitipo) svilupperà quell’interpretazione dell’eu
caristia che, facendo uso di categorie filosofiche, descriverà il valore ontologico
del sacramento del corpo e sangue di Cristo.
L’eucaristia, come figura del corpo e del sangue di Cristo e come figura della
sua morte, è al centro della trattazione patristica e viene passata alle epoche suc
cessive che mal comprenderanno il vocabolario della sacramentalità, che era sta
to formulato in modo figurale e tipologico. Alla concezione figurale, ormai de
classata ad allegoresi, succede una nuova concezione basata sulla nozione di pre
senza. Elaborata con ampiezza nel medioevo, questa nozione è divenuta il modo
per antonomasia di formulare la teologia dell’eucaristia. Il tema della presenza
entra nel magistero della Chiesa e ha il suo apice nel concilio di Trento.
Con il concilio Vaticano II è stata avviata una profonda riforma liturgica che ha
attinto alle fonti di epoca patristica per preparare nuove preghiere eucaristiche da
inserire nel messale. Contemporaneamente, per interpretare il «sacrificio» eucari
stico è stata usata la categoria della repraesentatio che, però, pare essere solo una
variante della nozione di praesentia, applicata agli eventi della redenzione.
La domanda finale, che mi pongo nell’ultimo capitolo del presente volume, è
se il cristianesimo di oggi può comprendere l’eucaristia in base alle categorie fi
gurali e tipologiche delle origini cristiane, conservando loro la stessa accezione di
allora: typos-antitypos, figura corporis, similitudo sanguinis, figura mortis eius, sa
cramentum ecc.
La risposta è positiva: nonostante il diverso ambiente culturale, e la differente
cultura filosofica di riferimento, la ricerca biblica è arrivata a interpretare l’ulti
ma cena come figura e annuncio della passione, dando a questa concezione un va
lore ontologico non diverso da quello dell’epoca patristica, anche se viene espres
so in modo molto diverso senza ricorrere alle categorie dell’epoca patristica.
Avevo già esposto questa interpretazione biblica nel mio volume Le odierne pre
ghiere eucaristiche3 e quindi il lettore ritroverà qui alcune di quelle pagine. Molte
Leiden 1962,282-292; L.F. Pizzolato, La dottrina esegetica di sant’Ambrogio (Studia patristica me-
diolanensia 9), Vita e pensiero, Milano 1978; J. Pépin, La tradition de l’allégorie. De Philon d'Alexan-
drie à Dante. Etudes historiques, Ed. Etudes augustiniennes, Paris 1987. Sulla tipologia applicata alla
liturgia cf. C. Jacob, Arkandisziplin, Allegorese, Mystagogie: ein neuer Zugang zur Theologie des
Ambrosius von Mailand (Athenaums-Monographies. Theologie Theophaneia 32), Hain, Frankfurt
1990; Id., «Zur krise der Mystagogie in der Alten Kirche», in Theologie und Philosophie 66(1991),
75-89; E. M azza, «Les raisons et la méthode des catéchèses mystagogiques de la fin du quatrième
siècle», in A.-M. Utiacca - A. Pistoia (edd.), La prédication liturgique et les commentaires de la li
turgie (Bibliotheca Ephemerides liturgicae. Subsidia, 65), CLV Edizioni liturgiche, Roma 1992,154-
176; R.N. Fragomeni, «Wounded in Extraordinary Dephts: Towards a Contemporary Mystagogy»,
in M. Downey - R.N. Fragomeni (edd.), A Promise of Presence. Studies in Honour of David N.
Power, The Pastoral Press, Washington D.C. 1992,115-137; P.-M. Gy, «La mystagogie dans la liturgie
ancienne et dans la pensée liturgique d’aujourd’hui», in A.M. Triacca - A. Pistoia (edd.), Mysta
gogie: pensée liturgique d’aujourd’hui et liturgie ancienne (Bibliotheca Ephemerides liturgicae. Subsi
dia 70), CLV Edizioni liturgiche, Roma 1993,137-143; Ph. De Roten, «Le vocabulaire mystagogique
de Saint Jean Chrysostome», ivi, 115-135; E. M azza, «Saint Augustin et la mystagogie», ivi, 201-226.
Tutto questo volume ha grande rilievo per la mistagogia; D. Sartore, «Mistagogia ieri e oggi: alcune
pubblicazioni recenti», in Ecclesia orans 11(1994), 181-199.
3 EDB, Bologna 1984,21991.
7
cose sulla storia dell’anafora sono già state dette in altre mie pubblicazioni, tut
tavia qui non si tratta di pure ripetizioni perché ho collegato assieme ricerche che
ho pubblicato in epoche e in riviste diverse, facendo quei raccordi che al lettore
possono essere sfuggiti, perché erano soltanto impliciti. Inoltre ho cercato di pri
vilegiare la sintesi rispetto all’analisi, rendendo l’esposizione più accessibile an
che per quel lettore che non fa di professione lo storico dell’anafora eucaristica.
E.M.
Milano, 26 settembre 1995
8
PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE
/
Questa seconda edizione è stata aumentata di tre capitoli (ottavo, quattordi
cesimo e quindicesimo) e della relativa bibliografia; il resto dell’opera è rimasto
immutato.
Il capitolo ottavo tratta in modo sintetico e riassuntivo dell’origine giudaica
della liturgia eucaristica, esaminando sia l’eucaristia della Didachè, sia la pre
ghiera eucaristica della Chiesa alessandrina, sia la specificità della liturgia siro-
orientale. Viene dato particolare rilievo al rapporto tra la Birkat ha-Mazon e lo
sviluppo dell’anafora, per mettere in evidenza il ruolo che ha effettivamente
svolto questa preghiera giudaica, senza, per questo, dover affermare un rapporto
privilegiato tra la Birkat ha-Mazon e l’anafora cristiana, come ho dovuto recen
temente precisare per evitare che la mia interpretazione subisse letture distorte.1
Il caso della liturgia siro-orientale è dotato di una particolare attualità, dato
il recente accordo tra la Santa Sede e la Chiesa assira d’Oriente, sulla possibilità
che i caldei, partecipando alla liturgia assira, possano partecipare con la comu
nione (e reciprocamente). L’esame della liturgia della Chiesa assira d’Oriente
mette in evidenza gli elementi comuni tra questa arcaica eucaristia e la liturgia
occidentale dei primi secoli.
Il quattordicesimo capitolo tratta dell’istituzione dell’eucaristia, così
com’era concepita nel medioevo, ponendo il problema se ci sia o no continuità
tra le categorie culturali e teologiche dell’epoca dei padri della Chiesa e dell’epo
ca medievale. È una questione di rilievo; infatti, i padri avevano come punto di
riferimento la frase di Cristo: «Fate questo in memoria di me» e interpretavano
l’istituzione dell’eucaristia come trasmissione dei misteri; nel medioevo, invece,
le parole di riferimento sono: «Questo è il mio corpo» e, rispettivamente, «Que
sto è il calice del mio sangue», e l’istituzione dell’eucaristia è vista come creazione
del potere consacratorio di queste parole.
Il quindicesimo capitolo continua a trattare del medioevo, ma esamina un al
tro problema: la funzione dell’eucaristia, ossia la sua virtus. Anche qui c’è la que
stione della continuità o discontinuità con l’epoca patristica. In effetti si è passati
1 E. Mazza, «A propos de la dérivation de l’eucharistie chrétienne de la “Birkat ha-mazon”
juive», in Questions Liturgiques 83(2002), 233-239.
9
dall’idea di «sacramento dell’unità del corpo di Cristo che è la Chiesa», all’idea
di «sacramento dell’unione dell’anima con Cristo». In una parola, si è passati dal
la funzione ecclesiale - e comunitaria - della celebrazione eucaristica, alla funzio
ne individuale - in una sorta di intimismo religioso - della comunione intesa
come incontro con Gesù. Per spiegare queste trasformazioni ho fatto ricorso al
cambiamento delle categorie culturali del medioevo e alla differenza delle cita
zioni bibliche utilizzate dagli autori medievali.
Questi due capitoli riassumono una monografia che ho pubblicato nel 2001,
dal titolo: Continuità e discontinuità. Concezioni medievali dell’eucaristia a con
fronto con la tradizione dei Padri e della liturgia? È Pascasio Radberto che dà ini
zio alla «nuova» concezione dell’eucaristia attraverso una errata lettura di una ci
tazione di Ambrogio, cosa che gli sarà rimproverata dal suo contemporaneo Ra
tramno, anch’egli monaco di Corbie. Pascasio, tuttavia, non usa ancora il concet
to di «presenza» per parlare del realismo sacramentale: egli si serve di questo ter
mine solo per i miracoli eucaristici, ossia per descrivere la visibilità di Cristo
heU’eucaristia a opera di un miracolo che fa vedere, al posto dell’ostia, il bambino
Gesù così com’era tra le braccia della Madre. Anche negli autori successivi, quan
do il termine «presenza» ha già assunto valore sacramentale, tale termine conser
va un preciso legame con la presenza di Cristo nella sua vita storica in Palestina.
Non ho fatto invece alcuna aggiunta per quanto riguarda l’epoca contempo
ranea. Mi era stato chiesto, infatti, di dedicare spazio al dibattito contemporaneo
sulla cosiddetta «presenza eucaristica», trattando delle questioni recenti come la
«transfinalizzazione» e la «transignificazione». Se questa monografia fosse stata
un volume di teologia dell’eucaristia, avrei dovuto farlo, e così pure se fosse stata
un volume di storia dell’eucaristia. In questo caso avrei dovuto trattare anche dei
grandi autori orientali come, ad esempio, Giovanni Damasceno e Nicola Cabasi-
las. Questa mia opera però non è né l’una né l’altra cosa. In altri termini, qui vo
glio confrontare la celebrazione dell’eucaristia, sia nelle sue origini che nei suoi
sviluppi patristici, con le interpretazioni successive, che hanno portato alle deci
sioni del concilio Vaticano II di iniziare una grande riforma liturgica.
I tentativi contemporanei di reinterpretare l’eucaristia con le categorie della
«transfinalizzazione» e della «transignificazione» sono fuori da questo quadro.
Infatti, io intendo porre come punto di riferimento l’epoca dei padri della Chiesa,
non le categorie medievali, dato che è nell’epoca patristica che sono state fissate
le grandi anafore delle Chiese sia dell’Oriente sia dell’Occidente e che hanno fat
to da modello alle nuove preghiere eucaristiche del messale di Paolo VI. Il mio
scopo è di illustrare il quadro in cui è nata e si è sviluppata la liturgia eucaristica
e di far vedere quali sono stati gli sviluppi che ci hanno portato lontano da allora
e che hanno generato il bisogno di una riforma nella Chiesa di Roma. In una pa
rola, questa vorrebbe essere una trattazione sulla «eucaristia nella storia».
E.M.
Milano, 26 gennaio 2003
2 «Bibliotheca Ephemerides liturgicae. Subsidia 113», CLV Edizioni liturgiche, Roma.
10