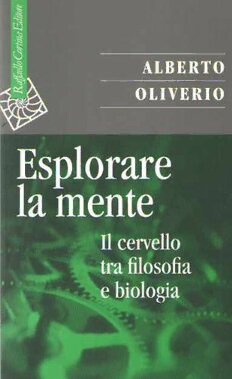Table Of ContentAlberto Oliverio
Esplorare la mente
Il cervello tra filosofia e biologia
;
·~ ~...·...~. ~~ ":" .·...:..-...-...:...:. -~--.n... ..... . q.... ... ..-,..a. 3iblioteche C
C:_l ,_:or..une di Roma
B:BwìOTECA MARCONI
. . . 9~-)41~{
!i - .r;·;er:tano n ..................... ----·-
"r:... . .................... _
~
RajàelloCortinaEditore
www.raffaellocortina.it
Copertina
FG Confalonieri CReE
Redazione
Maria Colò
Fotocomposizione
Studio g&p -Lodi
ISBN 88-7078-575-0
© 1999 Raffaello Cortina Editore
Milano, via Rossini 4
Prima edi~ione: 1999
INDICE
Introduzione
1. Breve storia della biologia del comportamento 7
Alla ricerca delle sedi della psiche 7
Le sedi del linguaggio 11
Dalle associazioni mentali al funzionalismo 18
Il comportamentismo: una mente senza cervello 22
La biologia del comportamento e i rapporti tra struttura e funzione 29
Nella profondità del cervello 35
Le mappe della corteccia 39
Il cervello diviso: due menti o una sola? 43
2. Storia naturale della mente 51
Le scelte del paramecio 51
Piacere e dolore 53
L'evoluzione del cervello: quantità e qualità 56
I rapporti gerarchici tra strutture nervose e compor.tamento 62
Comportamenti rigidamente predeterminati 66
Gli istinti 70
Le strutture del linguaggio sono innate? 73
Dalla plasticità alla creatività 78
Il pensiero analogico 83
3. Il cervello e la realtà 89
Gli a priori della conoscenza 89
Plasticità nervosa, mutevolezza delle rappresentazioni 91
La selezione dell'informazione 97
Strategie per elaborare l'informazione 100
Trappole per la mente 104
La realtà e la sua rielaborazione 107
Neurobiologia della memoria 110
VII
INDICE
Memoria ed emozione 113
Mutevolezza della memoria 115
Forme della memoria 118
Sedi della memoria 121
I suggeritori della memoria 126
Memorie e inconscio 127
Esperienze inconsce 128
L'emozione e i suoi significati 130
4. Neuroscienze e filosofia della mente 135
Le posizioni "classiche" della filosofia della mente 136
Quali sono le caratteristiche essenziali della mente? 142
La teoria computazionale della mente 148
Eliminativismo e connessionismo 154
Psicologia del senso comune e intenzionalità: altre teorie 160
Alternative al meccanicismo mentale 168
Neuroscienze e teorie della mente 176
Neuroscienze e natura wriana 183
Glossario 193
Bibliografia 207
INTRODUZIONE
Tutto ciò che riguarda il cervello, il comportamento e le carat
teristiche della mente è oggi al centro di crescente attenzione sia
da parte degli scienziati sia da parte dei non specialisti che per
diversi motivi possiedono alcune nozioni su differenti aspetti dei
rapporti tra cervello e comportamento. Ad esempio, spesso sen
tiamo affermare che l'essere depressi o di buon umore può di
pendere dalle dinamiche delle molecole chimiche prodotte dalle
cellule nervose, che le droghe modificano il nostro comporta
mento agendo sui trasmettitori nervosi, che un trauma cranico
può comportare un vuoto di memoria, che intelligenza e memo
ria possono sgretolarsi in tarda età se il cervello va incontro a
malattie degenerative come il morbo di Alzheimer. Ognuno di
noi, insomma, ha conoscenze, più o meno sommarie, sia nel
campo delle neuroscienze, le discipline che studiano il cervello
attraverso diversi strumenti e punti di vista, sia in quello della
psicobiologia, la disciplina che cerca di interpretare alcuni aspet
ti della mente attraverso un'ottica biologica, sia, infine, in quello
della filosofia della mente che, attraverso i secoli, ha cercato di ri
spondere a diversi interrogativi che riguardano i rapporti tra la
mente, un tempo associata all'anima, e il cervello. Alcuni di que
sti classici interrogativi, oltre al rapporto mente-cervello, riguar
dano gli atteggiamenti umani, le credenze e i desideri, la coscien
za, la razionalità, le passioni, il rapporto tra natura e cultura, la
volontà, lo stesso libero arbitrio. Un tempo, però, i filosofi della
mente si ponevano domande che prescindevano dalle - poche -
conoscenze sul funzionamento del cervello, mentre oggi è ben
difficile non tenere in considerazione quanto ci rivela la biologia;
INTRODUZIONE
anche se alcuni filosofi ritengono che gli eventi mentali siano es
senzialmente dei vissuti in prima persona, su cui la scienza ha
ben poco da dire, è ben difficile ignorare alcuni fondamenti bio
logici del mentale. Ad esempio, non abbiamo dubbi sul fatto che
la mente di una persona che ha fatto uso di droghe pesanti sia al
terata, che la morte cerebrale coincida con l'assenza di coscienza
e delle funzioni mentali, che alcune funzioni mentali si verifichi
no a livello inconscio. Anche quando ci interroghiamo sul futu
ro, la dimensione biologica ha un impatto sull'etica, sulla filoso
fia della mente, sullo stesso concetto di "persona umana": spes
so, tanto per ricorrere a un argomento attuale, ci domandiamo
cosa avverrebbe se gli individui umani fossero clonati e, in parti
colare, se le loro menti potessero essere quasi identiche tra loro,
simili in modo inquietante ...
Questa trasformazione del nostro modo di guardare alla men
te umana, attraverso un'ottica biologica, è abbastanza recente:
sia pure con qualche approssimazione, potremmo affermare che
poco più di cinquant'anni fa la mente e il comportamento uma
no erano ancora appannaggio della filosofia e della psicologia,
mentre si riteneva che biologia e medicina si limitassero a fornire
risposte circoscritte alla patologia, ai casi di malattie e lesioni del
sistema nervoso. In realtà, l'interesse ai rapporti tra cervello e
comportamento risale a molti anni or sono; ad esempio, gli stu
diosi di anatomia comparata, i naturalisti e gli evoluzionisti si
erano posti domande sulle radici biologiche del comportamento
umano già alcuni secoli addietro; Charles Darwin aveva sostenu
to, sin dalla metà dell'Ottocento, che il cervello umano avesse al
le sue spalle una lunga storia naturale; i neurologi avevano indi
cato come le lesioni di alcune parti della corteccia cerebrale alte
rassero profondamente il linguaggio, la memoria, il comporta
mento. Tuttavia, malgrado queste conoscenze e teorie, il cervello
restava un continente inesplorato e ignoto ai più; soprattutto, co
me si è detto, era opinione comune che la scienza, in particolare
la medicina, potesse chiarire alcuni aspetti della patologia cere
brale ma non della fisiologia. Si ammetteva, ad esempio, che il
comportamento potesse disgregarsi a causa di un ictus o della si
filide ma non si riteneva che la scienza potesse esplorare le carat
teristiche della memoria, dell'emozione, del sogno e più in gene
rale della mente. Oggi, invece, la situazione è profondamente
INTRODUZIONE
cambiata, il modo in cui guardiamo alla mente è diverso in quan
to le neuroscienze, attraverso lo sviluppo di varie tecniche e stra
tegie, hanno consentito di inquadrare e conoscere numerosi
aspetti dei rapporti tra sistema nervoso e comportamento, sia dal
punto di vista fisiologico che patologico. Ovviamente, le trasfor
mazioni del modo in cui guardiamo ai rapporti tra mente e cer
vello, tra psiche e corpo, non rispecchiano soltanto conoscenze
scientifiche ma anche mutamenti sociali e culturali; in effetti, la
maggiore attenzione nei riguardi dei rapporti tra cervello e psi
che può anche essere interpretata sulla base dell'attuale tenden
za verso l'individualismo, della crescente attenzione verso il Sé,
di una trasformazione della mentalità che riguarda anche quegli
interrogativi sul come siamo fatti e sul come agiamo, che rientra
no nel campo di studio delle scienze della psiche e del cervello.
Un'ulteriore spinta verso una lettura in chiave biologica della
mente ha avuto origine da una laicizzazione della cultura e quin
di dal superamento di una concezione spiritualistica che, nel
passato, poteva far sì che il concetto di mente coincidesse con
quello di anima o di spirito: lo studio del comportamento in ter
mini naturalistici o "riduzionistici" implica invece che i fenome
ni mentali siano manifestazioni del corpo o dei processi cerebrali
e che quindi lo studio della mente umana non sia appannaggio
della metafisica, della filosofia o di una psicologia completamen
te scissa dalla biologia. Ciò non significa che la mente umana
possa essere svelata esclusivamente attraverso un'ottica naturali
stica ma che le neuroscienze rappresentino un importante livello
di lettura, anche se non esclusivo. Questa laicizzazione della cul
tura è meno evidente in Italia e ciò spiega, probabilmente, per
ché in altri paesi la filosofia della mente occupi un posto centrale
nella filosofia e le neuroscienze suscitino maggiore attenzione di
quanto non avviene nel nostro paese.
Per renderci conto di come si sia giunti a una nuova concezio
ne dei rapporti tra mente e cervello si possono seguire quattro
diversi percorsi.
1. In primo luogo ripercorrere la storia dei rapporti tra biolo
gia e comportamento a partire dall'Ottocento, quando i naturali
sti, i fisiologi e i neurologi cominciarono a condurre studi e ricer
che sistematiche sulla storia naturale del cervello, sulla sua fisiolo
gia e sugli effetti dei danni localizzati in alcune regioni cerebrali.
INTRODUZIONE
2. In secondo luogo seguire un'ottica di tipo evolutivo, cerca
re cioè di seguire le tracce di una "storia naturale" della mente
per soffermarsi sulle tappe fondamentali che hanno portato a un
cervello tipicamente umano.
3. Un terzo percorso può invece riguardare alcuni fondamen
tali raggiungimenti delle neuroscienze e della psicologia che han
no innovato il modo in cui guardiamo ai rapporti tra cervello e
rappresentazioni della realtà, basati sia su quel complesso intrec
cio di meccanismi predeterminati e processi plastici che caratte
rizzano ogni funzione mentale, in particolare la memoria che co
stituisce una specie di luogo simbolico della mente. Gli studi sul
la memoria indicano, ad esempio, che alcuni aspetti e modi del
ricordare sono legati a specifiche aree della corteccia, che la
mente rielabora in modo massiccio sia nuove esperienze che ri
cordi consolidati, che non tutte le esperienze si verificano a livel
lo cosciente e, infine, che attività cognitive ed emotive sono for
temente interdipendenti.
4. Ultima tappa del nostro percorso saranno le teorie della
mente, un classico capitolo della filosofia che riguarda i rapporti
tra 'mente e cervello. In che modo le nuove conoscenze neuro
scientifiche hanno modificato le teorie della mente? Ad esempio,
a quali trasformazioni è andata incontro l'epistemologia, il cui
nucleo centrale è l'origine e la legittimazione della conoscenza?
Tutta la conoscenza, come sostenevano gli ~mpiristi nasce dai
sensi e alle imp~~ni che sono a a base e contenuto e1 no
stiTStatrììieritali di cui abbiamo conoscenza diretta oppure si
fon a su asi natura istic e, su idee innate, come ritenevan I -
~ti?) Mente e cen;clio sono due entità distinte? Esiste un
linguaggio della mente? Le neuroscienze permettono di rispon
dere a queste domande in modo più esaustivo oppure le risposte
risiedono altrove, ad esempio nelle conoscenze che derivano dal
l'intelligenza artificiale e da quelle di calcolo o "computazionali"?
O infine, come sostengono la filosofia e la psicologia fenomeno
logica, le neuroscienze non ci consentono di dare risposta alcuna
in quanto le esperienze mentali sono un fenomeno precluso alla
conoscenza obiettiva? Considerata da questi diversi punti di vi
sta, la mente ci apparirà sotto un insolito aspetto in quanto è evi
dente che il cervello opera attraverso una serie di meccanigni
precostituiti, frutto della sua lunga storia, che fanno sì che stimo-
4