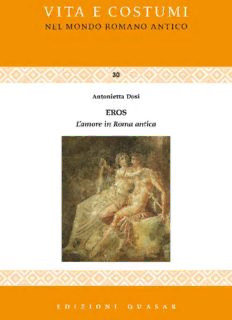Table Of Content30
EROS
L’amore in Roma antica
VITA E COSTUMI NEL MONDO ROMANO ANTICO
Collana edita con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio
Comitato scientifico:
Anna Mura
Cinzia Vismara
Giuseppe M. Della Fina
Filippo Coarelli
Gianfranco Gazzetti
Coordinamento editoriale: Giuseppina Pisani Sartorio
Si ringrazia il Museo della Civiltà Romana per la collaborazione
In copertina: Marte e Venere (o Enea e Didone). Affresco da Pompei, Casa del Citarista
(Ins. I, IV.5.25) (Napoli, Museo Archeologico Nazionale) (da Rosso Pompeiano
2007, p. 132).
© Roma 2008, Edizioni Quasar di Severino Tognon Srl
via Ajaccio 41 / 43, 00198 Roma - tel. 0685358444
email: [email protected]
e-ISBN 978-88-7140-619-0
VITA E COSTUMI NEL MONDO ROMANO ANTICO
30
Antonietta Dosi
EROS
L’amore in Roma antica
edizioni quasar
inTroduzione
Hic abitat felicitas (qui abita la felicità) si legge su un bassorilievo in travertino1. Tra
le prime parole e felicitas è grafita l’immagine di un fallo2 stilizzato e piatto, ma in forma
rigorosamente eretta, simbolo della potenza e della gioia dei sensi. e un liberto imperiale
in una iscrizione dedicata a Priapo, dio di tutte le cose, lo prega: “Concedimi di piacere ai
ragazzi e alle fanciulle con il mio fallo provocante”3.
“Il culto del fallo (in erezione) e dell’attività sessuale”, scrive Edoardo Bianchini4, “si perde
nella notte dei tempi legato allo stupore dell’originario ominide incapace di spiegarsi perché
l’organo sessuale virile, così indifeso in condizioni normali, potesse farsi improvvisamente
aggressivo e rigido al momento della sua erezione, pur non contenendo alcun elemento
osseo”.
In quanto è poi anche datore di sensazioni di piacere, i nostri antichi progenitori riservarono
al fallo un’incondizionata venerazione. E tanto di più scoprendo che grazie ad esso era
assicurata la generazione e la propagazione della specie. L’idolatria parossistica a lui
riservata ne fece pertanto un feticcio potentissimo in grado di stimolare i demoni della
fertilità e inibire quelli maligni della sterilità. L’organo maschile diventò così elemento
rituale e oggetto di culto apotropaico. Presente già nei riti dei clan primitivi e poi tribali e
inine in quelli dei villaggi e delle città, esso assunse con il passare del tempo la funzione di
catalizzatore di energie vitalistiche. Venerarne immagini e feticci, pronunziarne il nome in
formule magiche divenne “atto indispensabile per dominare”, continua sempre Bianchini,
“una realtà sfuggente e inafferrabile e sempre nella speranza… di poter ottenere un rinascere
perpetuo nel dipanarsi di un’eternità altrimenti impossibile e negata”5.
In altre parole era attraverso il fallo e i suoi riti che l’uomo affermava la vittoria della vita
sulla morte e poteva dire di essere immortale come gli dèi.
Le testimonianze più antiche sul culto fallico risalgono, come narra Erodoto6, al mondo
egizio7. Di lì sarebbe penetrato nel mondo greco grazie a Melampo8 che lo avrebbe
introdotto in Grecia insieme al culto di Dioniso. In suo onore sarebbero nate le ‘falloforie’
o processioni del fallo accompagnate dai canti fallici sia nel quadro di feste rustiche che
nella stessa Atene, durante le quali sembra che le donne portassero per le vie fantocci
antropomori dotati di un pene spropositato9.
Certo gli spiriti forgiati da un’educazione eccessivamente puritana potevano scandalizzarsi
ino a qualche decennio fa (oggi non più) leggendo di tali manifestazioni e ancora di più
di certi carmi giudicati così grossolani da indurre non pochi studiosi del secolo scorso a
edulcorarne la traduzione. Ma come è possibile analizzare comportamenti umani di civiltà
scomparse con criteri e valori che appartengono alla civiltà moderna? Ad ogni modo il fallo
7
non riveste mai né in Grecia né a Roma carattere di oscenità.
simboleggia invece la perennità della vita, il dominio della
potenza vitale sul caos e, come prima si diceva, la vittoria delle
forze di riproduzione su quelle della morte. Tale integrazione
dell’essere al ciclo naturale della riproduzione si sono
rinvenute anche in altre civiltà al di fuori del Mediterraneo
e ad esse anteriori dove si compivano e probabilmente
si compiono ancora cerimonie analoghe. In India, per
esempio, un culto del genere è legato alla ‘linga’ indou
che simboleggia Shiva, dio della riproduzione, e da cui
forse il culto del fallo addirittura proviene10.
Quanto a EROS (ig. 1), a cui ho dedicato il titolo di
questo libro, molto tempo prima di essere ‘Amore’ nel
senso che oggi gli attribuiamo, e ancor prima che
Platone, smarrito di fronte all’incontenibile forza
erotica, la sublimasse in ‘divina follia’, cioè nel
sentimento che ci eleva alla contemplazione
delle idee eterne del ‘bene’ e del ‘bello’11,
era semplicemente l’espressione della vis
generandi, in gran parte violenta, connessa alla
propagazione della specie. E dunque qualcosa che
non aveva nulla a che fare con l’erotismo e con le sue
implicazioni di natura psichica, estetica e morale.
Le rafigurazioni di ‘eros’ legate al culto di Afrodite, dea
dell’amore, in un giovane bellissimo o in un bambino
capriccioso e volubile armato di frecce con cui colpisce
il cuore degli uomini e degli dèi appartengono al mito
greco. L’erotismo - nel senso che ancor oggi gli attribuiamo
- appartiene invece a un momento posteriore e nasce con
il culto di Dioniso, dalla licenza dell’orgia dionisiaca che
accompagna il culto fallico. Attraverso l’atto sessuale che
tien dietro all’ebbrezza provocata dal vino, l’uomo si sente
creatore e in tutto simile agli dèi. i riti di dioniso, rinnovando il
caos mitico anteriore alla creazione, permettono la circolazione
dell’energia vitale che restaura il legame degli uomini con
l’universo (ig. 2). La trasgressione delle regole di decenza
nelle cerimonie dionisiache e le azioni che normalmente si
giudicano oscene, come anche la crudezza e la volgarità del
linguaggio provocatore (aischrologhia), hanno il potere magico di
puriicare e rendere fertili.
A Roma (visto che è di Roma che in questo libro si parla) i Saturnali, che si celebrano in
pieno inverno verso la ine di dicembre (quando le notti, sempre più lunghe, incutono la
paura che la luce non torni) e le feste di primavera che incoraggiano la ripresa del ciclo
riproduttivo, testimoniano la frenesia genetica che s’impadronisce degli uomini e altro non è
che il desiderio di sopravvivenza.
La licenza orgiastica è giustiicata dal suo carattere sacro in quanto riviviica i legami che
uniscono gli uomini agli dèi. Altra cosa però sarebbe considerarla un fatto normale nel
comportamento quotidiano. La sessualità si esercita anche nel tempo profano, ma secondo
regole che mirano a consolidare e insieme a rispettare i legami sociali. Queste regole
rappresentano ciò che si è convenuto di chiamare ‘morale’.
8
Nella pagina a ianco:
1 Eros vincitore, II sec. a.C.
Da Mahdia (Tunisi, Museo del
Bardo) (Yacoub 2005b, p. 652).
a lato:
2 Leggenda dell’invenzione
miracolosa della vigna. Parte
centrale del mosaico pavi mentale
da Oudna (Tunisi, Museo del
Bardo) (Yacoub 2005a, p. 17).
A questo punto diviene inevitabile chiedersi che cosa sia la morale. Nel suo senso più
ampio essa designa il sistema di valori che un gruppo di uomini si è dato per stabilire una
condotta comune di vita. È un codice sociale che comporta un certo numero di proibizioni
issate nell’interesse di tutti, la cui trasgressione può mettere in pericolo l’equilibrio su cui
il gruppo si fonda. Dal che deriva che non esiste una morale che sia un archetipo, perché
le regole morali di un gruppo rispettano solo la mentalità degli uomini che se le sono
imposte e sono l’emanazione di una cultura forgiata dalle circostanze che hanno presieduto
all’evoluzione di quella civiltà. Essa corrisponde a ciò che J.N. Robert deinisce ‘una morale
di comportamento’12. Questa è la morale che si è cercato di prendere in esame nello studio
dell’eros nella civiltà romana.
La parola ‘morale’, che nella sua accezione ilosoica traduce il termine greco (ethike),
appare in Roma solo verso la ine del I sec. a.C. in Cicerone. Il suo riferimento è
contenuto nel mos maiorum, cioè nella tradizione dei patres, dove mos designa appunto il
comportamento secondo il costume anteriore alla legge, a cui è servito da fondamento. il
mos ha regolato tutta l’organizzazione familiare e sociale romana ino alla prima formazione
nel 450 a.C. di un diritto scritto con le Leggi delle Xii Tavole. ed è sempre al mos che
i giureconsulti si riferiscono quando il diritto si rivela inadeguato a trattare certi casi
particolari. il mos maiorum è dunque il fondamento di tutte le qualità morali che deiniscono
l’ideale romano sintetizzato nella virtus, la quale ha condizionato lo sviluppo di Roma.
Di questa pratica morale l’esercizio della sessualità costituisce un aspetto rivelatore
essenziale, perché la maniera di concepire i rapporti intimi fra gli esseri consente di chiarire
i legami che la società crea fra gli uomini e di analizzare l’evoluzione dei costumi. La
sessualità dei romani (come del resto di altri popoli) non offrirebbe alcun interesse di studio
se fosse svincolata dal suo contenuto morale e si trascurassero gli avvenimenti interni e le
inluenze esterne che ne hanno determinato l’evoluzione.
9