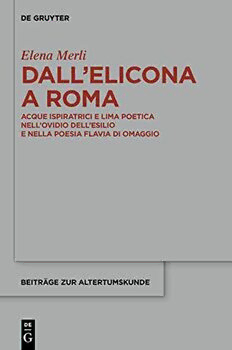Table Of ContentElena Merli
Dall’Elicona a Roma
Beiträge zur Altertumskunde
Herausgegeben von Michael Erler, Dorothee Gall,
Ludwig Koenen und Clemens Zintzen
Band 318
Elena Merli
Dall’Elicona a Roma
Acque ispiratrici e lima poetica nell’Ovidio dell’esilio
e nella poesia flavia di omaggio
Pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila.
ISBN 978-3-11-033683-2
e-ISBN 978-3-11-033757-0
ISSN 1616-0452
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Premessa
Questa indagine è incentrata sulla presenza di immagini e topoi ascrivibili al
callimachismo romano nella poesia di omaggio di età imperiale: a un esame
sistematicodisorsoispiratoreelimacheemendailtestosiaggiungel’analisidi
alcuneattestazionisignificativeedesemplaridiagrypnia,pudor,caratteretenuis;
inoltre,viene riservata attenzione alla festinatio, l’ostentata fretta nella compo-
sizione:undatotipicamente‘imperiale’chebastaagarantiredellevariazionidi
funzione e orientamento subite dai motivi tradizionali relativi al fare poesia.
Le letture proposte prendono le mosse da una osservazione: a partire
dall’OvidiodiTomi,epoinellesilvaediStazioenegliepigrammidiMarziale,le
varianti relative all’immaginario acquatico e alla lima poetica vengono spesso
utilizzatenonalfinediesprimeredirettamenteunaesigenteeraffinatasceltadi
stileodigenereletterariominore,comeaccadevaperlopiùinetàaugustea,ma
nel contesto dell’omaggio a un patrono appassionato di letteratura e in molti
casi egli stesso poeta. In questo fatto non dovrà leggersi un sintomo di
svuotamentoedecadenzamaunsegnaleditrasformazionechemeritadiessere
interpretato nel contesto di un nuovo assetto del sistema letterario e di
condizioni del fare poesia profondamente mutate.
L’analisisiconcentreràperciòsuattestazionidihaustuselimadisolitopoco
o superficialmente valutate, in quanto orientate alla comunicazione e all’enco-
miodidestinataricoltipiuttostocheaunaesplicitaedesclusivadichiarazionedi
poetica, e darà la preferenza a confronti con segmenti coevi, tratti dall’episto-
lario di Plinio il Giovane,dal dialogus tacitiano, dalla satira imperiale, anziché
stabilire un ‘cortocircuito esegetico’ fra testi flavi e modelli della piena età
augustea.Sitrattadiunasceltaediunaipotesiinterpretativaconsapevolmente
parziali, che presentano però il vantaggio di correre meno di altre il rischio di
proporre una lettura anacronistica soccombendo al fascino delle più note e
fortunate dichiarazioni di Callimaco, Properzio,Orazio.
La scommessa di questo libro è considerare immagini nobili e ricche di
storia alla stregua di fatti a un tempo di forma e di comunicazione, senza
tracciare una netta linea di separazione fra valori letterari e documentari: la
poesia di omaggio si situa in un contesto occasionale e di dialogo, ma sa
esprimerealtempostessoledelicatestrategiediself-fashioningdapartediautori
che, anche in quanto inseriti in una società alla moda nella quale tanti si
improvvisano poeti, salvaguardano il proprio ruolo e dichiarano con accorta
cautela la superiore qualità della propria produzione letteraria.
Hopotutosottoporreaverificamoltideirisultatiquiespostigrazieaunaseriedi
convegni e conferenze tenutisi a Milano (Statale e Cattolica), Torino,Venezia,
VI Premessa
L’Aquila. Ringrazio tutti coloro che mi hanno invitato, chi ha partecipato alle
discussioni,chihalettoversioniprecedentidellavoroodisueparti,offrendomi
sia preziosi suggerimenti che amicizia e incoraggiamento. In particolare:
Delphina Fabbrini, Massimo Gioseffi, Francesca Lechi, Lara Nicolini,Gianpiero
Rosati, Livio Sbardella.
Alcune delle proposte qui presentate sono state in parte anticipate in
L’illusionecallimachea.AcquaispiratriceestrategiadicomunicazioneinMarziale
8, 70, “Quaderni del dipartimento di filologia linguistica e tradizione classica
AugustoRostagni”,n.s.8,2009,43–63,eLalimaeiltestodaOvidioaMarziale:
poetica e comunicazione, “Cento Pagine” 4, 2010, 71–89, i cui materiali sono
confluiti rispettivamente nel III e nel IVcapitolo.
Il fons di ispirazione di questa indagine è Mario Citroni: a lui essa è perciò
dedicata.
L’Aquila/Pisa, luglio 2013
Indice
Introduzione 1
Walter Wimmel e i rischi del ‘pancallimachismo’ 1
L’età flavia: immagini tradizionali, nuove funzioni 8
Callimaco a Tomi. Fonti delle Muse e lima poetica nell’elegia ovidiana
dell’esilio 16
Haustus ispiratore: dialogo coi destinatari e crisi
dell’ingenium 24
Lima poetica, agrypnia e pubblico fra Roma e Tomi 41
Una variabile ‘imperiale’: la festinatio 57
Tempi moderni. Poeti, patroni e acque ispiratrici nella poesia di
omaggio dell’età flavia 63
Il sorso ispiratore nelle silvae: omaggio e
autorappresentazione 73
L’epigrammista al fonte: mitizzazione e realismo 96
L’omaggio per Nerva poeta. Elegia imperiale e poetica
dell’epigramma 116
Pudor e verecundia: una questione editoriale… con qualche im-
plicazione politica 122
Alla fonte del Permesso: elementi augustei e comunicazione
flavia 133
Il secondo epigramma per Nerva: retorica dell’inferiorità e generi
minori 141
Festinata cura. Nuove dinamiche per le forme brevi 154
Marziale e la lima del patrono: omaggio e autonomia 159
Marziale e la lima dell’autore: comunicazione e apologia 167
Le strategie di Stazio fra silvae e impegno epico 178
Bibliografia 192
Indice dei luoghi citati 207
Indice dei nomi, delle cose e delle parole notevoli 212
Introduzione
Walter Wimmel e i rischi del ‘pancallimachismo’
Nec fontelabraproluicaballino:ilnotoincipitdeicoliambidiPersioècaricodi
sarcasticodisprezzoperlapoesiachesiatteggiaa‘ispirata’inscenandoleacque
scaturitedalcolpodellozoccolodiPegasoeilgestodelpoetadidissetarsiodi
accostareaesselelabbra.Ilsatiricopresentailtoposcomeusurato,inadeguato
a veicolare un efficace contenuto poetologico. Questa condanna senza appello
ha goduto di larga influenza, fino a venire estesa alla complessiva presenza
dell’immaginarioacquaticonellapoesiaimperiale.Inparticolare,essaèripresa
autorevolmente da Walter Wimmel nella conclusione del suo Kallimachos in
Rom.¹
Il saggio, meritatamente fortunato, è dedicato alla presenza nella poesia
augustea,specialmentenelleoperediVirgilio (bucoliche egeorgiche),Properzio
e Orazio, di metafore metaletterarie che avevano trovato uso esemplare in
Callimaco, quali l’acqua e la strada, in quanto si aggregano in un delicato
sistema: la recusatio. Il prologo degli aitia, l’epigramma 28 Pfeiffer, il finale
dell’inno ad Apollo esprimono una scelta di poesia dotta ed esigente, nel nome
della“Musasottile”eperopposizioneadaltre,menoraffinate,possibilitàdella
letteratura. In tutti e tre i testi ha un ruolo l’immagine dell’acqua:² nel sogno
degli aitia, ambientato sull’Elicona, era quasi certamente presente una fonte
ispiratrice;³ l’epigramma esprime disdegno per la fontana alla quale tutti
attingono;soprattutto,nelfinaledell’innoadApollo,aPhthonos,chedichiaradi
ammiraresolochicantaalmenoquantoilmare,ildiorispondeconun’articolata
antitesifrailmare,ilfangosofiumeassiroelapiccolaepurastillaattintaauna
sorgentesacra.⁴Èquest’ultimoilsegmentoin cuiilmotivo acquaticotrova,nel
testodiCallimacogiuntofinoanoi,piùampiautilizzazione,inserendosisuuna
griglia oppositiva di natura sia quantitativa che stilistica.
Wimmel1960.
Il lavoro di riferimento sull’acqua ispiratrice rimane Kambylis 1965, dedicato allo scenario
dellaDichterweihedaEsiodoaProperzio.Ampioregestodiattestazionidellametaforaacqua-
tica, fra l’altro in Pindaro, in Empedocle e nella commedia antica, e condivisibili spunti di
discussionedellepropostediKambylisinAsper1997,109–20.
Perladelicataquestionecfr.Kambylis1965,spec.99,102,110–1,122,elanitidaesposizionein
Massimilla1996,233–7,doveconladebitacautelasiproponecheCallimacodescrivessel’ini-
ziazionesiadiEsiodosiasuapropriatramiteunhaustussull’Elicona;assaiprobabileritienela
presenzadiquestoelementonelproemiodegliaitiaancheLyne1995,33e36–7n.11.Amio
parere,eccessivosuquestopuntoloscetticismoespressodaAsper1997,131.
DavedereconilcommentodiWilliams1978.
2 Introduzione
A Roma, sono i poeti augustei a far proprie sia queste immagini che,
specialmente, lo schema secondo il quale esse si dispongono, conferendo loro
unorientamentonettamenteapologetico,disceltadistileedigenereletterario,
afrontedellerichiestedicimentarsiconprove‘grandi’edistampocelebrativo.
Le evidenti riprese della costellazione callimachea nel suo complesso e di
elementi provenienti da essa assumono,cioè, il fine non solodi dichiarareuna
originaleeraffinataricercaformalemaanche,esoprattutto,didareespressione
egiustificazioneallasceltadiungenere‘minore’,presentatocomeinadeguatoa
cantare temi bellici con accenti scopertamente encomiastici: scopo di questa
strategia è, in sostanza, “evitare l’epica grazie all’autorità di Callimaco”.⁵ Ne
abbiamo il primo caso certo nella sesta bucolica di Virgilio, vv. 3–12, cui
seguonoalcunefelicivariazionioraziane(ades.carm.I6esat.II1,10–5),maè
l’elegia romana, che per statuto si definisce in opposizione all’epica e
all’impegno attivo del civis, a produrne gli esempi più caratteristici e influenti:
se rimane aperta la questione del ruolo di Cornelio Gallo, si potranno
confrontare numerosi componimenti properziani, quali le elegie II 1;10; 34; III
1;3;9, e le riprese ovidiane a partire da amores I 1.
Il meccanismo funziona ma appare anche limitato e un poco ripetitivo, e
saràperciòdestinato,nellasuaforma‘pura’,aunrapidoesaurimento;delresto,
con l’avvento della pax augusta, è possibile, e addirittura opportuno, lodare il
princepstrattandooggettipoeticinonlegatiadarmaetristiabella(comemostra
acutamente Orazio, carm. IV 15). Allo stesso tempo, specialmente grazie
all’Eneide, ha perso significato l’opposizione fra stile limato e poesia che si
estende per molti libri: “nei capolavori augustei… è scomparsa l’opposizione
neoterica fra techne e temigrandi, in quanto la moderna tecnica poetica era in
grado di affrontare questi temi senza troppo sforzo”.⁶
Wimmel colloca perciò il culmine della stagione della recusatio latina nel
breve giro di anni dal 40 al 20 a.C., mentre, fin dal decennio successivo, gesti,
motivi e lessico più tipici e ricorrenti in quella modalità espressiva, pur
continuandoaperpetuarsigrazieallaloroefficaciaeallaesemplaritàdicuisono
portatori,sonosecondoilsuo parereesposti alrischio difarsiarmamentariodi
maniera, ‘marchio di garanzia’ letterario ormai lontano dall’esprimere sia un
Lyne1995,35n.9,nelcontestodiunnitidoquadrodellarecusatioaugustea(31–9).‘Forza
d’urto’ adeguata a scardinare la radicata tradizione interpretativa che prende le mosse dal
Kallimachos in Rom in Cameron 1995,454–83; innovativo Hunter 2006, 7–41, che amplia lo
spettro degli intertesti per le scene di recusatio e di iniziazione nella poesia augustea. Fra i
contributi più recenti su ‘Callimaco a Roma’ da vedere Barchiesi 2011 e Acosta-Hughes –
Stephens2012,204–69.
Brink1982,566.