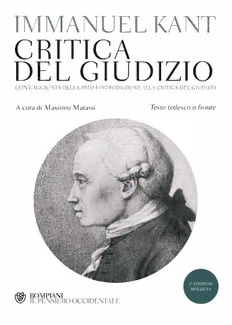Table Of ContentTMMANUKEALN T
CRTTTCA
DELG TUDTZTO
CO L'AGGTDUE"\!LTLPAAR TI\\lITAR ODUZAILOLC\lARE I TDIECGLAI UDIZIO
Testteod easfr coon te
A curdaiM assiMmaor assi
rfia"J BOMPTANT
� TLP ENSTOECRCOT DENTALE
BOMPIANI
Il PeNsIerO OccIdeNtAle
Direttore
GIOVANNI reAle
immanuel kant
critica del giudizio
con l’aggiunta della Prima introduzione
alla critica del giudizio
Testo tedesco a fronte
Introduzione, traduzione, note e apparati
di Massimo Marassi
2a edizione riveduta
BomPiani
il Pensiero occidentale
Direttore editoriale Bompiani
Elisabetta Sgarbi
Direttore letterario
Mario Andreose
Editor Bompiani
Eugenio Lio
© 2004/2014 Bompiani/RCS Libri S.p.A.
Realizzazione editoriale: Vincenzo Cicero – Rometta Marea (ME)
II edizione Il Pensiero Occidentale dicembre 2014
© 2017 Giunti Editore S.p.A. / Bompiani
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Piazza Virgilio 4 - 20123 Milano - Italia
ISBN 9788858776872
Prima edizione digitale Giunti Editore S.p.A.: ottobre 2017
S
ommario
Introduzione vii
Aggiunta alla seconda edizione della Critica del giudizio xvii
Cronologia della vita e delle opere di Kant xix
Nota editoriale xxv
Critica della forza di giudizio 1
Prima introduzione 697
Apparati 815
Indice generale 1019
I
NTRODUZIONE
“Wir haben Fähigkeiten, Vermögen und Kräfte”
“Noi abbiamo capacità, facoltà e forze”
(AA XXV, II, 1, p. 15).
Dopo aver fondato, con le prime due Critiche, la scienza e
la morale, Kant aveva intenzione di stabilire quale fosse il
«fondamento della critica del gusto». In una lettera del 25
giugno del 1787 a Christian Gottfried Schütz, Kant lamenta
la mancanza di tempo e comunica l’intenzione di dedicarsi
alla scrittura del Fondamento della critica del gusto, opera
peraltro già annunciata nel catalogo della Fiera di Pasqua del
1787 dall’editore Hartknoch; ripete a Ludwig Heinrich Ja-
kob, nel settembre del 1787, che si dedicherà all’elaborazione
della Critica del gustocon cui porrà fine alla sua impresa criti-
ca e che intende pubblicarla prima della Pasqua del 1788,
data di pubblicazione confermata a Carl Leonhard Reinhold
il 28 e 31 dicembre del 1787. La stessa dichiarazione si trova
replicata l’anno successivo in una lettera del 7 marzo 1788 a
Reinhold. Scrive Kant: «Questo semestre estivo sono gravato
di un lavoro straordinario: il Rettorato dell’Università (che,
insieme al Decanato della Facoltà di Filosofia, mi è toccato
per 2 volte consecutive in tre anni). Ciò nonostante, spero
proprio di consegnare la mia Critica del gusto per la Fiera di
San Michele e di poter così completare la mia impresa criti-
ca»1. Dopo un altro anno, e sempre a Reinhold, Kant annun-
cia però (12 maggio 1789) che la Critica del gusto costituisce
solo una parte della Critica del Giudizio.
Dunque l’intento iniziale di Kant consisteva nello scrivere
una Critica del gusto. È unicamente nel corso del lavoro che il
progetto assume dimensioni e propositi ben più consistenti,
tanto che la critica del gusto diventerà soltanto una parte,
corrispondente al giudizio estetico, della definitiva Kritik der
1I. Kant, Epistolario filosofico 1761-1800, a cura di O. Meo, il me -
lan golo, Genova 1990, p. 167.
VIII MASSIMOMARASSI
Urteilskraft, comprendente anche una parte dedicata all’ana-
lisi del giudizio teleologico.
La formazione del testo fu estremamente laboriosa: dalla
fine del 1787 alla metà del 1788 Kant scrisse l’analitica del
bello, la deduzione dei giudizi estetici puri, la dialettica della
forza estetica di giudizio (senza il § 58) e la metodologia del
gusto; dall’estate del 1788 all’inizio di gennaio del 1790 ela-
borò la Prima introduzione (in cui viene presentata la fonda-
mentale distinzione tra giudizi determinanti e riflettenti)2, il §
58 dedicato alla finalità nella natura e nell’arte, i §§ 23 e 30,
l’analitica del sublime, tutta la critica della forza teleologica
di giudizio; infine, tra gennaio e marzo del 1790, l’introduzio-
ne definitiva e la prefazione3.
Kant spedisce le parti concluse all’editore Lagarde in
varie fasi: il 21 gennaio, poi il 9 febbraio, il 9 marzo, e prefa-
zione e introduzione il 22 marzo. L’opera poté uscire in tempi
molto rapidi, e purtroppo con numerosi errori, alla fine di
aprile del 1790.
Il progetto complessivo di Kant non fu ritardato solo dai
suoi numerosi impegni accademici e dalla quantità di mate-
riale che andava via via raccogliendo. In una lettera del 26
maggio del 1789 a Marcus Herz Kant scriveva: «sono ancora
impegnato in un lavoro di ampio respiro per completare il
mio progetto (sia a licenziare l’ultima parte della Critica, ossia
quella del Giudizio, che apparirà fra breve [in Lieferung des
letzten Theils der Critik, nämlich dem der Urtheilskraft, wel-
cher bald herauskommen soll], sia ad elaborare un sistema di
metafisica, tanto della natura quanto dei costumi, conforme a
quelle istanze critiche)»4.
2La Prima introduzione, qui pubblicata alla fine della terza Critica, non
venne inclusa nel testo definitivo, ufficialmente per la sua eccessiva lun-
ghezza, e affidata però a Jakob Sigismund Beck che parzialmente la pub-
blicò nel 1794; sulle forme dei giudizi cfr. già KrVA 646-647; B 674-675.
3 Cfr. i lavori di G. Tonelli, La formazione del testo della Kritik der
Urteilskraft, «Revue internationale de philosophie», VIII (1954), pp. 423-
448; J.H. Zammito, The Genesis of Kant’s Critique of Judgment, The
University of Chicago Press, Chicago & London 1992; D. Dumouchel,
Genèse de la Troisième Critique: le rôle de l’esthétique dans l’achèvement du
système critique, in Kants Ästhetik-Kant’s Aesthetics-L’esthétique de Kant, a
cura di H. Parret, W. de Gruyter, Berlin-New York 1998, pp. 18-40.
4I. Kant, Epistolario filosofico 1761-1800, cit., p. 205.
INTRODUZIONE IX
Da notare in questo passaggio che Kant parla dell’opera in
cantiere non come della terza Critica, bensì come del l’«ultima
parte» della Critica, a sottolineare che le tre opere, nel suo
intento, non sono separabili, e che il suo «sistema del sapere»
comprende certamente delle parti, ma è un unico sistema.
In merito all’unità dell’ultima parte della Criticae all’unità
del sistema occorre considerare almeno alcuni elementi. In
quest’opera vengono in primo piano questioni relative al bel-
lo, al sublime e alla finalità, e si trovano raccolti insieme pro-
blemi riguardanti l’estetica e la teleologia. Questi temi sono
presenti diffusamente anche in precedenti opere di Kant,
basta pensare, almeno, alla Storia generale della natura e teo-
ria del cielo del 1755, o alle Osservazioni sul sentimento del
bello e del sublime del 1764, sebbene sia solo nel 1790 che i
temi indicati vengono ricondotti al rigore del metodo critico.
Per quanto riguarda invece l’unità del sistema, il problema
è un po’ diverso e più complicato: nel piano iniziale del pro-
getto critico quest’ultima parte non era prevista, anzi Kant era
ben convinto che le Critiche dovessero essere due, perché
basate sulla distinzione tra ragione teoretica e ragione pratica,
ma concepite come risposta coerente alla stessa do manda,
quella con cui si chiedeva come mai fosse possibile che le due
forme della medesima ragione, quale si presenta nella scienza
e nella morale, costituiscano una «sola» ragione. Rispetto al
progetto critico riguardante un’unica ragione nelle sue due
forme, l’ultima parte della Critica non soltanto è estranea al
piano iniziale, ma quella stessa Critica del gusto, di cui Kant
parlava nelle lettere citate, era indicata come un ambito circo-
scritto e meramente applicativo delle acquisizioni precedente-
mente ottenute. Nulla dunque lasciava presagire che addirit-
tura l’intero sistema delle facoltà stesse per venire sottoposto a
critica, condotto innanzi al tribunale della ragione, perché il
suo autore, molto tardi, a cose fatte, era giunto a individuare
una lacuna nel suo sistema del sapere e molto faticosamente
era poi riuscito a rinvenire la soluzione al problema posto: so -
no solo due gli ambiti della filosofia (teoretica e pratica) ma
ora la Criticasi articola in una tricotomia, in cui c’è sempre una
condizione, un condizionato e il concetto della loro unione5.
5Cfr. Introduzione, § IX. Il sistema delle facoltà sottoposto a critica
ricorda inevitabilmente il problema del consenso, della comunicazione,
X MASSIMOMARASSI
Il fatto perciò che in quest’opera la ragione si occupi fi -
nalmente di se stessa portava Scaravelli a dire, e senza mezzi
termini – benché sia trascorso un po’ di tempo conviene sem-
pre ricordarlo –, che «la Critica del Giudizio va, così, dall’e-
stremo della sua perfetta inutilità all’estremo dell’unica opera
veramente critica: ché mentre le prime due si occupano della
natura e della volontà – e sono “eteronome”, – in quest’ulti-
ma, finalmente, e in questa sola, “la ragione non si occupa
d’altro che di se stessa”, e raggiunge così il più alto fastigio
cui possa arrivare»6.
Lo schema con cui termina l’introduzione all’opera7 è
dun que il segno che l’ultima parte della Critica individua
finalmente quale fosse l’ambito (il sentimento del piacere e
dispiacere), la facoltà (la forza di giudizio), il principio a prio-
ri (la finalità), e l’ambito di applicazione (l’arte), che poteva-
no mantenere in unità conoscenza e desiderio, intelletto e
ragione, legalità e fine definitivo, natura e libertà. È dunque
molto tardi, presumibilmente durante l’estate del 1788, cioè
dopo la pubblicazione delle prime due Critiche, che sorge l’e-
sigenza d’individuare, come sarà detto nel § II dell’Introdu -
zio ne, il fondamento dell’unità tra il soprasensibile che fonda
la natura e il soprasensibile contenuto a livello pratico nella
libertà. La terza parte della Critica esamina perciò il «fonda-
mento dell’unità» dei «fondamenti» – il gioco di parole è ine-
vitabile perché tale «fondamento», dirà Kant, è un «libero
gioco» – delle due opere precedenti, e quindi pur non aven-
do un dominio proprio rende possibile «il passaggio dal mo-
do di pensare secondo i principi della natura al modo di pen-
sare secondo i principi della libertà», assicura il «passaggio»
dall’interesse speculativo dell’intelletto all’interesse pratico
della ragione e la subordinazione del primo al secondo.
Ma il «passaggio» è possibile, e giunge così a compimento
il sistema critico, non soltanto perché Kant completa con il
bello, il sublime, il fine ravvisato nella natura e nell’arte, ciò
della funzione politica del giudizio o, come amava dire Eric Weil, il
complesso quadro teorico della Critique de la Judiciaire; cfr. Problèmes
kantiens, Vrin, Paris 19902, già p. 8.
6 L. Scaravelli, Scritti kantiani, La Nuova Italia, Firenze 1968, p.
344.
7Cfr. p. B LVIII.