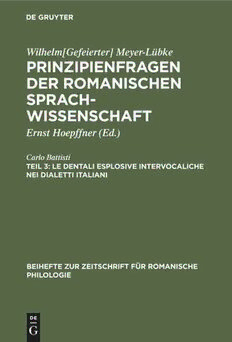Table Of ContentBEIHEFTE
ZUR
ZEITSCHRIFT
FÜR
ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON PROF. DR. GUSTAV GRÖBER t
FORTGEFÜHRT UND HERAUSGEGEBEN
VON
DR. ERNST HOEPFFNER
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT JENA
HEFT XXVIII A
PRINZIPIENFRAGEN DER ROMANISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT.
MEYER-LÜBKE GEWIDMET. TEII. III
HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
I9I2
PRINZIPIENFRAGEN
DER
ROMANISCHEN
SPRACHWISSENSCHAFT
WILHELM MEYER-LÜBKE
ZUR FEIER DER VOLLENDUNG SEINES 50. LEHRSEM ESTERS
UND SEINES 50. LEBENSJAHRES
GEWIDMET
TEIL III
CARLO BATTISTI
LE DENTALI ESPLOSIVE INTERVOCALICHE
NEI DIALETTI ITALIANI
HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1912
Piano della ricerca.
pag-
Condizioni generali del preromanzo 3—60
I.
§§ I—6. Critica dei grammatici latini: 1. I tre ragguagli
principali sulla pronunzia delle esplosive dentali. 2. Le
conclusioni di E. Seelmann. 3. Diversità nella pronunzia
delle tenui e delle medie omorganiche. 4. Articolazione
apicale delle, dentali forti, dorsale delle leni. 5. Attendi-
bilità delle fonti. 6. L'osservazione fonetica in Xerenziano
(pag. 3—la).
§§ 7—9• Cosa c' insegna lo sviluppo storico di t e d nel
latino rispetto all' articolazione delle dentali : 7. Condizioni
paleoitaliche e preletterarie. 8. La media. 9. La tenue
(13—17).
§§ IO—11. Mancanza di lenizione nel materiale epigrafico :
I. Il materiale latino. 2. Il materiale barbarico (17—23).
II.
§§ la—17. I prestiti latini: 12, 13. nel celtico, 14. nell'
anglosassone, 15, 16. nei dialetti germanici, 17. nell'
albanese.
§§ 18—20. Il materiale germanico: 18. nella penisola
iberica; 19. in Francia; 20. nell'Italia settentrionale.
§ 31. I primi esempi di lenizione romanza della tenue
dentale (33—49).
III.
§§33—25. Il motivo fonetico fisiologico della lenizione:
23. Lenizione ed assimilazione. 33. Lenizione e divisione
sillabica. 24. Scadimento dell' energia d' articolazione
a) rispetto all' elevazione linguale, /?) rispetto alla posizione
delle corde vocali. 35. Il passaggio della sorda alla sonora
(49-54)-
§§ 26—30. Relazione fra la lenizione appenninica e la
galloromanza. 26. Punti di contatto fra la lenizione
galloromanza e la gallica. 37—28. Parallelismi casuali:
27. Lenizione di s. 28. Lenizione dopo liquida e nasale.
29. Ripetizione del processo di lenizione in epoche diverse
nel romanzo. 30. Rielaborazioni spontanee di lenizione
paleoitalica nei dialetti italiani centrali e meridionali ($4
—60).
Le dentali esplosive intervocali nei dialetti italiani.
IloqÙ AXt£ávó(iov xov IlXaxw-
vtxov rè fitj noXXáxtt;, ftr¡Sh
Z<t>pls áváyxr¡g Xèyeiv npóg xtva,
f¡ iv èmaxoXy ygà<f>tiv oxi àaxo-
Xóg elfii • ftqóh Sia
TOIOVTOV
zgónov ovvtxwi nagaittlDai xh
xaxà ri; 7tgòg xovq avftfiiovvxag
X¿oeig xa&rjxovza, itQo(iaX).ó-
/isvov xà neQieaxùixa npay/taxa.
M. Aur. I, 13.
Nel presentare al Maestro queste pagine, umile segno di devozione e
riconoscenza, non so reprimere un certo senso di scoramento. La ricerca sullo
sviluppo delle dentali interv., che, secondo la mia intenzione, doveva estendersi
a tutta la Romania, è qui ridotta a un torso non corri>pondente più al titolo
della raccolta. Lo svolgimento del tema nel campo dei dialetti italiani ha
assunto proporzioni tali da decidermi, anche quando avessi avuto molto più
tempo del pochissimo di cui posso disporre, a non elaborare il materiale già
raccolto su quasi tutto il territorio romanzo e restringermi a confiDi più modesti.
Ho preferito studiare le vicende delle due consonanti sul suolo italiano, perchè
la ricerca si presentava qui molto più interessante che altrove, sia per la
posizione centrale della penisola rispetto al romanzo orientale ed occidentale,
sia perchi i dialetti italiani relativamente e regionalmente vegeti mostrano
tracce importanti di vecchi filoni idiomatici coperti stranamente da sovrapposi-
zioni ed incrocci degni d' uno studio profondo. Lo confesso: è stata una
presunzione giovanile la mia: il quesito è molto più difficile di quanto sembri
a prima vista. Le molte domande che si collegano strettamente allo sviluppo
delle dentali e attendono ancora una risposta, m'impediscono non di raro di
giunger a delle conclusioni storiche sicure. L' inegualità del materiale d' osser-
vazione , la mancanza d' indicazioni fonetiche nel maggior numero dei lessici
dialettali, le difficolti dello spoglio sistematico dei nostri documenti latini
medievali troppo poco studiati, eppure miniere preziosissime per il romanista,
la deficenza di studi toponomastici, 1' irraggiungibilità di parecchi testi dialettali,
specialmente deplorevole quando si tratti di parlari per i quali non abbiamo
raccolte lessicali, si rispecchiano troppo chiaramente in questo studio.
Originariamente questa ricerca doveva essere un tentativo di geografia
fonetica, in quanto dallo studio sistematico d' un numero sufficenti d* esempi
Bcihcft zur Zciuchr. f. rom. Phil. XXV11I. (Festschrlft.) I
2
è lecita ricoitniire e delimitare territorialmente quei dirizzoni linguistici, secondo
i quali noi formuliamo le „leggi fonetiche". Ma ormai il materiale stesso mi
trascinò a tentare delle ricostruzioni storiche che, allo stadio attuale della
dialettologia italiana, potrebbero sembrar premature. Se ogni vocabolo ha la
sua storia, sia che esso, come in pochissimi casi, abbia sempre fatto parte del
lessico volgare, sia che esso, subentrato nella nozione popolare soltanto in
epoca seriore, non abbia potuto avere uno sviluppo conforme alle tendenze
dialettali del periodo antecedente, sia che esso sia scomparso per condizioni
speciali di coltura e di storia dalla parlata comune, fossilizzandosi come tanti
nomi d' oggetti, d' usi e costumi dimenticati — anche una ricerca linguistico-
geografica deve avere una perspetliva storica per giudicare e sintetizzare con
criteri scientifici. E siccome 1' importazione d' un vocabolo dalla dizione d' una
casta più elevata o da altro centro linguistico, le cui tendenze dialettali non
combinali con quelle d1 uu detcrminato luogo, implica un' evolucione non con-
forme a quella d' un vocabolo svoltosi autoctonamente, siccome 1' influsso
flessionale o analogico, e con lui altri fattori che qui non ¿ necessario ricordare
possono aver alterato o alterare in grado diverso lo sviluppo d' un vocabolo,
il confronto reciproco degli esempi non solo in relazione al nostro fonema ma
pure allo sviluppo degli altri suoni s' impone e porta talvolta più in là dei
limiti modesti che m' era prefisso. Se la lenizione non ¿ che una delle mani-
festazioni d' una tendenza ben più generale che regola tutto il sistema del con-
sonantismo romanzo, e, cambiando le originarie condizioni d' energia, produce
variazioni più o meno profonde nel vecchio materiale, 1' evoluzione delle esplo-
sive dentali, come semplice episodio del processo di lenizione, non è che una
delle correnti del movimentato mare linguistico. Se essa vien fatta qui oggetto
d' uno studio speciale, il motivo risiede non soltanto nella certezza che per
comprendere il problema maggiore sia necessario rifar su più vasta base i
singoli lavori analitici parziali, ma pure nella persuasione che per le peculiarità
della pronuncia dentale il parallelismo con 1' evoluzione delle altre classi d' es-
plosive, determinato dall'unità della tendenza fonetica, in pratica si risolve in
pochi casi ad una vera eguaglianza dello sviluppo. Al parallelismo delle altre
esplosive sono perciò ricorso in questo saggio soltanto nei casi in cui il mio
materiale sulle dentali non bastava a chiarire le tendenze linguistiche.
Questi i criteri direttivi dello studio presente, che non può e non vuole
estere che un modesto lavoro di preparazione, il quale, specialmente quando
avremo anche noi il promesso atlante linguistico e una raccolta toponomastica
esatta ed esauriente, andrà corretto e in parte rifatto. E se il Maestro non
crederà vanamente sprecato il tempo dedicato a questa ricerca, se la critica
m' aiuterà a migliorare 1' esposizione e a colmare lacune che rimpiango, avrò
raggiunto il mio scopo. Giacché penso anch'io, come l'amico Pujcariu, che
un tentativo, se fatto seriamente, può sempre giovar a qualche cosa — almeno
ad indicare nuovi problemi e mostrare nuove vie.
3
Introduzione.
Condizioni generali del preromanzo.
I. I tre ragguagli pifi importanti dei grammatici latini sulla
pronuncia delle esplosive dentali furono già portati da E. Seelmann
Del noto studio Die Aussprache des Latein e più tardi da H. T. Karsten
nella Uitspraak van hit Latijn 116 e dal Lindsay, The Latin
Language 82. Non sarà però inutile il ricordarli al principio
d' una ricerca che deve prender le mosse dall' articolazione latina.
Terenziano Mauro (sec. Ili, d' origine africana) s' esprime (Keil,
Gramm. VI, 331,199*,*.):
at portio dentei quotiens suprema linguae
pulsaverit imos modiceque curua summos
tunc d sonitum perfidi explicatque uocem ;
t qua superis dentibus intima est origo,
summa satis est ad sonitum ferire lingua.
Molto simile è la descrizione attribuita a Mario Vittorino
(grammatico della metà del IV secolo, anche lui africano: Keil,
Gramm. VI, 33.24seg.): d autem et t, quibus, ut ita dixerim, uocis
uicinitas quaedam e?t, linguae sublatione ac positione distinguuntur. nam
cum summos atque imos conjunctim detiles suprema sui parte pulsaverit, d
litteram exprimit. quotiens autem sublimata partem, qua superis dentibus
est origo, contigerit, t sonore uocis explicabit. Poco di nuovo ci porta
Marziano Capella (III, 261): d appulsu linguae circa superiores
dentes innascitur — t appulsu linguae dentibusque impulsis extunditur
(cfr. 1' anonimo de litteris C. del supplemento del Keil, Gramm. 307,8),
assolutamente nulla Dositeo (Keil, Gramm. VII, 384) che non
stabilisce differenza alcuna fra 1' articolazione della media e della
tenue e definisce tutte due semplicemente secondo la vecchia
tradizione grammaticale come ¡itera consonans muta (yQCC/Jfia OV[i-
«peovov ct<p(Di'Ov). Senza speciale riguardo alle dentali Prisciano
s' esprime sul rapporto fra la media e la tenue nel modo seguente
(Insti!• Liber I, 26 = Keil, Gramm-. I, 20uscg): inter c sine aspiratione
et cum aspiratione est g, inter ! quoque e! th est d e! inter p et ph
sive f est b. Sunt igitur hac tres, hoc est b, d, g, mediae quae penitus
careni aspiratione nec eam plenam possident. Ora, per quanto la
testimonianza d' un autore del secolo sesto possa tornar gradita al
romanista, di Prisciano, vissuto in Costantinopoli e più che molti
altri grammatici latini esposto all' influsso della scuola greca, sarà
bene non fidarsi.1 La divisione delle consonanti in tenui, tenui
aspirate e in una classe intermedia rispetto all' aspirazione che
1 Cfr. sulla dipendenza di Piisciano dai grammatici greci: Steinthal,
Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern, 3a ed.
Berlino 1891, II, 188, 199. Circa l'influsso della classificazione greca delle mute
sui grammatici latini in generale cfr. anche: O. Froehde, Die Anfangsgründe
der röm. Gramm. 96 seg.
I*
4
appunto da questa circostanza deriva il nome di 'medie' è notoria-
mente d' origine greca. In modo eguale a Prisciano s' esprimono
p.e. gli scoliasti di Dionisio (Gramm. Graeci 111, 50312seg, Scholia
Londinensia): UóQ-ev óh órjlov ori rò ß (lioov èorì rov x xal <p,
rò óe y rov x xal x, rò de ó fièaov rov 9- xal r e Scholia Mar-
ciana, Gramm. Graeci III, 32i)7scg con maggior ricchezza di dettagli:
TI lari ¿¿Ira; 2vp(pa>vov àtpcovov /JtOov rov fr xal r. Ilòti-tv
tlgijrai óéjLra; Àxò rov óiaQxióv ri tlvai, 7/yovv rò firj òv èXhjteq
rq èytaQOa, loóxitvQov yÒQ, ov ovx à<patQOV(jt&ó ri rwv
locov, Iva loa yivrjrai, ènei ovrcoq $rv%sv èx rfjq xax'àQyjjv
èxrvjtcÓ0£a>$. Rinunciamo quindi per prudenza all' affermazione
di Prisciano e ritorniamo alle descrizioni di Terenziano Mauro e
Mario Vittorino.
2. Da queste E. Seelmann deriva una ricostruzione che non
credo del tutto esatta e che porto, perchè intraducibile, nella lingua
originale: D und / sind danach Klapplau te und zwar d eine
explosiv-plosiv, bezw. implosiv-plosiv stimmhafte dorsal-
gebildete rein dentale Lenis, /, bei dessen Bildung in-
folge des stärkeren artikulatorischen Druckes seitens der
Zunge der wulstige Vorderrücken derselben Oberzähne
und -Zahnfleisch gleichmäfsig berührt, die entsprechende
explosiv bezw. implosiv auftretende dorsal gebildete
dentigingivale Fortis.
Lasciamo correre la differenza fra la pronuncia implosivo-
o esplosivo-plosiva, che dovrebbe caratterizzare la media, e 1' es-
plosiva od implosiva, che caratterizza la tenue; ciò può essere, ma
non costituisce che una delle possibilità, e, nè la testimonianza di
Terenziano, nè in generale il materiale raccolto con tanta diligenza
dal Seelmann ci permettono di giungere a tal conclusione. Accettiamo
invece, quantunque il grammatico latino non vi accenni diretta-
mente, la supposizione che il d rappresenti (perlomeno in posizione
intervocale) la Iene per riguardo ai risultati romanzi; a una
differenza dell' energia d' articolazione fra la tenue e la media
accenna del resto nell' ordine delle gutturali Aftonio: c etiam et
g . . . nisuque dissentiunt . . . g vim prioris (c) pari linguac
habitu palatu suggerens lettius reddit. E accettiamo infine,
almeno per la tenue, anche 1' osservazione del Seelmann che in
questi suoni la chiusura orale venga realmente esplosa, non sciolta
gradatamente attraverso la stretta orale, quantunque circostanze che
verranno addotte al § 24 possano far sorgere dei dubbi: il sonilum
pelle re di Terenziano (K. VI, 193) rispetto all' articolazione del p che
si collega all' exploso e mediis labris sono di Aftonio (K. VI33) e al p
labris spirito erumpit di Marziano Capella III, 201 (= K. Suppl. 308),
dimostrano cosa pensassero i grammatici latini almeno rispetto allo
scioglimento dell' articolazione labiale, di più facile constatazione
della dentale e gutturale. Ma ha torto, a mio credere, il Seelmanu