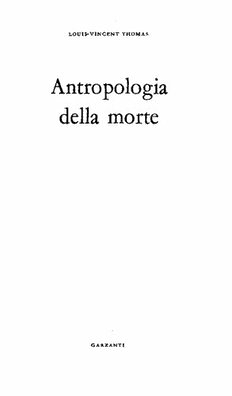Table Of ContentLOUIS-VINCENT THOMAS
Antropologia
della morte
GARZANTI
Traduzione dal francese di
Arnaldo Rressana, Renata Molinari e Donella Piccioli
a cura di Mario Spinella
Prima edizione; novembre 1976
Titolo originale dell’opera ;
« Anthropologie de la mort »
© Payot, Paris 1975
© Aldo Garzanti Editore, 1976
Printed in Italy
INTRODUZIONE
Perché un libro sulla morte?
Vi sono almeno tre ragioni, anzi tre gruppi di ragioni, a
favore di una simile scelta.
In primo luogo la morte continua ad essere, per eccellenza,
l’avvenimento più universale e irrefutabile: la sola cosa di cui
siamo veramente sicuri, anche se ne ignoriamo il giorno e l'ora,
il perché e il come, è che si deve morire, Da questo punto di
vista la morte appare più radicale della vita: il numero dei
vivi rappresenta infatti, potenzialmente, solo una minima per
centuale di quanti avrebbero potuto nascere, ma la morte col
pisce ogni uomo senza eccezioni, tanto è vero che l'essere uma
no, come sottolineava Heidegger, è un essere-per-la-morte. Vita
e morte sono antinomiche, eppure si dimostrano stranamente
indissociabili l’una dall'altra: il bimbo che nasce porta in sé
una promessa di morte, è già un-morto-in-potenia; ma chi
muore ha la speranza di sopravvivere nella memoria di chi
resta e, quando ne abbia, di perpetuarsi parzialmente nel pa
trimonio genetico dei discendenti. Bisogna dunque affermare
la necessità della morie: e forse la scienza moderna sta risco
prendo ciò che è sempre stato sostenuto dalle civiltà arcaiche.
La morte, per il biologo, è ciò che consente quotidianamente
la sopravvivenza della specie (se il grano non muore, aggiun
ge il poeta...) e ne assicura, con il rinnovamento, le possibilità
di mutazione.
In secondo luogo, troppo spesso l'uomo d'oggi assume —- nei
confronti di quella che Paolo definiva « la regina dei terrori *
— una posizione equivoca, una curiosa mescolanza di fuga e
negatività. Già Bossuet, nel suo sermone sulla morte del 1666,
sottolineava: « È una singolare debolezza dello spirito umano
il fatto che la morte non gli sia mai presente, per quanto gli
si metta in mostra da ogni parte e in mille modi... I mortali
si preoccupano di seppellire il pensiero della morte con la
5
stessa cura con cui sotterrano i morti. * Ed è un fatto che se
ritorno d’oggi sembra sul punto di superare, non certo senza
traumi, ì tabù del sesso {benché la repressione sessuale, in
Occidente, rimanga spesso fin troppo evidente) si trova strana
mente bloccato davanti al tabù della morte. Parlare della
morte, si dice, è segno d’uno « stato d’animo morboso, confi
nante con il macabro D'altra parte la ricerca del macabro
si può definire, sotto molti aspetti, come un comportamento dì
fuga, come un rifiuto travestito in forma tragicomica.1 2 « Il
pubblico, generalmente, quando gli si parla della morte si
aspetta due cose: 1°) di sottrarsi alla noia mediante una forte
sensazione; 2") di trovarsi reinstallato, subitO'dopo, nella sua
poltrona ( relax > per mezzo di un finale rassicurante. Tra lo
scrittore e la società esiste una tacita intesa: < Conto su di te,
dice la società, affinché tu mi fornisca degli strumenti con cui
utilizzare, dimenticare, ritardare, mascherare o trascendere la
morte. Ti ha assunto per questo. Se non eseguirai il tuo com
pito, sarai licenziato (cioè ‘non sarai più letto’) >. »3 4 II modo
più maldestro di negare la morte, probabilmente, è di vederla
come una pura potenza negatrice, di ridurla a una pura e sem
plice distruzione della vita: la morte muta la presenza in as
senza facendo dell’essere un non-essere o, al più, un labile ri
cordo. In breve, come diceva cosi bene V. Jankélevitch, « mo
rire non significa diventare altro, ma diventare nulla o — il
che è lo stesso — diventare assolutamente altro, dato che, se il
relativamente altro è ancora un modo d’essere, l’assolutamcn-
te altro, che è la contraddizione del medesimo, si comporta
nei suoi confronti come il non essere in rapporto all'essere •*
Non ci si stupisca che un simile modo di vedere, nonostante la
prospettiva rassicurante o consolante delle religioni monoteì-
ste, limiti la morte aWat/venimento-che-mette fine-alla-vita. In
tesa cosi, la morte occupa nel pensiero occidentale una posizio
ne ambigua: le si accorda troppo perché, si dice, essa annienta
1 H. Rebou). Le diseours du vietlard sur tu mori, « L’in format ion psy-
chologique », 44, 4° trimestre 1971, p, 75.
2 b il caso di P. I.éautaud che confida a R. Mail et che gli sarebbe pia
ciuto riposarsi sopra la tomba della sua amante per «pensare a ciò che capi
tava lì sotto»: o di Baudelaire che canta la putrefazione del cadavere:
« Alors ò ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, » 6
anche il caso dì J- Ensor il cui celebre quadro * Autoritratto nel 1960 * rap
presenta uno scheletro vestito.
3 A. Fabrc-Luce, La mort a changé, Gallimard 1966, p. 12,
4 V. Jankilevitch, Pkilosophie première, 1954, pp. 55-56.
6
l’essere; non le si dà abbastanza perché la si riduce ad un avvé
niménto momentaneo; e vedremo più avanti che, per luomo
moderno, i morti non sì trovano mai al loro posto e ossessiona
no l'inconscio dei sopravvissuti che si sforzano di scordarli. Ma
il rifiuto del dialogo rende i defunti più crudeli, e soprattutto
più presenti. Per un curioso paradosso ci si potrebbe chiedere
se l'uomo occidentale non tema la morte perché si rifiuta di
credere nell’onnipotenza della vita. Invece il Negro-africano
— del quale sono noti il modo ricco e originale e il fervore
con cui esalta la vita — minimizza la portata della morte fa
cendone un immaginario che interrompe provvisoriamente re
sistenza del singolo e risparmia, trasformandola in un avveni
mento che riguarda solo l'apparenza dell’individuo, la specie
sodale (credenze nell’onnipotenza degli antenati, conservazio
ne del Totem del clan grazie alla reincarnazione...): il che gli
consente non solo di accettarla ed assumerla, anzi di ordinarla
— secondo la definizione di Jaulin — integrandola nel pro
prio sistema culturale (concetti, valori, riti e credenze), ma
anche di includerla ovunque (che è il metodo migliore per do
minarla), di scimmiottarla ritualmente nell'iniziazione e di
trascenderla grazie a un gioco appropriato e complesso di sìm
boli. In breve, il Negro non ignora la morte; al contrario, la
afferma smisuratamente (abbiamo appena detto che ìa inclu
de ovunque). Presso di luì, e per lui, « la morte è la vita che
perde, che è stata giocata male. La vita è la morte domata
a livello sociale prima ancora che a quello biologico E in
realtà, se si osservano i miti, le credenze, i fantasmi e l'attività
creatrice degli uomini di ieri e di oggi, ci si accorge presto
del ruolo privilegiato riservato alla morte, ruolo in cui si
esprime la positività di quella che è considerata come l’eterna
e spietata distruttrice: un’opera recente non ha forse indicato
come categorie estetiche fondamentali della morte l’evasivo,
il crepuscolare, il funebre, il lugubre, l’insolito mentre il fan
tastico, il meraviglioso, il demoniaco, l’mfernaie, l’apocalittico,
il macabro, il diabolico sarebbero le categorie dell’aldilà? *
Al tempo stesso, la vita moderna porta in sé un certo numero
d’elementi (credenze, tecniche, atteggiamenti) che obbligano
l’uomo d’oggi a rivedere alcuni punti di vista secolari a pro
posito della morte. Le guerre non sono mai state così micidiali
5 R. jaulin, La mort tara, Plon 1967, p, 6*.
6 M. Guiomar Principe* d'unt etthétique d* t<i mori, J. Corti 1967.
7
né le minacce di polluzione o di inquinamento nucleare tanto
drammatiche, né la corsa agli armamenti è mai stata più one
rosa e pericolosa che ai giorni nostri, in cui lo stesso disprezzo
dell'uomo per l'uomo si fa sempre più evidente (ecocidio, ge
nocidio ed etnocidio; recrudescenza della criminalità, degli
infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali; intensificazione
dello sfruttamento capitalistico che, ossessionato dalla riduzio
ne dei margini di profitto, arriva a commercializzare persino la
morte...). Inoltre, per motivi che hanno poco a che vedere
con ragioni di carattere economico, all’uomo è tolta la sua
stessa morte: muore da solo, all’ospizio o all’ospedale, senza
preparazione (esistono manuali di comportamento sessuale ma
non sull’arte del morire bene); i funerali e i riti funebri perdo
no d'importanza:7 t cadaveri sì fan mi sempre più ingombranti
e ì cimiteri pongono agli urbanisti problemi sempre più com
plessi. Da parte sua lo scienziato, sottolineando l’insufficienza
delle tradizionali prove del decesso (arresto cardiaco e della
respirazione), suggerisce di completarle con la constatazione
dell’assenza totale di attività cerebrale che — verificata da un
tracciato piatto dell’elettroencefalogramma — dimostri una
assoluta mancanza di un qualsiasi tipo di riflesso per un pe
riodo di tempo * adeguato a, Che pensare allora della defini
zione cristiana secondo cui la morte è la separazione dell’anima
dal corpo? E come interpretare, se non in termini simbolici,
la sentenza dell’Ecclesiaste (xn, 7): « Che la polvere ritorni al
la terra da cui era stata presa e che lo Spirito ritorni a Dio
che l’aveva dato *? Ma si stanno verificando anche altri cam
biamenti, ci si offrono nuove prospettive, abbiamo nuove spe
ranze: le pompe funebri sì trasformano in servizi tanatologi-
ci, si edificano complessi funerari (atanei), sì inserisce nei co
dici una nuova deontologia (trapianti, donazioni di organi,
traslazioni di cadaveri), i tanatotecnici limitano gli effetti
degradanti della tanatomorfosi facilitando così il lavoro sui
morti, la Chiesa abolisce le sue proibizioni relative alla cre
mazione... e si profila già, in un ipotetico avvenire, l’eventua
lità dell'ibernazione e della rianimazione.
7 A questo proposito l'evoluzione dei calendari si dimostra assai ricca
d'insegnamenti. Una volta il 2 novembre era dedicato alla Festa dei Morti;
in seguito è diventalo, più prosaicamente. Giornata dei defunti; oggi ci si
accontenta di un termine laconico come • Defunti », la cui asciuttezza fa
pensare sd un ordine nuovo.
8
Per un'antropotanatologia
I problemi della morte riguardano, a vario titolo, personag
gi molto diversi tra loro, come: il teologo e il filosofo, lo psi
cologo, lo psicanalista e lo psichiatra; il biologo e il biochi
mico; il demografo e il sociologo; il giurista, il criminologo
e l'economista; lo studioso di estetica e il critico d'arte; lo
storico e il geografo; senza trascurare il pTete, il medico {coinè
tecnico della salute e come medico legale), l’assicuratore, l’ad
detto ai servizi funebri, gli infermieri, gli urbanisti... Ognu
no considera la morte in generale — sia degli altri che la pro
pria — secondo un’ottica particolare, che gli deriva dalla sua
professione (e dunque dal suo codice deontologico), dall’ordi
ne dei suoi interessi intellettuali, dalla sua ideologia o da quel
la del gruppo cui più specificatamente appartiene. Perciò ri
schia di avere, sul nostro problema, un punto di vista parzia
le, interessante e magari originale, ma inadeguato ai fini di una
sua esauriente comprensione. Se dunque si vuole uscire, come
dice E. Morin,® dalle « geremiadi sulla morte, dal sospiro ar
dente in attesa della dolce rivelazione religiosa, dal manuale
di serena saggezza, dal saggio < patetico i, dalla meditazione
metafisica che esalta ì benefici trascendenti della morte o dal
gemito sui suoi non meno metafisici misfatti; se si vuole uscire
dal mito, dalla falsa evidenza e dal mistero fasullo, è neces
sario copernicanizzare la morte. Ciò significa impegnarsi non
già in una mera descrizione psicologica, ma in una scienza
totale che sola potrà consentirci di conoscere contemporanea
mente la morte attraverso l’uomo e l'uomo attraverso la mor
te. * E l’antropologia vuole essere appunto la scienza dell'uo
mo per eccellenza,’ quella che cerca le leggi universali del
pensiero e della società e considera le differenze spazio-tempo
rali per giustificarle, pur tentando di ridurle a modelli uni
versali e astratti, a schemi esplicativi il più possibile generali
senza trascurare, per quanto possibile, di riferirle anche al
mondo non-umano. Si tratta dunque di situare l'uomo non
solo secondo i sistemi socio-culturali che — hic et mine —- egli
si è scelto, ma di considerarlo anche come « momento » (ai
8 L'fiorume et la mori, Seuil 1970, p. 16.
9 0, più modestamente, tanto il tronco comune a tutte le scienze umane
quanto 0 meno della loro eventuale sintesi.
9
suoi occhi privilegiato) iieH’avventura universale della vita,
l/uoino, paragonato all’animale, è innanzitutto un manipola
tore /costruttore (homo faber) e — saremmo tentati di aggiun
gere — un produttore di armi che uccidono; con lui vediamo
espandersi, grazie ad un linguaggio articolato, la funzione lin
guistica (homo loquax): mai la padronanza del rapporto si
gi! ilìcante-signibeato si era spinta così lontano. Ma fin qui non
si potrebbe ancora parlare di rottura, dì soluzione di continui
tà; le differenze rispetto alluminale, benché assai rilevanti,
non sono tanto d’ordine naturale quanto piuttosto d’ordine
quantitativo. Anche Laminale, infatti, sì dimostra a volte ca
pace di intelligenza fabbricatrice e non ignora alcune tecni
che di comunicazione. Resta allora un altro tratto distintivo,
forse più pertinente; l’uomo, sì potrebbe dire, è Vanimale che
seppellisce i propri morii. Si deve parlare, al riguardo, di una
« breccia bio-antropologica » 10 che introdurrebbe un’autentica
specificità dell’uomo? L’atteggiamento di fronte alla morte
— e al cadavere — non sarebbe in definitiva quell’aspetto della
sua natura per cui l’uomo si sottrae parzialmente alla natura e
diventa animale acculturato?11 « Ciò che definiamo la cultura
di un popolo è, almeno in parte, lo sforzo eh’esso compie per
reintegrare nella propria vita collettiva la materialità del ca
davere, le ossa prive della carne che rappresenta la vita, per
scongiurarne gli effetti distruttivi: alla distruzione nichilista
della natura di cui Darwin dice che uccide più di quanto con
servi, le società rispondono-controllando la putrefazione del
supporto reale della vita, la carne. La mummia, lo scheletro,
il teschio, che ne è la più antica metafora, rappresentano me
diante il loro contrario ciò che della realtà umana non è più
visibile né palpabile, le sue credenze, i suoi valori, la sua
< cultura >. » 12
L’antropologia tauatologica deve necessariamente essere
10 1.'espressione è di E. Morin.
11 A questo proposito, si potrebbe aggiungere che tra tutti gli esseri
viventi l’uomo rappresenta la sola specie animale cui la morte è onnipre
sente durante tutta la sua vita (e sia pure solo a livello di fantasmi); la
sola specie animale che accompagna la morte con un rituale funebre com
plesso e ricco di simboli; la sola specie animale che ha potuto credere, e
spesso ancora crede, alla sopravvivenza e alla rinascita dei defunti; in breve,
la sola specie per la quale la morte biologica, fatto di natura, si trova con
tinuamente superata dalla morte come fatto di cultura.
12 f- Duvignaud, Le langage fierdu, puf 1973, pp. 275-27S.
XO
comparativa, poiché cerca l’unità dell’uomo nella differenza o,
meglio, ne costruisce l’universalità a partire dagli scarti. Da
qui la necessità dei confronti. A questo scopo avremmo potuto
scegliere fra tre possibilità. Mettere a confronto il rurale (ar
caico) e l’urbano: ma così si correva il rischio di non andare
troppo lontano, tanto più che è in corso un'urbanizzazione ac
celerata delle campagne. Confrontare, per l’Occidente, un pe
riodo storico del passato con quello contemporaneo e utiliz
zare una serie di studi preziosi (M. Vovelle, Piétè baroque et
déchrislianisation en Provence au X VIIP siècle: F, Lebrun,
Les hommes et la mori en Anjou aux XVIP siècle et XVI1P
siècle) ma numericamente insufficienti 11 e troppo poco diver
sificati rispetto alle epoche e alle zone geografiche considerate.
Restava una terza possibilità, quella che abbiamo scelto: apri
re un confronto tra una società arcaica contemporanea sulla
quale siamo adeguatamente informati (nel nostro caso il mon
do tradizionale 13 14 negro-africano) e la società industriale, mec
canizzata, produttivistica (la nostra). Un tale procedimento ha
ovviamente un mero valore esemplificativo e non consente ge
neralizzazioni, ma permette di porre in risalto tutta una serie
di differenziazioni assai note a livello di credenze, atteggia
menti e riti, sia sul piano degli individui che su quello delle
collettività. Ma al di là delle differenziazioni spazio-temporali
13 M. Vovelle, Mourir autrejois, Gallimard-Juillard 1974, distingue a ra
gione la morte subita, che ha attinenza con la demografia, la morte vìssuta,
che fa parte della sfera dell'esperienza individuale, e il discorso sulla morte,
che costituisce un documento storico, rivelatore della mentalità di un'epoca.
14 Non si deve fraintendere il senso della parola « tradizionale ». In
nessun caso essa sta a indicare l'idea di purezza, d'autenticità, di speci
ficità, colte « ne varietur », al di fuori dei condizionamenti socio-storici.
Con « tradizionale » si intende l’insieme delle pratiche che nel corso di una
data epoca, abbastanza lontana e prolungata nel tempo, si sono radicate al
punto da diventare, oggi, abitudini o addirittura automatismi che, di conse
guenza, non si mettono più minimamente in questione; si è prodotto attual
mente uno slittamento semantico del termine « tradizionale »: esso comincia
a venire considerato in quanto tale solo a partire dal momento in cui pra
tiche fin qui convenzionali si dimostrano inadatte o non funzionali in rap
porto all'adozione di un genere di vita relativamente nuovo, causata sia dal
contatto di altre culture con tecniche più avanzate (condizioni esterne) che
da trasformazioni interne di tipo qualitativo o dalla combinazione di en
trambi i fattori. Cosi alcuni aspetti della cultura di partenza, per la loro
inadeguatezza rispetto a pratiche nuove, diventano dei settori tradizionali,
che talvolta in un tempo più o meno breve deperiscono e cadono a livello
di folclore. Ora, le civiltà » tradizionali » negro-africane, nonostante l'im
patto coloniale, hanno conservato — in particolare nell'ambiente rurale —
una sorprendente vitalità.
II
è possibile riscontrare anche una serie di costanti in comune.
Cosi, per esempio, l'orrore per il cadavere in decomposizione
{mascherato ai giorni nostri dal pretesto dell’igiene); l’asso
ciazione tra la morte e [‘iniziazione (soprattutto in caso di
guerra); il prestigio accordato alla morte-feconda (rischiare
la propria vita o dare il proprio sangue per la patria, per la
fede, per un ideale politico); la persistenza delle credenze nel
la morte-resurrezione (ruomo sopravvìve a se stesso per mezzo
dell'eredità cromosomica; si preoccupa di trasmettere il pro
prio nome; spera nell’aldilà, se è credente); l'importanza ac
cordata alla morte-madre (amore per la Terra-madre in cui
si spera dì venire sepolti : « La terra, » scrive E. Morin,15 « vie
ne dunque maternizzata da un lato come sede delle meta
morfosi di morte-nascita e dall’altro come terra natale »); il
ruolo della morte nella vita economica (mestieri attinenti alla
morte) o nell’arte funeraria (la morte nell’arte e l’arte nella
morte); le relazioni tra i morti e ì vivi (l’occultismo e lo Spi
ritismo, la credenza nell’immortalità dell’anima, la comme
morazione annuale dei defunti, il culto dei santi come sosti
tuto del culto degli antenati...) sono altrettante sopravvivenze
« primitive » — nonostante i cambiamenti dovuti alle diffe
renti condizioni di vita — presemi nella civiltà contempora
nea (a meno che non vi si debbano vedere, con C. C. Jung,
archetipi universali o infrastrutture permanenti dell’inconscio
collettivo). Si possono così scoprire, dietro la diversità di alcu
ni comportamenti, identiche finalità. Si prenda ancora come
esempio la tanatomorfosi. Contro le conseguenze negative del
la decomposizione « tutte le comunità umane reagiscono ten
tando di rovesciare i termini della spietata equazione; l’uso
della doppia sepoltura che incontriamo, come attesta H. Hertz,
presso numerose società umane chiede alla terra di compiere
un atto d'imputridimento che permetta di disseppellire lo
scheletro liberato dalla carne per reintegrarlo nella comunità
sotto la forma del solo simbolo, capovolto, di ciò che persiste,
cioè le ossa, la parte di terra che è in noi. Le maschere fune
rarie della Polinesia e le teste rattrappite degli Jivaros ten
dono indubbiamente allo stesso fine. E le mummie egizie,
peruviane, messicane non sono anch’esse un tentativo per de
bellare la morte? Le raffigurazioni dei morti non sono fot se,
15 E. Morin, Uhomme et la mort dans fkistnire, Seuil 1971, p. 121.
12